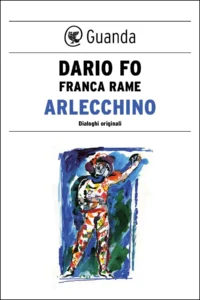1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il nostro piangere fa male al re” di Dario Fo ti porta dentro il mondo di un artista incredibile, un vero giullare moderno che ha usato il teatro, la satira e le tecniche della Commedia dell’Arte, come il grammelot, per smascherare il potere e le ingiustizie. Questo libro esplora come Dario Fo, con la sua energia e il suo talento unico, ha portato spettacoli iconici come Mistero buffo e Morte accidentale di un anarchico fuori dai luoghi tradizionali, nelle piazze e nelle fabbriche, per parlare direttamente alla gente comune. Affronta temi scottanti della storia e della società italiana, dai misteri d’Italia come la strage di piazza Fontana e la morte di Pinelli, alla critica feroce della Chiesa, dello sfruttamento e dell’ipocrisia borghese, sempre con un impegno politico fortissimo che gli è costato censure e ostilità dall’establishment, ma che alla fine gli è valso il prestigioso Premio Nobel per la Letteratura. È un viaggio affascinante nell’arte e nella vita di un autore che non ha mai smesso di lottare con la sua voce fuori dal coro, dimostrando che il teatro politico e la satira possono davvero fare rumore e disturbare chi sta in alto, lasciando un’eredità importante nel teatro di narrazione e civile.Riassunto Breve
Dario Fo è un artista poliedrico che usa il teatro, la scrittura, la recitazione e la musica per intervenire nella società. Il suo lavoro si basa sulle tradizioni popolari, come la Commedia dell’Arte e la figura del giullare, e utilizza tecniche come il grammelot per comunicare in modo diretto. L’arte di Fo è sempre legata al contesto storico e politico, prendendo posizione contro le ingiustizie e portando il teatro fuori dai luoghi tradizionali, in piazze e fabbriche, per raggiungere un pubblico vasto. Questa scelta gli causa spesso problemi, inclusa la censura, come accade con la RAI negli anni Sessanta dopo sketch satirici su temi sociali e sul lavoro. Nonostante le opposizioni, Fo continua a denunciare il potere e le sue ipocrisie. Spettacoli come “Ci ragiono e canto” recuperano i canti popolari per raccontare la vita e le lotte delle classi subalterne, affrontando temi come lo sfruttamento e l’emigrazione. “Mistero buffo” rielabora testi antichi e religiosi con ironia per criticare le istituzioni e le ingiustizie ricorrenti nella storia. Opere come “Morte accidentale di un anarchico” affrontano direttamente i misteri italiani e la strategia della tensione, usando la satira per smascherare le versioni ufficiali dei fatti e criticare polizia e stampa. Altri lavori, come “Isabella, tre caravelle e un cacciaballe” o “Guerra di popolo in Cile”, usano eventi storici o internazionali per denunciare l’oppressione e l’uso strumentale della religione o la violenza dei regimi. La sua scrittura teatrale, che attinge alle forme orali, è considerata letteratura e gli vale il Premio Nobel nel 1997, riconoscendo il valore di un’arte che denuncia e stimola la coscienza critica. L’eredità di Fo si vede in artisti successivi che continuano il teatro civile e di narrazione, mantenendo l’impegno a usare l’arte per dire la verità e criticare il potere, anche se trovare spazio nei media di massa e affrontare la satira politica rimane una sfida in una società complessa.Riassunto Lungo
1. Il Giullare e la Scena del Mondo
Dario Fo è una figura centrale nella cultura, noto per il suo lavoro come attore, regista, scrittore, pittore e musicista. Il suo talento si esprime attraverso la mimica, l’uso della voce e una regia innovativa. Ha scritto canzoni popolari e opere teatrali che gli sono valse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. La sua arte è strettamente connessa al periodo storico e sociale in cui vive, spesso riprendendo schemi della Commedia dell’Arte. Questo suo approccio genera sia grande apprezzamento che forti polemiche.Le Origini e i Primi Passi
Fin da bambino, Dario Fo è profondamente influenzato dalle storie popolari e dal teatro di piazza che incontra. Questa esperienza sviluppa in lui l’idea di un teatro destinato direttamente alla gente comune. Dopo gli studi, inizia la sua carriera creando farse e monologhi satirici. Tra questi, il programma radiofonico “Poer Nano” riscuote successo ma, a causa dei contenuti, viene spesso censurato. Questo problema di censura lo accompagnerà, in varie forme, per tutta la sua lunga carriera.L’Impegno Politico e Sociale
Dario Fo prende una posizione politica chiara e decisa, schierandosi contro il fascismo e impegnandosi a diffondere la cultura tra le persone comuni. Porta il teatro fuori dalle sale tradizionali, organizzando spettacoli in piazze e centri culturali. Questa scelta gli crea non pochi ostacoli, come il divieto di entrare negli Stati Uniti. Il suo lavoro artistico riflette profondamente il periodo storico intenso che vive, in particolare gli anni Sessanta e Settanta. L’impegno politico di Fo si nutre di una costante ricerca storica sulle ingiustizie sociali che si ripetono nel tempo.Il Teatro con Franca Rame
Un momento cruciale nella sua vita e carriera è l’incontro con Franca Rame. Insieme, fondano una loro compagnia teatrale. Attraverso spettacoli come “Il dito nell’occhio”, “I sani da legare”, “Ladri, manichini e donne nude”, “Comica finale”, “Gli arcangeli non giocano a flipper” e “Chi ruba un piede è fortunato in amore”, Fo esprime la sua satira sociale e politica. Nelle sue opere usa tecniche come la commedia degli equivoci e inserisce spesso canzoni. La sua arte riprende elementi della Commedia dell’Arte e si basa sull’uso del gesto e del grammelot, una particolare tecnica vocale che comunica attraverso suoni e ritmi, non parole compiute. Per questo uso del gesto e della satira, viene spesso paragonato a Charlie Chaplin. Le sue diverse capacità artistiche, dal teatro alla pittura, sono strettamente collegate tra loro e al suo messaggio.Censura e Riconoscimenti
Durante tutta la sua carriera, Dario Fo incontra continua censura e forte opposizione a causa delle sue posizioni e dei temi trattati. Nonostante ciò, mantiene salda la sua visione e diventa portavoce di importanti questioni sociali, generando dibattiti e divisioni nel pubblico e nella critica. Nonostante queste difficoltà, Fo prosegue con determinazione il suo percorso artistico e politico, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, che consacra il valore universale della sua opera.Se l’arte di Dario Fo generava “forti polemiche” e “continua censura”, perché il capitolo non spiega quali fossero, nel concreto, queste polemiche e censure?
Il capitolo sottolinea più volte come l’opera di Fo fosse oggetto di “forti polemiche” e “continua censura”, ma non specifica quali fossero i temi o i momenti concreti che hanno scatenato tali reazioni. Questa generalizzazione lascia nell’ombra un aspetto fondamentale della sua carriera: la natura specifica dello scontro tra la sua satira e il potere o l’establishment culturale. Per comprendere meglio questa dinamica, è essenziale approfondire la storia della censura in Italia nel secondo dopoguerra e leggere analisi critiche del suo teatro che documentino episodi specifici e le ragioni sottostanti le opposizioni. Approfondire autori che hanno studiato il teatro politico o la figura di Fo, come Oliviero Ponte di Pino, o leggere scritti e memorie di Franca Rame, può fornire il contesto necessario.2. La voce del popolo sul palco
La partecipazione di Dario Fo e Franca Rame a Canzonissima nel 1962 includeva sketch satirici che toccavano temi sociali e il cosiddetto miracolo economico, argomenti considerati scomodi all’epoca. Uno sketch in particolare, che trattava la sicurezza sul lavoro, portò alla censura da parte della RAI e alla decisione della coppia di abbandonare il programma. Questo evento, pur causando l’esclusione di Fo dalla televisione fino al 1977, contribuì ad aumentare la sua popolarità.Il ritorno al teatro e la ricerca popolare
Negli anni Sessanta, il teatro occupava uno spazio importante nel palinsesto televisivo italiano. Dario Fo tornò sulla scena con lo spettacolo “Ci ragiono e canto”, rappresentato più volte tra il 1966 e il 1973, e che approdò anche in televisione nel 1977. Questo spettacolo nacque da un’approfondita ricerca sui canti popolari e dialettali di tutta Italia, un lavoro che coinvolse la collaborazione di importanti musicisti e ricercatori come Giovanna Marini e il gruppo del Nuovo Canzoniere Italiano. La ricerca mirava a riscoprire e valorizzare le espressioni culturali autentiche delle classi popolari.Temi e rappresentazione della vita popolare
“Ci ragiono e canto” utilizzava i canti raccolti in diverse regioni italiane per raccontare la vita quotidiana, il lavoro, le difficoltà e le lotte delle classi popolari, siano essi contadini o operai. Attraverso queste canzoni, spesso cantate in dialetto o con un misto di dialetto e italiano, venivano affrontati temi come lo sfruttamento nei campi e nelle fabbriche, l’emigrazione verso le città del Nord o l’estero, le dure condizioni di lavoro e le rivendicazioni operaie. Molti brani avevano un tono satirico o di denuncia sociale. La messa in scena era volutamente semplice, con costumi che ricordavano il mondo contadino e l’uso di gesti che mimavano le attività lavorative, rendendo lo spettacolo accessibile e immediato.Le storie raccontate dalle canzoni
Tra i brani presentati, alcuni descrivevano la fatica estenuante del lavoro nei campi sotto il sole, o narravano i lunghi e difficili viaggi degli emigranti che lasciavano le loro terre in cerca di fortuna altrove. Altri canti dipingevano la realtà delle fabbriche, con i pericoli e le ingiustizie subite dagli operai, e le loro lotte per condizioni migliori. Non mancavano poi i canti che rievocavano le esperienze di soldati e partigiani durante le guerre, portando sul palco le voci di chi aveva vissuto quei momenti drammatici. Lo spettacolo includeva anche brani più intimi, come ninne nanne o canzoni d’amore, ma sempre radicati nella cultura e nella sensibilità popolare.“Ho visto un re”: Satira e critica sociale
Un esempio significativo è la canzone “Ho visto un re”, composta appositamente per la versione dello spettacolo del 1969. Questo brano è un potente esempio di satira politica e religiosa. Utilizzando un linguaggio che ricorda le fiabe, la canzone critica in modo pungente il potere costituito e l’oppressione, mostrando come i problemi e le sofferenze delle classi subalterne siano un filo conduttore che attraversa la storia. L’approccio complessivo di Fo, che mescola la ricerca sulla cultura popolare, l’arte teatrale e una forte critica sociale, presenta chiari punti di contatto con il lavoro del drammaturgo tedesco Bertolt Brecht.Il capitolo non rischia forse di idealizzare la “voce del popolo”, trascurando la complessa mediazione artistica?
Il capitolo descrive con dovizia la ricerca sui canti popolari alla base dello spettacolo, ma non approfondisce sufficientemente il processo di trasformazione di questo materiale autentico in opera teatrale. Questo lascia aperta la questione di quanto la “voce” che arriva sul palco sia effettivamente quella “del popolo” e quanto invece sia filtrata e reinterpretata dalla sensibilità e dagli intenti degli artisti. Per comprendere meglio questa dinamica, sarebbe utile esplorare gli studi sulla cultura popolare, l’antropologia teatrale e la sociologia dell’arte, magari confrontandosi con le analisi di autori che hanno indagato il rapporto tra intellettuali e classi subalterne, o che hanno criticato le rappresentazioni artistiche della vita popolare.3. Il Giullare che Smaschera la Storia
Dario Fo ha creato un suo modo di fare teatro, ispirandosi alla figura del giullare del Medioevo e alle tecniche della Commedia dell’Arte. Per farsi capire da tutti, anche superando le differenze di lingua, ha inventato il grammelot, un linguaggio fatto di suoni e parole che ricordano diversi dialetti. Questo stile si vede in modo completo nello spettacolo Mistero buffo. In quest’opera, Fo rielabora racconti antichi, sia religiosi che storici, spesso prendendoli da testi meno noti o da leggende popolari. Il suo scopo è commentare la vita delle persone e criticare chi ha il potere. Storie famose della Bibbia, come le Nozze di Cana o la Resurrezione di Lazzaro, vengono presentate con ironia, mostrando un Gesù più vicino alle persone comuni e personaggi strani o emarginati. Anche figure storiche importanti, come il Papa Bonifacio VIII, vengono prese in giro per far vedere l’ipocrisia e la corruzione delle istituzioni, soprattutto la Chiesa, vista come uno strumento nelle mani dei potenti.I Temi e lo Spettacolo
Argomenti importanti come l’arrivo di persone da altri paesi, lo sfruttamento di chi lavora (mostrato attraverso la figura del “villano”), le ingiustizie nella società e il divieto di parlare liberamente (la censura) vengono raccontati usando storie ambientate nel passato per farci pensare al presente. Lo spettacolo non si tiene nei teatri tradizionali, ma in luoghi diversi, come piazze o fabbriche, per eliminare la distanza tra chi recita e il pubblico. Dario Fo, vestito in modo semplice, usa solo la sua voce, i suoi gesti e il suo modo di parlare per dare vita ai personaggi e alle scene. Questa scelta dimostra che Fo vuole allontanarsi dal teatro per ricchi e portare la cultura a un pubblico più vasto e popolare. La sua critica sociale e politica riguarda anche i sistemi di oggi, come il capitalismo e il comunismo dell’Unione Sovietica, e questo gli ha causato reazioni da molte parti diverse.Ma quale teoria teatrale o politica spiega come l’uso di forme popolari come la farsa o la tradizione del giullare renda il teatro di Fo intrinsecamente ‘sovversivo’?
Il capitolo, pur descrivendo l’uso di forme popolari da parte di Fo e affermandone il valore ‘sovversivo’, non offre una spiegazione teorica solida su come queste forme specifiche (come la farsa o la tradizione del giullare) operino concretamente per smascherare il potere e stimolare la coscienza critica. Per comprendere meglio questo meccanismo, sarebbe fondamentale approfondire la teoria del teatro politico, ad esempio leggendo autori come Brecht, ed esplorare gli studi sul rapporto tra cultura popolare, satira e resistenza, come quelli di Bakhtin o di critici teatrali specifici che hanno analizzato l’opera di Fo da queste prospettive.6. La voce fuori dal coro
L’eredità artistica lasciata da Dario Fo si ritrova in artisti come Paolo Rossi, Marco Paolini e Marco Baliani, che portano avanti l’esperienza del teatro civile e di narrazione. Fo ha trasmesso a questi artisti l’importanza di trarre ispirazione dalla realtà e di concentrarsi su aspetti universali dell’esistenza umana. Tra questi, Marco Paolini è noto per i suoi spettacoli narrativi come Vajont e Il sergente. Marco Baliani, considerato da alcuni un pioniere del teatro di narrazione, ha creato opere significative come Kohlhaas e Pinocchio nero.Nuove generazioni e stile
Ascanio Celestini rappresenta una figura importante nella seconda generazione del teatro civile. Il suo lavoro si distingue per la capacità di mescolare ironia e impegno, curando attentamente il linguaggio, la memoria e la poesia. Come Fo, Celestini trae spunto da eventi storici e temi attuali, fondendo realtà e finzione con uno stile che risulta semplice e diretto.Dario Fo e il teatro tradizionale
Dario Fo rimane un punto di riferimento fondamentale per chi si dedica al teatro, in particolare per la sua scrittura diretta e capace di arrivare a tutti. Il suo approccio ha contribuito a rendere il teatro italiano più aperto e comunicativo. Nonostante abbia ricevuto riconoscimenti internazionali, incluso il Premio Nobel, Fo non è sempre stato pienamente apprezzato negli ambienti teatrali più tradizionali. Questo si deve in parte alla sua natura “non borghese”, che si pone in contrasto con la cultura dominante in certi circuiti. Tuttavia, aprendo il teatro a un pubblico più ampio, ha influenzato anche autori con stili più convenzionali. Portare il teatro fuori dai luoghi classici non è l’unico elemento distintivo; è soprattutto il linguaggio utilizzato a fare la differenza. Artisti come Fo e Giovanna Marini mantengono il loro stile unico ovunque si esibiscano. Al contrario, figure come Carmelo Bene, pur essendo geniali, operano spesso all’interno di un contesto culturale più legato alla borghesia, mentre Fo è stato frequentemente osteggiato da questo stesso ambiente.Teatro, letteratura e contesto culturale
La scrittura per il teatro è una forma di letteratura a pieno titolo, profondamente legata alle tradizioni orali come le fiabe e i testi antichi. Non è un testo incompleto che necessita della rappresentazione per acquisire valore. Nel contesto culturale attuale, la musica popolare, ad esempio, appare spesso superficiale, concentrata quasi esclusivamente sulle relazioni interpersonali e subordinata alle logiche del consumo, trasformandosi in un prodotto privo di profondità. Questa tendenza riflette una società che viene mantenuta in una condizione di perenne adolescenza, più facile da controllare. Di conseguenza, per la musica o il teatro che mirano a un impegno sociale o politico, diventa difficile trovare spazio nei media di massa, che tendono a privilegiare contenuti semplici e immediatamente fruibili.Le sfide del teatro politico
Utilizzare il teatro come strumento di intervento politico, come ha fatto Fo, genera inevitabilmente reazioni e conflitti. La satira politica, in particolare, continua a suscitare proteste, specialmente quando tocca temi delicati come la religione o eventi specifici, potendo portare a censure o minacce. La sfida oggi è individuare voci capaci di esprimere la verità e criticare il potere in un mondo in cui il “bersaglio” della critica è meno definito e la società sembra mostrare una minore capacità di reazione.È davvero così semplice liquidare la musica popolare come un mero strumento di controllo sociale e consumo superficiale?
Il capitolo, pur offrendo spunti interessanti sul teatro, presenta una visione piuttosto unidimensionale della musica popolare, definendola quasi esclusivamente come superficiale e legata alle logiche del consumo. Questa generalizzazione rischia di trascurare la vasta gamma di generazioni, generi e artisti che compongono il panorama musicale, molti dei quali affrontano temi complessi e mantengono una forte carica espressiva e critica. Per approfondire il rapporto tra arte, società e industria culturale, superando le semplificazioni, sarebbe utile esplorare studi di sociologia della musica e della cultura, analizzando le diverse funzioni sociali ed estetiche che la musica può assumere. Autori come Adorno, Benjamin o De Benedetti possono offrire prospettive più articolate su questi temi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]