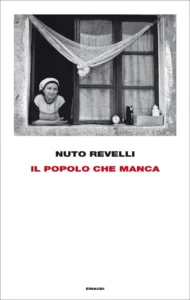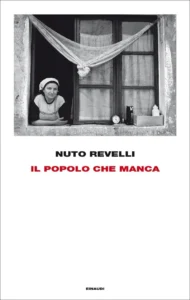Contenuti del libro
Informazioni
“Il mondo dei vinti. Testimonianze di vita contadina” di Nuto Revelli non è un romanzo, ma un viaggio potentissimo nelle vite di chi ha abitato il `Cuneese` rurale, le valli e le `Langhe`, tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento. Attraverso `testimonianze` dirette, il libro dipinge un quadro vivido della `povertà rurale Italia`, una `vita contadina` fatta di fatica incessante, fame, case povere e l’unica via d’uscita spesso cercata nell’`emigrazione Piemonte` verso Francia o America. Racconta l’impatto devastante delle guerre sui `contadini`, la complessità della `Resistenza contadina` e l’arrivo del Fascismo. Ma soprattutto, documenta il cambiamento epocale: l’industrializzazione che svuota le campagne, l’`abbandono della terra` e lo `spopolamento montagna`, lasciando dietro di sé un mondo di `vinti` dalla modernità. È la storia di comunità strette, credenze come le `masche`, e un legame profondo con la terra che si spezza, mostrando il prezzo del progresso e la memoria di chi è stato dimenticato.Riassunto Breve
La vita nelle campagne del Cuneese, delle Langhe e delle valli montane è caratterizzata da profonda miseria e fatica costante. Le famiglie sono numerose, possiedono poca terra, spesso frammentata, e si nutrono principalmente di polenta, patate e castagne; il pane e la carne sono lussi rari. Le condizioni abitative sono precarie, spesso si dorme nelle stalle per trovare calore, e l’igiene è scarsa, con alta mortalità infantile e ricorso a rimedi popolari. Il lavoro inizia in tenera età, anche a sei o otto anni, come servi, pastori o braccianti, con orari lunghi, paghe minime o nulle e trattamenti duri. L’istruzione è limitata. Questa povertà estrema spinge molti all’emigrazione, vista come l’unica via di fuga; si parte per la Francia, l’America (Stati Uniti, Argentina, Cile) o altre regioni italiane, affrontando viaggi difficili e trovando lavoro estenuante in miniere, campi o fabbriche, spesso in condizioni pericolose. I risparmi inviati a casa permettono a volte di comprare poca terra, che richiede ulteriore fatica. La società locale è dominata dai grandi proprietari terrieri e dalla Chiesa, che esercita un forte controllo sulla popolazione contadina, influenzando il voto e ostacolando l’emancipazione e la cooperazione. Emergono movimenti politici come il socialismo e il Partito dei Contadini, che cercano di difendere gli interessi dei lavoratori, ma incontrano l’opposizione dei proprietari, del clero e delle forze dell’ordine. Le guerre, dalla Libia ai conflitti mondiali, impongono ulteriori sacrifici; i contadini costituiscono la maggior parte dei soldati, mandati al fronte in condizioni brutali, soffrendo fame, malattie, ferite e prigionia. La guerra è spesso percepita come un massacro insensato, lontano dagli interessi della gente comune. L’avvento del fascismo porta violenza, repressione e controllo sulla vita quotidiana; non avere la tessera del partito rende difficile trovare lavoro. Durante la Resistenza, la popolazione contadina si trova tra tedeschi, fascisti repubblichini e partigiani; prevale un atteggiamento di prudenza e non schieramento aperto, dettato dalla paura delle rappresaglie e da un pragmatismo orientato alla sopravvivenza, anche se in alcune zone si fornisce aiuto ai partigiani. Accanto alle difficoltà materiali e agli eventi storici, persistono credenze popolari radicate, come la paura delle “masche” (streghe), ritenute responsabili di disgrazie, e la vita sociale si svolge nelle veglie serali nelle stalle, momenti di racconto, confronto e socialità. Nel dopoguerra, l’industrializzazione degli anni sessanta trasforma profondamente la campagna; grandi industrie attraggono la popolazione giovane dalle valli e dalle zone marginali, causando un esodo di massa e l’abbandono delle terre e dei villaggi. La vita in fabbrica offre un benessere economico maggiore rispetto al passato, ma porta allo spopolamento delle aree rurali, alla perdita delle tradizioni e a un cambiamento nei costumi e nella moralità. La montagna si svuota, restano gli anziani, le case crollano e la terra viene abbandonata, con rammarico per la perdita del legame con la terra e delle sofferenze passate che sembrano dimenticate dalle nuove generazioni.Riassunto Lungo
1. L’onda dell’industria e i vinti della terra
Negli anni sessanta, l’arrivo delle grandi industrie come Michelin e Ferrero cambia radicalmente la vita nelle campagne povere del Cuneese. Queste fabbriche attirano i giovani dalle valli, dalle Langhe e dalle aree di pianura meno ricche, spingendoli a lasciare la terra. Molti se ne vanno, e questo spostamento di massa causa l’abbandono di campi e paesi, lasciando case vuote e terreni incolti.La terra dei piccoli contadini, divisa in tanti piccoli appezzamenti e poco redditizia, non può reggere il confronto con le opportunità offerte dalle fabbriche. Per questo, molti, soprattutto i più giovani, cercano lavoro nelle nuove industrie. Diventano spesso “operai-contadini”, persone che dividono le loro giornate tra il lavoro in fabbrica e quello ridotto nei campi. Questa doppia fatica porta a grande stanchezza e rende difficile gestire bene la propria piccola fattoria.Il Ruolo della Politica
Le forze politiche, specialmente la Democrazia Cristiana con l’appoggio del clero, mantengono un forte controllo sui contadini. Usano la chiesa e varie associazioni per aiutare le persone a trovare lavoro in fabbrica. Allo stesso tempo, influenzano il voto con promesse facili e discorsi semplici, rendendo difficile per i contadini diventare più indipendenti e collaborare tra loro.Danni e Abbandono
Questa trasformazione industriale porta anche a conseguenze negative per l’ambiente. I fiumi si inquinano e le cave rovinano il paesaggio naturale. Le aree rurali più lontane e isolate diventano luoghi di povertà, dove vivono soprattutto anziani e persone lasciate ai margini dalla nuova società ricca. La vita di paese, basata sulla comunità, si sfalda, lasciando spazio all’isolamento e alla lotta quotidiana per sopravvivere.Il ruolo della Democristiana e del clero era davvero solo quello di “controllare” e “influenzare” i contadini?
Il capitolo descrive l’influenza politica sulla popolazione rurale, ma l’analisi del ruolo della Democrazia Cristiana e del clero appare piuttosto unidimensionale. Presentare queste forze unicamente come strumenti di controllo e influenza sul voto rischia di semplificare eccessivamente una realtà storica complessa. Per comprendere appieno le dinamiche di quel periodo, sarebbe utile approfondire la storia politica e sociale dell’Italia del dopoguerra, la storia delle organizzazioni cattoliche e contadine, e le specifiche politiche di sviluppo rurale (o la loro assenza). Approfondire il lavoro di storici politici e sociologi rurali può offrire una visione più articolata.2. Sopravvivenza e non-scelta nel mondo contadino
La vita contadina nel Cuneese era segnata da una profonda miseria. Le famiglie possedevano piccole porzioni di terra, spesso sparse e difficili da coltivare al meglio. Il cibo quotidiano era molto semplice: ci si nutriva principalmente di polenta, patate e castagne. Il pane era considerato un lusso, riservato a poche occasioni. Le condizioni di salute erano molto difficili, con un’alta mortalità tra i bambini. Le persone si affidavano spesso a rimedi popolari perché l’accesso a medici e ospedali era limitato e costoso.
Le donne affrontavano carichi di lavoro estremamente pesanti, sia nei campi che in casa, e spesso subivano violenza domestica. Trovavano conforto e rifugio nella chiesa. Gli uomini, invece, cercavano un po’ di sollievo e distrazione nelle osterie. L’unica vera speranza di sfuggire alla povertà era l’emigrazione, che portava le persone a cercare fortuna in Francia o nelle Americhe. Anche i bambini venivano mandati via da casa per lavorare come servi, pur di trovare un modo per sopravvivere.
Il Lavoro e l’Educazione
Il lavoro era una costante nella vita contadina, incessante e faticoso. La forza fisica era considerata una qualità fondamentale, necessaria per affrontare le dure giornate nei campi. L’analfabetismo era molto diffuso. La possibilità di frequentare la scuola dipendeva strettamente dalle necessità agricole: i bambini dovevano aiutare nei lavori, e lo studio passava in secondo piano rispetto alla sopravvivenza della famiglia.
Vita Sociale e Credenze
La vita sociale si concentrava soprattutto nelle veglie invernali. Le famiglie si riunivano nelle stalle, che erano i luoghi più caldi, per raccontare storie, confrontarsi e passare il tempo insieme. La superstizione aveva un ruolo importante nella vita di tutti i giorni, in particolare la paura delle “masche”, figure legate alla stregoneria. Questa paura era talvolta sfruttata dal clero. Il rapporto con la Chiesa e con la figura del prete variava molto: a volte il prete era un punto di riferimento positivo per la comunità, altre volte era percepito in modo negativo.
L’Impatto delle Guerre
Le guerre, a partire dalla campagna in Libia fino ai grandi conflitti mondiali, imposero ulteriori pesi sulla popolazione contadina. Gli uomini venivano costretti al servizio militare, lontani dalle loro case e dai campi. La “Patria”, l’idea astratta di nazione per cui si combatteva, era spesso un concetto lontano dalla realtà vissuta dal soldato contadino, il cui desiderio più grande era semplicemente tornare a casa. Alcuni cercavano di evitare il servizio militare con gesti estremi come l’autolesionismo o la diserzione, manifestando così il loro rifiuto per una guerra che sentivano imposta e non loro.
Tra Fascismo e Resistenza
L’arrivo del fascismo portò violenza, che inizialmente colpì le città ma si estese poi anche alle campagne. Durante il periodo della Resistenza, la popolazione contadina mostrò solidarietà verso i soldati italiani che si trovarono sbandati dopo l’8 settembre 1943, offrendo loro aiuto e rifugio. Tuttavia, l’atteggiamento verso i partigiani era più complesso. Molti contadini fornivano supporto e assistenza, ma la paura delle rappresaglie da parte delle forze tedesche e fasciste era molto forte. Questo timore diffuso portava a un desiderio prevalente di non essere coinvolti direttamente nel conflitto. La sicurezza dei giovani che cercavano di evitare la leva (i “renitenti”) dipendeva in parte dalla presenza dei gruppi partigiani. Tuttavia, le requisizioni di cibo e beni da parte di tutte le fazioni e gli scontri armati rendevano la situazione estremamente difficile e pericolosa per le popolazioni che vivevano nelle zone di conflitto, specialmente in montagna.
Ma davvero la vita contadina era solo “non-scelta”, o si trattava piuttosto di scelte difficilissime fatte in condizioni disperate?
Questa domanda sorge spontanea leggendo il capitolo, che descrive con efficacia la durezza delle condizioni, ma forse non esplora a fondo le sfumature dell’agenzia individuale e collettiva all’interno di quel contesto. Per comprendere meglio la complessità delle decisioni prese in ambienti di estrema privazione e pressione sociale, sarebbe utile approfondire gli studi di storia sociale ed economica, con particolare attenzione alle strategie di sopravvivenza e alle forme di resistenza (anche passive o quotidiane) delle classi subalterne. Autori come E.P. Thompson o James C. Scott offrono strumenti concettuali per analizzare come le persone comuni agiscano e prendano decisioni anche in assenza di libertà formale.3. Vite di fatica e scelte in campagna
La vita per le famiglie povere, i servi e gli operai è segnata da grande miseria e lavoro durissimo fin da giovani. Si lavora dall’alba a notte fonda, spesso con poco cibo, dormendo in condizioni difficili e precarie. L’emigrazione verso l’America o l’Argentina rappresenta un tentativo disperato di guadagnare qualcosa e migliorare la propria condizione, ma le condizioni di viaggio sono spesso disperate e il lavoro trovato all’estero si rivela simile a quello lasciato, altrettanto faticoso e malpagato. I risparmi ottenuti con enormi sacrifici permettono a volte di comprare poca terra, che però richiede altro lavoro estenuante per essere coltivata e dare qualche frutto.La struttura sociale e il potere dei proprietari
In questo contesto di fatica, la struttura sociale vede i grandi proprietari terrieri, come il conte Solaro, dominare completamente la vita del paese. Essi controllano la terra, fonte primaria di sostentamento, e non mostrano alcuna clemenza verso chi dipende da loro. La gente comune mostra una deferenza quasi obbligata verso il padrone, consapevole del suo potere e della propria vulnerabilità.I primi movimenti politici: il Socialismo
Parallelamente alla dura realtà quotidiana, il socialismo inizia a emergere tra gli operai e i servi di campagna, portando nuove idee di riscatto e uguaglianza. Tuttavia, queste idee non trovano un seguito significativo tra i contadini, più legati alla terra e alle tradizioni. I socialisti affrontano una forte ostilità dalla popolazione rurale, dai carabinieri e dalla chiesa, venendo spesso considerati sovversivi e pericolosi. Le manifestazioni del Primo Maggio, simbolo della lotta operaia, rimangono piccole e contrastate in questo ambiente.L’impatto della Prima Guerra Mondiale
Le guerre portano cambiamenti e sofferenze inaspettate. La Prima Guerra Mondiale, in particolare, causa grande sofferenza e fame per i soldati mandati in trincea, molti dei quali provenienti proprio dalle campagne. Tuttavia, per alcuni contadini, la guerra porta anche un inatteso beneficio economico, grazie all’aumento dei prezzi di bestiame e prodotti agricoli dovuto alla scarsità.L’era Fascista e la repressione
Dopo la guerra, il fascismo si afferma rapidamente, portando repressione e nuove difficoltà per chiunque non si allinei al regime. Non avere la tessera del partito fascista rende quasi impossibile trovare lavoro e garantisce la marginalizzazione sociale. La polizia fascista perseguita attivamente gli antifascisti con perquisizioni, arresti e l’invio al confino, cercando di soffocare ogni forma di dissenso.La Seconda Guerra Mondiale: pragmatismo e resistenza
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la campagna mostra un forte interesse economico dettato dalla necessità e dall’opportunismo. Mentre i partigiani combattono per la libertà e chiedono supporto alla popolazione, i contadini si concentrano sulla borsa nera, vendendo i prodotti agricoli a prezzi altissimi. Anche i partigiani sono costretti a pagare per il cibo, spesso usando buoni di requisizione che i contadini accettano solo a prezzi inferiori rispetto al mercato nero. La maggior parte dei contadini non supporta attivamente i partigiani, anzi, li accusa di rubare e pensa unicamente al proprio guadagno e alla propria sopravvivenza economica. Pochi figli di contadini si uniscono alla resistenza, a differenza di quanto accade tra gli operai delle città.Il dopoguerra e le nuove prospettive
Dopo la Liberazione, un clima di perdono prevale, e anche i fascisti e le spie vengono riammessi nella società senza gravi conseguenze. La campagna, sia i piccoli che i grandi proprietari terrieri, tende a orientarsi politicamente verso la Democrazia Cristiana, vista come garante dell’ordine e della proprietà. La vita di fatica continua per molti, accompagnata dal rammarico di non poter più lottare con lo stesso spirito per un futuro migliore come si era fatto in passato. La gioventù attuale, cresciuta in un contesto diverso, non sembra comprendere appieno le difficoltà affrontate dalle generazioni precedenti e l’importanza cruciale dell’impegno politico e sociale che ha caratterizzato quelle lotte.Era davvero solo “passività” o “mancanza di comprensione” l’atteggiamento dei contadini delle Langhe di fronte alla Resistenza?
Il capitolo descrive l’atteggiamento del mondo contadino verso la Resistenza come sostanzialmente passivo e privo di una piena comprensione del suo significato profondo. Questa lettura, pur cogliendo un aspetto, rischia di semplificare eccessivamente una realtà complessa. Le comunità rurali operavano in un contesto di estremo rischio, dove la priorità era spesso la sopravvivenza immediata e la protezione dei propri beni e familiari. Le loro azioni, come fornire cibo, possono essere viste non solo come passività, ma come una forma pragmatica di navigare tra le forze in conflitto, dettata da necessità più che da ideologia esplicita. Per approfondire questa dinamica e superare una visione potenzialmente riduttiva, è utile considerare gli studi di storia sociale e la storiografia sulla Resistenza che analizza il rapporto tra partigiani e popolazione civile. Autori come Claudio Pavone hanno esplorato le diverse “guerre” che si intrecciarono in quel periodo, inclusa la guerra dei contadini per la propria sopravvivenza.29. La Difficile Scelta del Contadino: Guerra e Trasformazione della Campagna
La vita nelle campagne era fin da subito segnata dalla povertà e dal duro lavoro. I bambini e i giovani partecipavano presto alle fatiche quotidiane. L’accesso all’istruzione era molto limitato, e spesso l’unica possibilità di studiare si trovava intraprendendo la carriera ecclesiastica. Le famiglie erano spesso numerose, rendendo la miseria ancora più diffusa e pesante. In questo contesto, il valore di una persona era spesso misurato in base alla sua ricchezza o ai beni posseduti.I contadini in guerra
Durante i periodi di guerra, la maggior parte dei soldati proveniva dalle campagne. I contadini erano spesso visti come ideali per il servizio militare: considerati ubbidienti, abituati alla fatica e quindi facili da gestire, quasi “carne da cannone”. La loro partecipazione ai conflitti era spesso motivata dalla pura necessità economica. A volte, si univano all’esercito anche per la promessa di ottenere un pezzo di terra al ritorno. Tuttavia, per molti, l’obiettivo principale rimaneva semplicemente quello di sopravvivere al conflitto e tornare a casa.Il difficile rapporto con la Resistenza
Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli abitanti delle campagne si trovarono in una posizione estremamente difficile, stretti tra le forze fasciste e i gruppi partigiani. Molti contadini guardavano con critica ai partigiani. Li consideravano un elemento di disturbo che rischiava di attirare rappresaglie violente da parte dei tedeschi e dei repubblichini. La convinzione diffusa era che i partigiani avrebbero dovuto provvedere a sé stessi senza chiedere aiuto o cibo alla popolazione locale. Per questo motivo, la reazione più comune tra i contadini era cercare di nascondersi e rimanere il più possibile lontani dal conflitto. Nonostante questa diffidenza e un certo opportunismo dettato dalla paura verso il regime, la maggior parte dei contadini non arrivò a tradire attivamente i partigiani. Tuttavia, le donne che sceglievano di aiutare i resistenti venivano spesso viste con sospetto e disapprovazione dalla comunità.Il dopoguerra: spopolamento e nuove economie
Terminato il conflitto, le aree rurali, in particolare quelle situate in montagna e in alta collina, conobbero un rapido e massiccio spopolamento. La mancanza di opportunità di lavoro e di garanzie economiche spinse molte persone ad abbandonare le loro terre in cerca di una vita migliore altrove. Questo abbandono diffuso ebbe conseguenze visibili sul paesaggio, portando a un progressivo degrado. Inoltre, l’incuria del territorio aumentò il rischio di disastri naturali, come le alluvioni. Parallelamente allo spopolamento delle zone più marginali, l’economia delle aree rurali si trasformò radicalmente. Nelle zone di pianura e bassa collina, si assistette allo sviluppo di un’agricoltura più specializzata, insieme alla crescita dell’industria e del turismo. Questi cambiamenti economici portarono con sé anche profonde modifiche nei costumi, nelle abitudini alimentari e nel sistema sanitario. Le nuove organizzazioni agricole che emergevano in questo periodo venivano spesso percepite dalla popolazione locale come strutture più orientate a tutelare gli interessi dei grandi proprietari terrieri. In questo modo, il mondo rurale tradizionale, basato su ritmi antichi e strutture sociali consolidate, lasciò il posto a nuove dinamiche economiche e sociali che ne ridisegnarono completamente il volto.È plausibile ridurre il complesso rapporto tra i contadini e la Resistenza a mera diffidenza e desiderio di nascondersi?
Il capitolo, pur descrivendo efficacemente la difficile posizione dei contadini stretti tra le forze in conflitto, rischia di semplificare eccessivamente la loro reazione alla Resistenza. La realtà storica fu ben più sfaccettata: accanto alla paura e alla diffidenza, esistettero forme di sostegno attivo, di collaborazione forzata, e di opportunismo non solo “dettato dalla paura verso il regime” ma anche da altre logiche locali o personali. La relazione variava enormemente a seconda delle regioni, della presenza specifica di formazioni partigiane e delle loro azioni, e delle dinamiche sociali interne alle comunità rurali. Per comprendere appieno questa complessità, è fondamentale approfondire la storia sociale della Resistenza e le dinamiche del consenso e del dissenso nelle campagne durante la guerra civile. Utili riferimenti si trovano negli studi di storici come Claudio Pavone o Gabriella Gribaudi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]