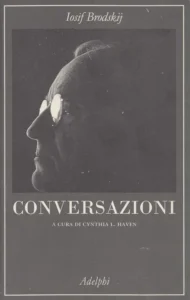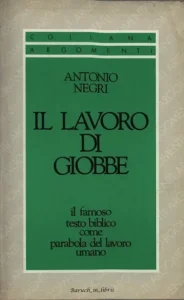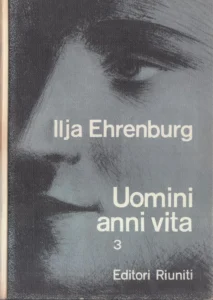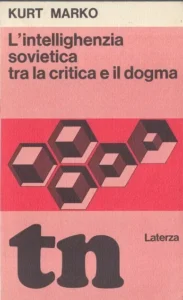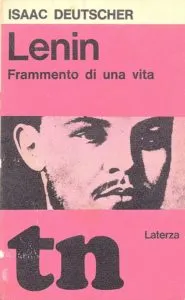1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
ci porta dritti nel cuore della Russia, ma non quella antica di Mosca, la “Terza Roma” legata alla tradizione e all’Ortodossia. Questo libro racconta la storia pazzesca di come Pietro il Grande abbia deciso di sradicare tutto, costruendo dal nulla San Pietroburgo, una “Finestra sull’Europa” su paludi inospitali. È una storia di contrasti enormi: la volontà ferrea di un sovrano visto come “Anticristo” o “Costruttore taumaturgo”, contro la sofferenza di chi ha pagato il prezzo di questa modernizzazione forzata. Pietroburgo non è solo una città, ma un simbolo potentissimo che ha diviso la Russia, alimentando il dibattito eterno tra Slavofili e Occidentalisti: restare fedele alle radici o aprirsi all’Europa? Il libro esplora come questa città artificiale, con la sua architettura grandiosa ma anche la sua realtà di miseria e burocrazia, abbia plasmato l’anima russa e ispirato capolavori della Letteratura russa. Da Pushkin che ne celebra la bellezza, a Gogol e Dostoevsky che ne svelano le illusioni e l’impatto sulla psicologia umana, Pietroburgo è un personaggio a sé, un miraggio affascinante e inquietante. È un viaggio nella storia, nel mito e nella poesia di una città che è il riflesso delle contraddizioni più profonde della Russia, fino al suo “declino” simbolico quando la capitale torna a Mosca.Riassunto Breve
La fondazione di Pietroburgo nel 1703 da parte di Pietro il Grande segna un cambiamento enorme per la Russia. Prima c’era Mosca, vista come la “Terza Roma”, legata alla religione ortodossa e all’eredità di Bisanzio. Questa visione giustificava il potere assoluto degli zar, come Ivan il Terribile. Ma i contatti con l’Occidente e problemi interni, come uno scisma religioso, iniziano a mettere in crisi questa idea. Pietro il Grande rompe con tutto questo. Fonda Pietroburgo, una città nuova, laica, orientata verso l’Europa. La chiama una “finestra sull’Europa”, simbolo di modernizzazione forzata e apertura. Come Ivan IV, usa un’idea forte per guidare il paese, ma in direzione opposta: non più religione e tradizione, ma scienza e modelli occidentali. Pietro è visto in modi diversi: per alcuni è l'”Anticristo” che distrugge la vecchia Russia, per altri è il “Costruttore” che porta il paese nel futuro. La costruzione di Pietroburgo è un’impresa enorme, su una zona paludosa, che costa molte vite umane, ma crea una città magnifica, con l’aiuto di architetti stranieri, soprattutto italiani. Le riforme di Pietro cambiano tutto: l’amministrazione, l’economia, la cultura, e mette anche la chiesa sotto il controllo dello stato. Queste trasformazioni incontrano molta resistenza. Pietroburgo diventa un simbolo potente. Viene chiamata “Palmira del Nord” o “Nuova Roma” per la sua bellezza, ma rappresenta anche la lotta tra la volontà dello stato e la sofferenza delle persone, come si vede nel poema “Il cavaliere di bronzo” di Púškin. La città alimenta un grande dibattito in Russia tra chi vuole seguire l’Europa (occidentalisti) e chi vuole restare legato alle tradizioni russe (slavofili). Gli slavofili vedono Mosca come il vero cuore della Russia e Pietroburgo come un’imposizione artificiale. Gli occidentalisti vedono Pietroburgo come necessaria per il progresso. Nella letteratura, la percezione della città cambia: da Púškin che ne celebra la bellezza, a Gògol’ che la vede come un luogo di illusione e burocrazia, fino a Dostoevskij che la lega alla psicologia umana, descrivendola come una città astratta e nebbiosa che porta alla “semifollia”. Le “notti bianche” diventano un simbolo di miraggio o irrealtà. Autori successivi descrivono la miseria nascosta dietro lo splendore. Anche storici vedono le riforme di Pietro come uno “shock” violento. Dopo la Rivoluzione del 1917, la capitale torna a Mosca, e Pietroburgo (rinominata Leningrado) perde il suo ruolo centrale, vista da alcuni come la chiusura della “finestra”. Il dibattito sull’identità russa e il suo rapporto con l’Europa, iniziato con Pietro e la sua città, continua ancora oggi.Riassunto Lungo
1. Due Miti e la Via della Russia
La fondazione di Pietroburgo nel 1703 segna un cambiamento fondamentale nella storia russa, segnando una rottura con il passato rappresentato da Mosca. Mosca era vista come la “Terza Roma” dopo la caduta di Costantinopoli, raccogliendo l’eredità spirituale e religiosa dell’Impero Bizantino. Rappresentava l’unificazione dei principati russi sotto un potere politico che aveva forti legami con la religione. Questa visione, espressa dalla dottrina del monaco Filofej, giustificava l’autorità assoluta degli zar moscoviti. Ivan IV il Terribile, ad esempio, usò questa dottrina per rafforzare il suo potere politico e religioso, affermando di discendere dagli imperatori romani e rivendicando un’autorità sia sui suoi sudditi che su tutto il mondo ortodosso.Il Declino del Mito di Mosca
L’idea di Mosca come “Terza Roma” cominciò a perdere forza con l’aumentare dei contatti con l’Occidente e a causa di crisi interne. Una di queste fu lo scisma religioso del XVII secolo, che divise la chiesa russa. Anche le critiche dei patriarchi orientali sulla purezza dei riti e dei testi sacri russi misero in discussione l’idea che l’ortodossia russa fosse infallibile. L’interesse per la cultura e le istituzioni occidentali cresceva costantemente. Viaggiatori, missioni diplomatiche e la presenza di stranieri a Mosca facilitarono questo avvicinamento all’Occidente, preparando il terreno per un cambiamento.Pietroburgo: La Finestra sull’Europa
Con la fondazione di Pietroburgo, Pietro il Grande abbandonò il mito religioso di Mosca per abbracciare un orientamento più laico e rivolto all’Occidente. Pietroburgo divenne il simbolo di questa nuova direzione, una vera e propria “finestra sull’Europa”. La città rappresentava una modernizzazione imposta con forza e un’apertura verso il commercio e la cultura europei. Questa nuova capitale incarnava la volontà di dominare la natura e di portare la Russia al livello delle nazioni occidentali. Per farlo, furono importati scienza, arte, architettura e nuovi modelli di organizzazione dello Stato.I Sovrani e la Forza dei Miti
Anche Pietro I, proprio come Ivan IV, utilizzò un mito per giustificare le sue riforme e la sua politica, sebbene con un significato completamente diverso. Se Ivan IV si basava su un mito religioso e politico legato al passato e all’Oriente, Pietro I si appoggiò a un mito più laico e orientato al futuro e all’Occidente. Entrambi gli zar, pur con metodi e visioni opposte, furono figure estremamente potenti che suscitarono reazioni molto forti tra la popolazione. Alcuni li veneravano quasi come divinità, altri li accusavano di essere l’Anticristo. Questo dimostra quanto i miti, siano essi religiosi o laici, abbiano avuto un ruolo fondamentale nel definire l’identità e la direzione che la Russia ha preso nella sua storia.Davvero la complessa transizione russa si esaurisce in un semplice scontro tra ‘miti’ fondativi, per quanto potentemente branditi dagli zar?
Il capitolo offre una chiave di lettura suggestiva, ponendo l’accento sul ruolo dei ‘miti’ nel plasmare la direzione della Russia. Tuttavia, questa prospettiva, focalizzata sulle sovrastrutture ideologiche e sul potere dei singoli sovrani, rischia di semplificare eccessivamente una realtà storica fatta anche di profonde dinamiche sociali, economiche e demografiche. Per cogliere appieno la complessità di questo cruciale passaggio, è indispensabile integrare l’analisi dei ‘miti’ con lo studio della storia sociale, delle trasformazioni economiche e delle pressioni geopolitiche che agivano sulla Russia. Approfondire queste discipline e confrontarsi con diverse scuole storiografiche può aiutare a superare una visione potenzialmente riduttiva, che vede i ‘miti’ non come uno degli strumenti del potere, ma quasi come l’unico motore del cambiamento.2. L’Anticristo e il Costruttore: Pietroburgo e le Riforme
Il regno di Pietro il Grande segnò una svolta nella storia russa, riassumendo il passato e anticipando il futuro. La sua spinta a modernizzare la Russia, superando la tradizione moscovita per proiettarla verso l’Europa, influenzò ogni aspetto della vita del paese. Le riforme si estesero all’amministrazione, all’economia, alla cultura e alla religione. Abolì il patriarcato e creò il Santo Sinodo, sottomettendo la chiesa allo stato. Istituì scuole pratiche, la Kunstkammer e l’Accademia delle Scienze, promuovendo la conoscenza e la tecnica. La sua giovinezza, segnata da un forte interesse pratico per le tecniche militari e navali, che lo portò a cercare maestri stranieri e a frequentare il quartiere degli stranieri a Mosca, più che da un’istruzione formale, fu determinante per questa visione europeizzante.La nuova capitale: San Pietroburgo
La fondazione di Pietroburgo fu una mossa strategica, volta a ottenere uno sbocco sul Baltico e a difendersi dagli svedesi. La scelta del luogo, una zona paludosa, richiese un’opera colossale e causò molte vittime tra i contadini reclutati per i lavori. La città fu costruita con l’aiuto di numerosi architetti e ingegneri stranieri, che portarono stili diversi, riflettendo il desiderio di Pietro di creare una città europea. La rapida crescita di Pietroburgo apparve quasi miracolosa, vista come una “finestra aperta sull’Europa”.Due visioni di Pietro il Grande
Queste trasformazioni radicali e l’opera di fondazione suscitarono reazioni opposte, portando a due visioni contrastanti di Pietro. Tra il popolo, i monaci scismatici, i boiari e i mercanti legati alla vecchia fede si diffuse la visione dell'”Anticristo”. Essi vedevano le riforme e la nuova capitale come un attacco alla tradizione moscovita e alla chiesa ortodossa. Affreschi e racconti popolari lo ritraevano come una figura demoniaca. Le sue azioni, come l’obbligo di tagliare la barba o cambiare abiti, e le sofferenze causate da reclutamenti e tasse elevate, alimentarono questa percezione.Contemporaneamente, si sviluppò l’idea del “Costruttore taumaturgo”. Questa visione, inizialmente limitata a pochi, si diffuse nel XVIII secolo. Sottolineava lo sforzo individuale di Pietro nel superare ostacoli naturali e umani. La città stessa, nata dal nulla in una zona ostile, era la prova della sua capacità di realizzare l’impossibile.Nonostante le resistenze, anche all’interno della sua famiglia, come dimostra il tragico destino del figlio Aleksej che si opponeva alle nuove idee, le riforme e la creazione di Pietroburgo cambiarono radicalmente la Russia. La proiettarono verso l’Europa e la trasformarono da principato di Moscovia a Impero russo.Quanto la “visione europeizzante” di Pietro fu davvero una scelta personale dettata dalla sua giovinezza, e non piuttosto una necessità storica della Russia?
Il capitolo lega strettamente la “visione europeizzante” di Pietro alle sue esperienze giovanili e ai suoi interessi pratici. Questa prospettiva, pur valida, rischia di trascurare il contesto più ampio: quali erano le pressioni interne ed esterne sulla Russia pre-petrina? Esistevano già correnti riformiste o necessità strutturali che avrebbero comunque spinto verso un’apertura o una modernizzazione di stampo occidentale, indipendentemente dalla specifica personalità del sovrano? Per approfondire, è utile esplorare la storia russa del XVII secolo, le sue relazioni internazionali e la struttura sociale ed economica dell’epoca. Autori come Kliuchevsky o Riasanovsky possono offrire prospettive più ampie sui processi storici che precedettero e accompagnarono il regno di Pietro.3. La città sull’abisso e il suo costruttore
Pietroburgo viene chiamata con nomi importanti come “Palmira del Nord” e “Nuova Roma”. Questi nomi mostrano quanto fosse magnifica la città e il suo ruolo di ponte tra l’Oriente e l’Occidente. Indicano anche la grandezza dell’impero russo. La città nasce per volere forte di Pietro il Grande in un’area piena di paludi. Questo fatto dimostra la vittoria della volontà umana sulla natura e rappresenta il rinnovamento della Russia e la sua apertura verso l’Europa.Lo splendore architettonico
La bellezza degli edifici della capitale cambia nel tempo, seguendo diversi stili. Durante il regno di Elisabetta Petròvna, l’architetto Bartolomeo Rastrelli porta lo stile barocco-rococò. Questo stile è caratterizzato da grande imponenza e ricchezza di decorazioni. Rastrelli crea edifici famosi come il Palazzo d’Inverno e il Monastero Smòl’nyj. Più tardi, con Caterina II e Alessandro I, si diffonde lo stile neoclassico. Architetti come Giacomo Quarenghi, conosciuto per la sua eleganza semplice, e Carlo Rossi, che progetta grandi complessi urbani, lavorano per rendere Pietroburgo una “seconda Roma”. Architetti italiani hanno un ruolo molto importante in questi cambiamenti.Pietro il Grande: un sovrano controverso
La figura di Pietro il Grande e tutto quello che ha fatto sono visti in modi molto diversi. Alcuni lo considerano un grande riformatore e un “costruttore quasi magico”. Altri lo criticano duramente, vedendolo come un tiranno. Lo accusano della violenza delle sue riforme e del suo disprezzo per le vecchie tradizioni russe. Questa diversità di opinioni si trova spesso nella letteratura che parla di lui.Il conflitto nel “Cavaliere di bronzo”
Il poeta Púškin, nel suo poema “Il cavaliere di bronzo”, esplora il contrasto tra la potenza dello stato e la sofferenza delle persone comuni. La potenza dello stato è rappresentata dalla statua di Pietro, mentre la sofferenza individuale è mostrata attraverso il povero Evgénij, colpito da una grande alluvione. Il poema mette in scena lo scontro tra la volontà dello stato (Pietro, la necessità della storia) e il destino del singolo (Evgénij). Ci sono diverse interpretazioni di questo scontro: alcuni lo vedono come la lotta tra il potere assoluto e la libertà personale, altri come il confronto tra la grande visione del sovrano e il prezzo umano pagato per realizzarla. L’opera di Púškin, influenzata anche dal poeta polacco Mickiewicz, fa capire quanto sia complesso giudicare l’eredità di Pietro il Grande.Ma è sufficiente la descrizione dell’ambiente urbano a spiegare le profondità (o le patologie) dell’animo umano?
Il capitolo pone l’accento sul legame tra l’ambiente di Pietroburgo e la psiche dei personaggi, suggerendo quasi una causalità diretta. Tuttavia, ridurre la complessità dell’animo umano all’influenza del paesaggio urbano rischia di essere riduttivo. Per approfondire questo rapporto, sarebbe utile esplorare studi di psicologia ambientale, sociologia urbana e critica letteraria che analizzano come lo spazio influenzi (ma non determini unicamente) l’individuo. Leggere autori come Simmel o Benjamin, che hanno riflettuto sulla vita nelle metropoli, potrebbe offrire prospettive diverse.6. La Finestra Contesa: Pietroburgo tra Europa e Tradizione Russa
Pietro il Grande fondò la città di Pietroburgo con l’intento di creare un’apertura diretta della Russia verso l’Europa. Questa nuova capitale fu pensata come una “finestra” simbolica che guardava a Occidente, segnando un distacco dalla tradizione russa incarnata da Mosca. Fin da subito, questa scelta generò un acceso dibattito all’interno della società russa. Da un lato c’erano gli “occidentalisti”, che sostenevano l’orientamento verso i modelli europei; dall’altro gli “slavofili”, che invece valorizzavano l’identità e le tradizioni russe e moscovite. Questa tensione tra le due visioni ha attraversato la storia russa per lungo tempo.Le critiche alla visione di Pietro
Molti pensatori e scrittori criticarono aspramente l’opera di Pietro il Grande. Già nel 1839, figure come il marchese de Custine vedevano Pietroburgo come una costruzione artificiale, destinata a non durare nel tempo, contrapponendola a Mosca, considerata il vero cuore della Russia. Questa critica fu ripresa da importanti intellettuali russi. Fëdor Dostoevskij, Nikolaj Danilevskij e Konstantin Leontiev, tra gli altri, espressero il loro dissenso. Danilevskij, in particolare, sosteneva che la Russia rappresentasse un tipo culturale unico, distinto dall’Europa, e per questo l’apertura voluta da Pietro era stata un errore fondamentale. Leontiev vedeva nella modernizzazione di Pietro un passo verso un’uguaglianza che giudicava distruttiva, proponendo invece un ritorno a radici slavo-bizantine e suggerendo di spostare l’attenzione russa verso Est, magari fino a Costantinopoli. Nel frattempo, Mosca manteneva forte il suo significato culturale e nazionale, celebrata da poeti come Aleksandr Puškin come simbolo dell’anima russa.L’impatto storico e la rivalità tra le città
Anche gli storici analizzarono a fondo le trasformazioni volute da Pietro il Grande. Studiosi come Konstantin Kavelin e Vasilij Klyuchevsky interpretarono le sue riforme non come uno sviluppo naturale della società russa, ma come una “scossa” violenta imposta dall’alto che ne alterò profondamente il corso. Questa tensione tra Pietroburgo e Mosca non rimase solo un dibattito intellettuale, ma si manifestò anche nello sviluppo concreto delle due città. Mosca, pur crescendo e sviluppando una propria borghesia intellettuale e un’industria sempre maggiore, rimase a lungo finanziariamente dipendente dalla capitale voluta da Pietro.Il ritorno a Mosca e la persistenza del dibattito
Un cambiamento radicale avvenne dopo la Rivoluzione del 1917. La capitale fu riportata a Mosca, segnando un ribaltamento del centro politico. Pietroburgo, che fu poi rinominata Leningrado, perse così il suo ruolo centrale nella vita politica del paese. Questo spostamento fu interpretato da alcuni come la chiusura simbolica di quella “finestra sull’Europa” che Pietro il Grande aveva cercato di aprire, quasi a confermare le profezie sul declino della città. Nonostante il cambio di capitale, il dibattito fondamentale sull’identità russa e sul suo rapporto con il mondo esterno, in particolare con l’Europa, non si esaurì. Continuò ad assumere nuove forme, manifestandosi in correnti di pensiero come l’eurasismo o all’interno delle discussioni sul socialismo. La figura stessa di Pietro il Grande fu oggetto di nuove valutazioni, e alcuni videro parallelismi tra l’epoca delle sue forzate trasformazioni e il periodo post-rivoluzionario, caratterizzato anch’esso da profondi e rapidi cambiamenti imposti alla società.La “finestra sull’Europa” e il dibattito intellettuale esauriscono davvero la complessità del rapporto russo con l’Occidente?
Il capitolo descrive efficacemente la tensione intellettuale e simbolica legata alla fondazione di Pietroburgo e al dibattito tra occidentalisti e slavofili. Tuttavia, concentrandosi principalmente su questa “finestra” e sulle reazioni dei pensatori, rischia di trascurare la multifaccettata e spesso contraddittoria realtà storica. Le riforme di Pietro il Grande non furono solo un atto simbolico o un tema di dibattito, ma ebbero conseguenze concrete e a lungo termine sulla struttura sociale, economica e amministrativa della Russia, spesso imposte con brutalità e resistenza. Per comprendere appieno il periodo e il suo impatto, è fondamentale approfondire la storia sociale ed economica della Russia petrina e post-petrina, studiando non solo le idee, ma anche le pratiche di governo e la vita quotidiana. Autori come Klyuchevsky offrono una base, ma è utile esplorare storici più recenti che analizzano le dinamiche di potere, le resistenze interne e le specifiche interazioni (non solo intellettuali) tra Russia ed Europa. Considerare anche la prospettiva europea su questo scambio può arricchire l’analisi, superando la dicotomia interna presentata.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]