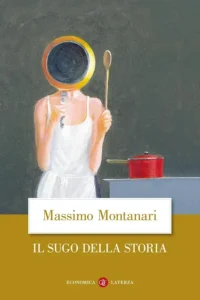1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il mito delle origini” di Massimo Montanari ti fa capire che le cose non sono mai semplici come sembrano, specialmente quando parliamo di storia e cibo. Dimentica l’idea che tutto nasca da un punto fisso, tipo Marco Polo che porta la pasta dalla Cina – spoiler: è una fake news! Montanari smonta questa visione semplicistica e ti porta in un viaggio affascinante per scoprire la vera storia della pasta, che in realtà ha radici nel Medio Oriente e si sviluppa in Italia, soprattutto in Sicilia e poi a Napoli, diventando piano piano il simbolo della cucina italiana che conosciamo oggi. Non è solo la pasta, eh: il libro esplora come ingredienti come il pomodoro (arrivato dall’America e inizialmente snobbato), il formaggio, la forchetta, il basilico, l’olio d’oliva, l’aglio e il peperoncino si sono integrati nelle nostre abitudini alimentari, spesso partendo da usi diversi o da altre culture. È un racconto di scambi culturali, evoluzione culinaria e come l’identità italiana nel piatto sia un mix dinamico, non qualcosa di immutabile. Se ti interessa la storia del cibo e vuoi capire davvero da dove vengono i piatti che amiamo, questo libro ti apre gli occhi sul mito delle origini e sulla complessità della nostra identità culinaria.Riassunto Breve
L’origine di un fenomeno non spiega tutto da sola. Spesso si pensa che l’inizio di qualcosa sia la causa completa, ma è solo un punto di partenza che ha bisogno di un ambiente favorevole per svilupparsi. Questo vale anche per il cibo. Cercare la ricetta originale o il prodotto autoctono perfetto non basta a capire un piatto. Il territorio da solo non crea un prodotto; è l’incontro tra la natura e il lavoro dell’uomo. La vera identità di un piatto, come gli spaghetti al pomodoro, non sta in chi l’ha inventato o quando, ma nelle condizioni storiche, ambientali e culturali che l’hanno fatto nascere e cambiare. L’identità è dinamica, fatta di scambi e trasformazioni.La storia della pasta occidentale non inizia con Marco Polo che la porta dalla Cina, quella è una notizia falsa nata da un errore. La pasta ha radici in Medio Oriente, dove esistevano impasti simili al pane non lievitato. Anche Greci e Romani avevano preparazioni come *laganon*, ma non erano una categoria a sé. La cottura in acqua non era comune per loro. Gli Arabi sono stati fondamentali per diffondere la pasta secca nel Mediterraneo, e termini arabi sono arrivati nelle lingue europee.La prima produzione industriale di pasta secca si sviluppa in Sicilia nel XII secolo, sotto Arabi e Normanni. Al-Idrisi parla di Trabia che esporta grandi quantità di pasta. Questo succede perché la Sicilia aveva già una forte tradizione agricola e l’influenza araba ha spinto la pasta secca, perfetta per il commercio via mare. Da lì, la produzione si diffonde in altre zone costiere italiane. All’inizio, “maccheroni” era un nome generico. Tra Medioevo e Rinascimento, la pasta diventa una categoria alimentare riconosciuta, con diverse forme studiate da medici e cuochi. Il termine “pasta” in italiano arriva a includere tutta questa varietà regionale.Bollire la pasta in acqua salata, che sembra normale oggi, è un’abitudine che si è affermata nel tempo. Prima si cucinava in altri modi. Bollire la pasta secca serviva a reidratarla, seguendo idee mediche antiche che cercavano di bilanciare le qualità degli alimenti. La pasta bollita era umida, e per bilanciare si aggiungevano ingredienti secchi. Il formaggio stagionato, soprattutto il parmigiano, era perfetto per questo, creando un abbinamento classico. Anche l’uso della forchetta si lega alla pasta. Nel Medioevo si usavano mani, cucchiaio, coltello. Ma la pasta calda e scivolosa era difficile da mangiare con le mani, così in Italia la forchetta si diffonde prima che altrove, diventando essenziale per la pasta.La pasta non era sempre un cibo base. A Napoli, intorno al 1630, diventa fondamentale per la popolazione impoverita da carestie e malgoverno. L’introduzione di macchinari abbassa i costi e i maccheroni diventano accessibili, sostituendo carne e verdure. I napoletani diventano i “mangiamaccheroni”. La pasta passa da contorno a piatto principale, anche cibo da strada. La cottura cambia da lunga a “al dente”. L’emigrazione italiana diffonde la pasta nel mondo, creando lo stereotipo dell’italiano “mangiamaccheroni”, che paradossalmente rafforza l’identità nazionale, rendendo la pasta un simbolo unitario.Il pomodoro, che viene dal Sud America, ci ha messo tanto ad essere accettato in Italia, anche se è arrivato nel Cinquecento. All’inizio c’era diffidenza, anche i medici lo vedevano male, paragonandolo alla melanzana. La Spagna ha aiutato a diffonderlo. Nel Seicento, la salsa di pomodoro, a volte chiamata “spagnola”, inizia ad apparire nei ricettari. Aggiunge il colore rosso alle salse. Nel Settecento e Ottocento si diffonde, e le idee mediche cambiano. Napoli è il luogo chiave dove pasta e pomodoro si incontrano. All’inizio il pomodoro si aggiungeva ad altri condimenti, ma poi la salsa semplice diventa la base. Artusi, a fine Ottocento, la rende famosa a livello nazionale.Ingredienti come peperoncino, olio d’oliva, aglio e cipolla hanno storie diverse. Il peperoncino, dall’America, si diffonde subito perché è facile da coltivare e costa poco, diventando popolare. L’olio d’oliva, antico, è rimasto a lungo limitato a certe zone e classi sociali; nel Medioevo si usavano più grassi animali, e l’olio diventa comune solo nel Novecento. Aglio e cipolla, coltivati da millenni, erano visti come cibi “volgari”, legati alla cucina contadina. Entrano nella cucina più raffinata tardi e diventano fondamentali con la diffusione della salsa di pomodoro.Il basilico oggi è un simbolo italiano, specialmente con pomodoro e mozzarella. Ma non è sempre stato così. Viene dall’India e dall’Africa, arrivato nel Mediterraneo anticamente, ma usato più come medicina. Testi antichi e medievali gli attribuivano proprietà negative. Solo nel Cinquecento si inizia a usarlo di più in cucina, soprattutto nelle insalate e minestre. L’associazione con il pomodoro e gli spaghetti arriva molto dopo, nell’Ottocento. La storia degli spaghetti al pomodoro e della cucina italiana mostra che i piatti che sembrano tradizionali sono il risultato di tanti cambiamenti e influenze nel tempo. L’identità culinaria non è fissa, ma è un processo dinamico. Le “radici” sono spesso gli “altri” che hanno contribuito a formare quello che consideriamo la nostra identità.Riassunto Lungo
1. Seme e Contesto: Decostruire le Origini
L’idea comune di origine è sbagliata
Spesso si pensa che l’origine di qualcosa sia la causa principale che spiega come mai quel qualcosa esiste. In realtà, questa idea non tiene conto di quanto la storia sia complessa. Pensare all’origine come a una causa unica e sufficiente è troppo semplice. Le origini sono solo l’inizio di un processo, come un seme che ha bisogno di un terreno adatto per crescere e svilupparsi. Per capire meglio, possiamo usare l’immagine della ghianda e della quercia: la ghianda è necessaria perché nasca la quercia, ma da sola non basta. La quercia crescerà solo se trova un ambiente giusto intorno a sé.L’ossessione per le origini nel cibo
Questo modo di pensare si può applicare anche al cibo. Oggi siamo molto interessati a trovare le ricette originali e i prodotti tipici di un luogo. Pensiamo che il luogo o il tempo in cui un cibo è nato gli diano un valore speciale e lo rendano unico. Però, un territorio da solo non basta a spiegare un prodotto alimentare. Un prodotto nasce dall’incontro tra la natura di un luogo e il lavoro dell’uomo. Il concetto di “terroir” è più adatto a spiegare questa complessità, perché considera sia l’ambiente geografico che le capacità delle persone.Spaghetti al pomodoro: un esempio di identità dinamica
Anche per piatti famosi come gli spaghetti al pomodoro, cercare l’origine non vuol dire trovare chi li ha inventati o quando sono nati. La cosa importante è capire quali condizioni ambientali, storiche e culturali hanno permesso a questo piatto di diventare un simbolo della cucina italiana. Esistono tantissime ricette diverse di spaghetti al pomodoro, e questo dimostra che la cucina italiana è sempre in movimento e cambia continuamente. È il risultato di incontri, scambi e trasformazioni che avvengono nel tempo e nei diversi luoghi. La vera identità della cucina italiana sta nella sua capacità di mescolare e reinterpretare ingredienti e ricette diverse, non nella ricerca di una purezza delle origini che non esiste.Se l’origine non è la causa principale, rischiamo di sottovalutare l’importanza delle condizioni iniziali nello sviluppo di un fenomeno?
Il capitolo mette in luce giustamente la complessità delle origini, ma è fondamentale non cadere nell’estremo opposto. Sebbene il contesto e le trasformazioni siano cruciali, le condizioni iniziali pongono dei vincoli e influenzano la traiettoria di sviluppo. Per approfondire questa dinamica, si suggerisce di esplorare il pensiero sistemico, che analizza come condizioni iniziali e cicli di feedback interagiscono nel tempo. Autori come Nassim Nicholas Taleb, nei suoi studi sulla casualità e i sistemi complessi, offrono spunti rilevanti sul ruolo degli eventi iniziali e della dipendenza dal percorso.2. La Vera Storia della Pasta
Le vere origini della pasta
La pasta, contrariamente a quanto molti pensano, non è stata portata in Italia dalla Cina da Marco Polo. Questa idea sbagliata nasce da un errore di interpretazione dei suoi scritti nel Cinquecento. In realtà, Marco Polo descrive nei suoi testi un tipo di pasta fatta con la farina di sago che ha visto a Sumatra, non in Cina. Lui stesso paragona questa pasta esotica a prodotti italiani che già conosceva bene. Quindi, la storia della pasta che mangiamo in Occidente ha radici diverse e molto più antiche, che affondano nel Medio Oriente.La pasta nel mondo antico
La pasta si sviluppa come un’evoluzione del pane non lievitato nelle regioni del Medio Oriente. Già nell’antica Persia esistevano nomi per indicare impasti simili alla pasta, come lakhsha e rishta. Anche nel mondo greco e romano si conoscevano preparazioni affini, chiamate laganon e lagana. Tuttavia, queste preparazioni non erano considerate un tipo di cibo specifico come intendiamo oggi la pasta. Inoltre, cuocere la pasta in acqua era visto come un modo strano di cucinare rispetto alle abitudini culinarie dei greci e dei romani, che preferivano pane e polente.Il ruolo degli Arabi e la diffusione nel Mediterraneo
Gli arabi hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione della pasta secca nel Mediterraneo occidentale. Lo dimostrano parole come itriyya e fidawsh, che vengono dall’arabo e che testimoniano questo sviluppo. Queste parole sono poi state adottate dalle lingue neolatine, compreso l’italiano, per indicare la pasta. Quindi, la storia della pasta è il risultato di scambi culturali e di nuove idee culinarie che arrivano dal Medio Oriente, e non di un’importazione dalla Cina.Ma siamo sicuri che ridurre tutto il merito storico della pasta al “Medio Oriente” non sia eccessivamente semplicistico, oscurando magari contributi e sfumature regionali cruciali?
Il capitolo, pur correggendo un errore comune, rischia di presentare una visione un po’ monolitica dello sviluppo della pasta. Approfondire le dinamiche culturali e geografiche specifiche all’interno del Medio Oriente, e considerare le interazioni con altre regioni, potrebbe arricchire notevolmente la comprensione. Per questo, sarebbe utile esplorare la storia della gastronomia e le opere di autori che si sono dedicati allo studio delle cucine mediterranee e mediorientali antiche.3. L’Ascesa della Pasta: Dalla Sicilia all’Identità Italiana
In Sicilia, nel XII secolo, durante il periodo di dominazione araba e normanna, nasce la prima vera industria di pasta secca. Un documento storico di al-Idrisi testimonia l’esistenza, a Trabia, di aziende agricole specializzate nella produzione e vendita di grandi quantità di pasta, chiamata itriyya. Questa pasta veniva poi esportata in tutto il Mediterraneo. La nascita di questa produzione industriale in Sicilia non avviene per caso, ma è il risultato di diversi fattori storici e ambientali che si sono combinati tra loro. L’isola, che già in epoca romana era considerata il granaio del mondo e che faceva parte della Magna Grecia, poteva contare su una lunga tradizione agricola e alimentare. L’influenza araba, unendosi alla preesistente cultura greco-romana, ha portato all’introduzione e alla diffusione della pasta secca, un prodotto ideale per i commerci via mare.La diffusione della pasta in Italia
La produzione di pasta dalla Sicilia si estende poi ad altre regioni costiere italiane, come la Sardegna, la Liguria, Pisa, Venezia e Napoli. Questo è dovuto soprattutto alla sua caratteristica di essere un prodotto che si conserva a lungo e che si presta bene al commercio. In particolare, Genova diventa un importante centro per l’importazione e l’esportazione della pasta. Con il passare dei secoli, la pasta si afferma sempre di più come un elemento fondamentale della cucina italiana.La pasta assume una sua identità
Inizialmente conosciuta con il nome di maccheroni, un termine che veniva usato genericamente per indicare gli gnocchi di farina, la pasta secca inizia gradualmente a distinguersi e ad assumere una sua precisa identità. Nei libri di ricette del Trecento e del Quattrocento si nota una crescente attenzione verso le diverse tipologie di pasta, sia fresca che secca. Nel Quattrocento, Maestro Martino descrive in modo dettagliato i “macharoni siciliani”, che possono essere considerati gli antenati degli spaghetti, sottolineando l’importanza del processo di essiccazione per la conservazione di questo alimento.La pasta come categoria alimentare autonoma
Tra il Medioevo e il Rinascimento, in Italia si sviluppa l’idea di considerare la pasta come una categoria alimentare a sé stante. Medici e esperti di gastronomia iniziano a catalogare e studiare le varie tipologie di pasta, riconoscendone le differenze e il valore nutrizionale. Anche il linguaggio della cucina si evolve, e la parola “pasta” nella lingua italiana assume un significato ampio e inclusivo. Questo termine riesce a comprendere la grande varietà di formati e tradizioni regionali, diventando un simbolo della cultura gastronomica italiana, basata sulla ricchezza e diversità dei prodotti locali.Se il capitolo afferma che il cambiamento di status del peperoncino è dovuto al desiderio delle élite di distinguersi, non rischia di ridurre eccessivamente le complesse dinamiche socio-economiche e culturali che influenzano le abitudini alimentari nel corso della storia?
Il capitolo presenta una narrazione lineare e semplificata dell’evoluzione dei gusti alimentari, focalizzandosi principalmente sul cambiamento di percezione di alcuni ingredienti. Tuttavia, l’affermazione che le élite abbiano abbandonato il peperoncino per distinguersi potrebbe trascurare altri fattori cruciali. Per una comprensione più completa, sarebbe utile esplorare la storia economica e sociale dell’alimentazione, approfondendo le dinamiche di mercato, le innovazioni agricole, le migrazioni e gli scambi culturali. Autori come Fernand Braudel o Sidney Mintz offrono prospettive più ampie sulle trasformazioni alimentari nel corso della storia, considerando molteplici variabili.8. Il Tocco Verde dell’Identità
Il basilico nella cucina italiana contemporanea
Oggi, in Italia, il basilico è fondamentale in cucina. È diventato un vero e proprio simbolo della nostra identità nazionale, soprattutto quando lo abbiniamo a pomodoro e mozzarella. Questi tre ingredienti insieme ricordano i colori della bandiera italiana. Però, non è sempre stato così: il basilico non ha radici antichissime nella nostra tradizione culinaria. Arriva dall’India e dall’Africa tropicale e ha raggiunto il Mediterraneo ai tempi degli antichi Greci e Romani. In quel periodo, però, non lo usavano in cucina, ma solo per curare le malattie.Le antiche credenze sul basilico
Nell’antichità e nel Medioevo, esperti di alimentazione come Galeno e Platina pensavano che il basilico fosse un ingrediente negativo. Credevano che facesse male allo stomaco e che potesse addirittura far impazzire le persone. Nonostante queste idee negative, alcune persone lo usavano, ma con molta attenzione. Nei libri di ricette del Medioevo, si preferiva usare altre erbe aromatiche come il timo, la maggiorana e la menta, invece del basilico.Il basilico comincia a essere usato in cucina
Solo nel Cinquecento, il basilico ha iniziato a essere usato di più in cucina. Un botanico di nome Costanzo Felici ha scritto che il basilico era un ingrediente comune nelle insalate e nelle minestre. Sembra che piacesse soprattutto alle donne. Nel Seicento, un altro esperto, Castelvetro, ha confermato che le cuoche di casa usavano il basilico nelle insalate miste.Il basilico incontra il pomodoro
Quindi, il basilico è entrato nella cucina italiana tra il Cinquecento e il Seicento. Però, per vederlo insieme al pomodoro, soprattutto negli spaghetti, bisogna aspettare fino al 1837. In quell’anno, Ippolito Cavalcanti ha messo la ricetta degli spaghetti al pomodoro nel suo libro di cucina. Anche dopo il famoso libro di ricette di Artusi, il basilico ha impiegato un po’ di tempo per diventare un simbolo della cucina italiana in tutta la nazione.L’identità culinaria è in continua evoluzione
La storia degli spaghetti al pomodoro, e più in generale della cucina italiana, ci fa capire che molti piatti che consideriamo tradizionali sono nati da cambiamenti culturali e nuove idee arrivate nel tempo. La nostra identità culinaria non è qualcosa di immutabile, ma cambia continuamente grazie agli incontri tra culture diverse, agli scambi di ingredienti e alle trasformazioni dei gusti. Quando cerchiamo le origini dei nostri piatti, scopriamo in realtà quanto siamo stati influenzati da culture esterne. Queste influenze straniere sono proprio ciò che rende unica la nostra cultura culinaria.Ma se il basilico è diventato un simbolo dell’identità culinaria italiana solo in tempi relativamente recenti, possiamo considerarlo un simbolo “autentico” o piuttosto una costruzione culturale più moderna?
Il capitolo presenta il basilico come simbolo dell’identità italiana contemporanea, ma la sua argomentazione storica evidenzia una diffusione e accettazione relativamente tarda nella cucina popolare. Per rispondere alla domanda sull’autenticità di questo simbolo, sarebbe utile approfondire studi di antropologia culturale e sociologia dell’alimentazione, che analizzano come i simboli culturali vengono costruiti e adottati nel tempo. Autori come Roland Barthes, con i suoi studi sulla semiotica del cibo, o Massimo Montanari, storico dell’alimentazione, potrebbero offrire strumenti concettuali utili per comprendere la complessità della costruzione dei simboli culinari e la loro evoluzione nel contesto sociale e culturale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]