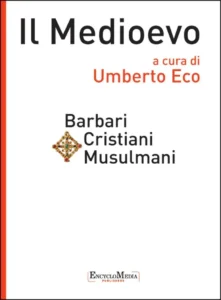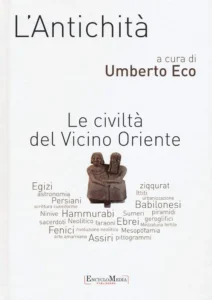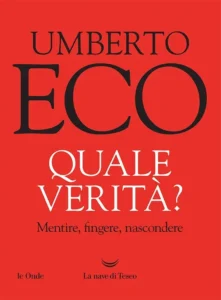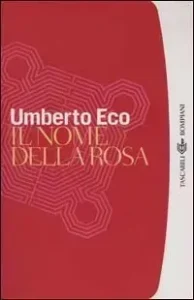1. Dinamiche tra Europa Occidentale e Oriente nel Medioevo
L’espansione dei popoli germanici verso est prende il via nell’undicesimo secolo. Inizialmente, sono i sovrani della dinastia Salica a guidare spedizioni militari contro le popolazioni slave, spesso animate da motivazioni religiose. I territori che vengono via via conquistati vengono poi ripopolati da genti di origine tedesca. Nel corso del dodicesimo secolo, l’iniziativa di questa espansione passa nelle mani dei signori locali, come cavalieri e principi sassoni. Essi ampliano i propri domini a spese delle terre abitate dagli Slavi, introducendo in queste aree le strutture tipiche del sistema feudale.Anche gli ordini militari religiosi, come i Portaspada e i Cavalieri Teutonici, giocano un ruolo fondamentale in questa fase di conquista e insediamento, in particolare nella regione della Prussia. A partire dal tredicesimo secolo, l’immigrazione si allarga, includendo non solo guerrieri e signori, ma anche contadini e abitanti delle città. Queste genti sono attratte dalle nuove opportunità, ma anche spinte verso est dalle invasioni mongole che causano un forte spopolamento in aree come la Polonia e l’Ungheria. I coloni tedeschi portano con sé nuove e più efficienti tecniche agricole, che si riflettono nella creazione di insediamenti organizzati in linee rette, e nuove forme di organizzazione urbana, basate sul diritto comunale e su statuti come quelli di Magdeburgo. Questo contribuisce in modo significativo alla crescita economica e alla rinascita di molte città. I tedeschi sono anche esperti minatori e diffondono le loro tecniche di estrazione e l’organizzazione del lavoro in diverse regioni, dalla Slesia alla Boemia, dalla Moravia all’Ungheria, e ancora in Serbia, Bosnia, Bulgaria, arrivando fino a Tessalonica. Questa vasta migrazione trasforma profondamente il volto dell’Europa orientale, anche se gli storici offrono interpretazioni diverse sul suo carattere, discutendo se sia stata principalmente un’opera di civilizzazione o un’espansione aggressiva.L’Europa guarda al Mediterraneo Orientale
Parallelamente a questa spinta verso est via terra, le grandi potenze dell’Europa occidentale rivolgono il loro sguardo verso il Mediterraneo orientale. Un esempio chiave è la Quarta Crociata, promossa da Papa Innocenzo III con l’intenzione di liberare la Terrasanta. Tuttavia, l’impresa devia significativamente dal suo obiettivo originale. Venezia, che si occupa di fornire le navi necessarie per il trasporto dei crociati, ottiene in cambio il loro aiuto per assoggettare la città di Zara nel 1202. Successivamente, i Veneziani spingono i crociati a dirigersi verso Costantinopoli, la capitale dell’Impero Bizantino.La città bizantina viene presa e saccheggiata nel 1204, un evento che segna un punto di svolta. Questo porta alla fondazione del cosiddetto Impero Latino d’Oriente, un’entità politica di breve durata che esisterà fino al 1261. Venezia emerge come il principale beneficiario di questa crociata, ottenendo il controllo di numerose e strategiche piazze commerciali nel Mediterraneo orientale. Questo evento, oltre a consolidare la potenza marittima ed economica di Venezia, acuisce ulteriormente lo scisma già esistente tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente, rendendo la separazione ancora più profonda.La competizione tra le città marinare italiane
Nel frattempo, le città marinare italiane sono in forte competizione tra loro per il controllo dei lucrosi traffici commerciali nel Mediterraneo. Pisa e Genova, in particolare, si scontrano duramente nel corso del tredicesimo secolo. La sconfitta subita da Pisa nella battaglia della Meloria nel 1284 segna l’inizio del suo progressivo declino come potenza marittima.Dopo l’indebolimento di Pisa, Genova e Venezia diventano le due principali rivali, combattendo aspramente per il dominio delle rotte commerciali verso l’Oriente. Venezia, in particolare, consolida la sua posizione di forza nel Mediterraneo orientale proprio grazie ai vantaggi ottenuti dalla Quarta Crociata. La rivalità tra Genova e Venezia prosegue intensa per tutto il tredicesimo e quattordicesimo secolo.Questa lunga competizione raggiunge il suo culmine nella Guerra di Chioggia, combattuta tra il 1378 e il 1381. La guerra si conclude con la sconfitta di Genova, che segna l’inizio del suo definitivo declino come potenza marittima di primo piano. Sia Genova che Venezia, pur con esiti diversi, dovranno in seguito affrontare e adattarsi ai profondi mutamenti geopolitici che interessano il Mediterraneo, primo fra tutti l’ascesa inarrestabile dell’Impero Ottomano.Ma questa espansione verso est fu davvero solo ‘civilizzazione’, come suggeriscono alcuni passaggi del capitolo?
Il capitolo, pur riconoscendo che gli storici offrono interpretazioni diverse, sembra indugiare sugli aspetti legati all’introduzione di nuove tecniche agricole e urbane da parte dei coloni tedeschi, quasi a voler accreditare una narrativa di progresso. Tuttavia, per cogliere la reale natura di questa dinamica, è indispensabile esplorare a fondo le prospettive che la descrivono come un’espansione aggressiva, con le sue inevitabili conseguenze di conquista, sottomissione e alterazione profonda del tessuto sociale ed etnico dei territori slavi e baltici. Approfondire la storia dell’Europa orientale medievale, con particolare attenzione alle fonti e alle interpretazioni provenienti dalle aree interessate dalla colonizzazione, è cruciale per bilanciare la narrazione.2. Scontro di Poteri e Nuovi Equilibri
Lo scontro tra poteri e l’Impero di Federico II
Il XIII e XIV secolo vedono un forte scontro tra le grandi autorità del Medioevo, l’Impero e il Papato, e le nuove potenze che stanno nascendo: i regni nazionali e i Comuni in Italia. Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia, usa gran parte del suo regno per combattere proprio i Comuni e i pontefici, che temono il suo grande potere. Nonostante le guerre, Federico II crea un regno organizzato e centralizzato con le Costituzioni Melfitane, che permettono anche la tolleranza religiosa. La sua corte è un luogo di cultura vivace, dove nasce l’Università di Napoli e si studiano le scienze e la poesia in siciliano. Anche se vince battaglie importanti come Cortenuova, subisce sconfitte decisive a Parma e Fossalta. Muore nel 1250, e i suoi eredi non riescono a mantenere il potere imperiale.Le sfide al Papato con Bonifacio VIII
Intanto, il Papato, guidato da figure come Bonifacio VIII, afferma di avere il potere più grande (plenitudo potestatis) su tutti i governanti della terra. Questo desiderio di supremazia si scontra però con la crescente forza dei sovrani nazionali. Bonifacio VIII si scontra con i re di Francia e Inghilterra perché vuole tassare il clero (con la bolla Clericis laicos) e dichiara la superiorità del Papa su tutti nella bolla Unam sanctam. La lotta con Filippo IV di Francia arriva al culmine nell’episodio di Anagni nel 1303. Questo evento è un duro colpo per il desiderio del Papato di avere potere universale e avviene poco prima della morte del Papa.Il destino degli Ordini Militari
Anche gli ordini religioso-militari, nati per difendere la Terrasanta durante le Crociate, risentono di questi cambiamenti. Ordini come i Templari e gli Ospitalieri avevano accumulato molto potere e ricchezze. La perdita definitiva della Terrasanta nel 1291, con la caduta di Acri, mette in discussione la loro esistenza. Il re di Francia Filippo IV, per motivi politici ed economici, avvia un processo contro i Templari, accusandoli di eresia. Nonostante il Papa sia contrario, l’ordine viene sciolto nel 1312. Questo dimostra come i sovrani stiano diventando sempre più capaci di intervenire su gruppi legati alla Chiesa.Il risultato di questi scontri è la fine del potere universale di Impero e Papato. Al loro posto, si affermano nuovi equilibri politici. I regni nazionali diventano sempre più importanti e centralizzati. Anche i poteri locali, come i Comuni italiani, guadagnano forza e autonomia. Questo segna un cambiamento profondo nella struttura politica dell’Europa medievale.
Ma come hanno fatto, concretamente, questi “nuovi poteri” a diventare così forti da sfidare e superare Impero e Papato?
Il capitolo descrive lo scontro e il suo esito, ma lascia un po’ nell’ombra i motivi profondi per cui i regni nazionali e i Comuni italiani sono riusciti ad accumulare la forza necessaria per sfidare e ridimensionare le autorità universali. Non basta lo scontro tra figure come Federico II e i pontefici, o Bonifacio VIII e Filippo IV, a spiegare un cambiamento strutturale così radicale. Per capire come questi nuovi poteri si sono rafforzati, è utile approfondire la storia delle istituzioni, l’evoluzione delle finanze statali, la nascita di apparati amministrativi più efficienti e le trasformazioni sociali ed economiche che hanno favorito l’accentramento monarchico e l’autonomia comunale. Approfondimenti sulla formazione dello stato moderno, ad esempio con autori come Joseph Strayer, o sulla complessa realtà politica delle città-stato italiane possono aiutare a colmare questa lacuna.3. Crisi e Trasformazione di Papato e Impero
Tra il Trecento e il Quattrocento le grandi istituzioni universali, come il Papato e l’Impero, attraversano un periodo di profonda crisi, mentre le monarchie nazionali diventano sempre più forti. La sede del papato si sposta ad Avignone tra il 1305 e il 1376, un periodo chiamato “cattività avignonese”. Anche se i papi mantengono una certa indipendenza, risentono molto dell’influenza francese, visibile nella scelta dei cardinali. Durante questo soggiorno, la curia papale si organizza meglio, potenziando i suoi uffici amministrativi e finanziari, accentrando i poteri e aumentando le tasse. Il papato ad Avignone cerca di raggiungere obiettivi importanti come portare la pace in Europa, organizzare crociate e riprendere il controllo dei territori dello Stato della Chiesa. Si scontra duramente con l’Impero, specialmente con Ludovico il Bavaro, rivendicando il diritto di approvare l’elezione dell’imperatore e di nominare rappresentanti in Italia. Nonostante i tentativi di alcuni papi, tornare a Roma è difficile a causa dell’instabilità in Italia e dell’opposizione della Francia. Solo Gregorio XI riporta definitivamente la sede a Roma nel 1377, anche grazie alle pressioni ricevute dall’Italia.Il Grande Scisma d’Occidente
Il ritorno a Roma porta al Grande Scisma d’Occidente, che dura dal 1378 al 1417. Dopo l’elezione di Urbano VI a Roma, una parte dei cardinali elegge un altro papa, Clemente VII, che si stabilisce ad Avignone. La cristianità si ritrova divisa, con due (e poi tre) papi, due curie e due schieramenti politici. Questa crisi profonda favorisce le teorie che sostengono la superiorità di un concilio generale sull’autorità del papa. Il Concilio di Costanza, tenutosi tra il 1414 e il 1418, riesce a porre fine allo scisma eleggendo un unico papa, Martino V. Tuttavia, il papato riafferma con forza la sua autorità, come dimostra la bolla Execrabilis emessa nel 1460.La Situazione dell’Impero Germanico
Nello stesso periodo, l’Impero Germanico è caratterizzato da una monarchia dove l’imperatore viene eletto, una regola confermata ufficialmente dalla Bolla d’Oro nel 1356. Il potere reale è nelle mani dei principi che controllano i vari territori, mentre l’imperatore ha un ruolo più simbolico e di rappresentanza. Durante un periodo in cui il potere imperiale è debole, noto come “grande interregno”, emerge la dinastia degli Asburgo con Rodolfo I. Questa famiglia si concentra sull’allargamento dei propri domini in Austria. Nonostante le difficoltà iniziali nel mantenere la corona imperiale e le resistenze incontrate nell’espansione in Boemia e Svizzera, gli Asburgo riescono gradualmente a rafforzare il loro potere come dinastia, assicurandosi in seguito una successione imperiale continua per molti anni.Quanto è affidabile la nostra ricostruzione della musica e della danza medievale, data la scarsità di notazione?
Il capitolo accenna giustamente al fatto che gran parte della pratica esecutiva si basava sulla tradizione orale. Questo solleva un problema fondamentale: se la notazione era spesso limitata, quanto possiamo essere certi delle nostre interpretazioni moderne? Per affrontare questa lacuna, è cruciale approfondire lo studio critico delle fonti scritte superstiti, come trattati e manoscritti, e considerare le metodologie della performance practice storica. È utile anche esaminare fonti iconografiche e letterarie, e confrontarsi con studi di antropologia sulle tradizioni orali.58. Un Mondo in Trasformazione: Le Dimensioni del Tardo Medioevo
Questo periodo storico è caratterizzato da una complessa organizzazione politica che include diversi tipi di poteri. Esistono regni consolidati e grandi imperi come quello bizantino, destinato a tramontare, e il Sacro Romano Impero Germanico. Si assiste inoltre all’ascesa di una nuova potenza, l’Impero Ottomano. Anche il Papato, pur centrale, deve affrontare numerose sfide sia al suo interno che nei rapporti con gli altri stati. In Italia, in particolare, si osserva una trasformazione significativa, con il passaggio dalle libere città comunali al dominio delle signorie. La società è fortemente divisa in classi: si distinguono la nobiltà, le nuove e dinamiche borghesie cittadine e la vasta popolazione rurale, spesso protagonista di rivolte. La vita di tutti i giorni è scandita anche da pratiche religiose come i pellegrinaggi e da forme di assistenza rivolte ai più poveri.L’Economia del Periodo
L’economia si basa su diverse attività produttive e commerciali. Sono importanti le manifatture, l’estrazione mineraria e la lavorazione dei metalli. Il commercio si sviluppa attraverso le grandi fiere e una rete di vie di comunicazione sempre più efficiente. Crescono l’uso del credito e la circolazione della moneta, strumenti essenziali per gli scambi. Tuttavia, il periodo è segnato anche da crisi profonde, come quella causata dalla Peste Nera, che ha avuto un impatto devastante sulla popolazione e sull’economia.La Sfera Religiosa
La Chiesa Cattolica mantiene un ruolo centrale nella vita delle persone e nella struttura della società. Nonostante la sua autorità, la Chiesa è attraversata da intensi dibattiti teologici e da forti aspirazioni di rinnovamento spirituale. Parallelamente, si diffondono movimenti considerati eretici, spesso perseguitati dall’Inquisizione. Sorgono nuovi ordini religiosi che propongono modelli di vita diversi, e fioriscono esperienze mistiche che cercano un rapporto più diretto con il divino.Cultura, Filosofia e Arte
La cultura trova nei centri universitari luoghi di grande vivacità intellettuale, dove si sviluppa il metodo scolastico basato sul ragionamento e la tradizione del commento dei testi antichi. La filosofia è influenzata dalle correnti aristoteliche e si interroga su temi complessi come l’infinito e le modalità della conoscenza, anche grazie all’incontro con il pensiero islamico ed ebraico. La letteratura è ricca e varia, spaziando dalla poesia lirica all’epica, dal romanzo al teatro. Emergono figure letterarie di statura universale come Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Geoffrey Chaucer. Nel campo dell’arte si afferma lo stile gotico, e si registrano importanti progressi nella pittura e nella scultura, con un riconoscimento crescente del ruolo e del talento dell’artista.Scienza, Tecnica ed Esplorazione
Le conoscenze scientifiche e le applicazioni tecniche compiono passi avanti significativi. Si studiano discipline come l’alchimia, l’astrologia, la fisica, la matematica e la medicina. Vengono introdotte e si diffondono innovazioni che cambiano la vita quotidiana e le attività umane, tra cui l’orologio meccanico, gli occhiali, la bussola per la navigazione e le armi da fuoco. L’interesse per il mondo esterno porta a esplorazioni geografiche e ai viaggi di grandi esploratori, che ampliano notevolmente la conoscenza delle terre lontane.Conflitti e Tensioni
Il periodo è purtroppo segnato da numerosi conflitti che destabilizzano l’Europa e le aree circostanti. Continuano le crociate, spedizioni militari con motivazioni religiose. Si verificano frequenti guerre civili all’interno dei singoli stati e tra le diverse potenze. Un conflitto di lunga durata e particolarmente significativo è la Guerra dei Cent’anni, che coinvolge principalmente i regni di Inghilterra e Francia, ridisegnando la mappa politica del continente.Il capitolo dipinge un quadro ricco, ma quali sono i fili invisibili che legano tra loro le diverse ‘dimensioni’ di questa trasformazione?
Il capitolo elenca una serie di fenomeni e ambiti (politica, economia, società, religione, ecc.) che caratterizzano il Tardo Medioevo. Tuttavia, per comprendere appieno la “trasformazione” del periodo, è cruciale analizzare non solo i singoli elementi, ma anche e soprattutto le loro interconnessioni e le dinamiche causali che li legano. Come l’economia ha influenzato la struttura sociale? In che modo le crisi (come la Peste Nera) hanno impattato la religione e la politica? Per approfondire questi aspetti e cogliere la complessità sistemica del periodo, si potrebbe esplorare la storiografia che analizza le strutture profonde e le interazioni tra i diversi livelli della società medievale, consultando ad esempio le opere di autori come Jacques Le Goff o Georges Duby.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]