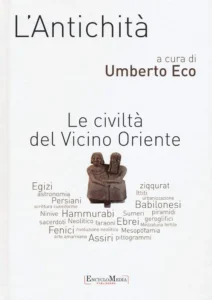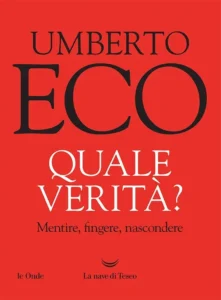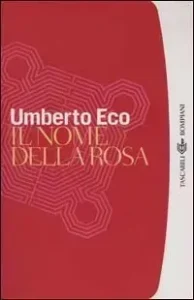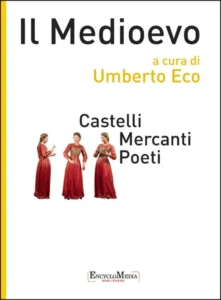Contenuti del libro
Informazioni
non è solo la storia di un impero che crolla, l’Impero Romano, ma di un mondo intero che cambia faccia. Questo libro ti porta in un viaggio attraverso l’Alto Medioevo, un periodo super dinamico dove le migrazioni di popoli come i barbari, gli Unni e poi gli Arabi ridisegnano la mappa dell’Europa e del Mediterraneo. Vedrai nascere i regni romano-barbarici, l’Impero Bizantino lottare per sopravvivere e l’Islam espandersi a velocità incredibile, creando un mondo nuovo da al-Andalus alla Persia. Non è solo una questione di guerre e re, ma anche di fede: il cristianesimo si consolida, il papato a Roma acquista un potere enorme, e il monachesimo diventa un centro di cultura e sapere, salvando un sacco di testi antichi. Ma anche il mondo islamico non scherza, con Baghdad e Cordoba che diventano fari di conoscenza, rielaborando la scienza greca e sviluppando cose come l’alchimia e la medicina. È un’epoca di trasformazioni profonde, dalla vita nelle città e nelle campagne, con la nascita della signoria rurale e del feudalesimo, fino all’arte medievale, all’architettura e alla musica, dove tradizioni diverse si incontrano e si influenzano. Insomma, un periodo pazzesco, pieno di scontri ma anche di scambi culturali incredibili, che getta le basi per l’Europa che conosciamo.Riassunto Breve
La fine dell’Impero romano d’Occidente nel 476 non è un crollo improvviso, ma il punto finale di un lungo processo di trasformazione che porta i territori imperiali a diventare aree autonome e meno legate tra loro. Già dal III secolo si manifestano spinte separatiste e nel IV secolo le usurpazioni locali diventano comuni, mentre rivolte come quelle bagaudiche mostrano tensioni interne. Il potere imperiale contribuisce alla divisione nominando più governanti, e la separazione formale del 395 tra Oriente e Occidente si consolida quando l’Oriente non riconosce l’autorità di Stilicone. In Occidente, la disgregazione è più rapida: la Britannia viene abbandonata, e i regni romano-barbarici nascono da accordi (*foedera*) con Roma, mantenendo spesso strutture amministrative e fiscali romane. L’autorità dei re barbari, inizialmente delegata, diventa indipendente col tempo. Le città non scompaiono ma cambiano, perdendo le vecchie magistrature e vedendo i vescovi assumere un ruolo centrale. Si assiste a uno spostamento di attività economiche e residenze aristocratiche verso le campagne. Il sistema di lavoro agricolo si trasforma, con il declino della villa e la prevalenza del colonato, dove i contadini sono legati alla terra. Le migrazioni di popoli tra IV e V secolo, spinte dall’arrivo degli Unni, rappresentano un momento cruciale. Gruppi germanici come Visigoti, Vandali, Alani e Suebi attraversano i confini imperiali, stabilendosi in Gallia, Spagna e Africa, mentre Angli, Sassoni e Juti occupano la Britannia. In Italia, il potere imperiale si indebolisce fino alla deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre nel 476. Questi popoli migranti subiscono trasformazioni a contatto con il mondo romano, pur mantenendo elementi propri. Successivamente, dal VII secolo, si verifica l’espansione degli Slavi. Popolazioni nomadi dalle steppe asiatiche, come Unni e Avari, arrivano in Europa centrale, mantenendo le proprie tradizioni e spingendo altri popoli verso l’Impero. I Bulgari si fondono con popolazioni slavo-trace e formano un regno stabile. L’indebolimento dell’Impero d’Occidente facilita la formazione di regni barbarici, alcuni con notevole continuità istituzionale (Ostrogoti, Visigoti, Burgundi, Franchi), altri con meno integrazione. Al di fuori dello spazio mediterraneo, popoli come Celti, Scandinavi e Mauri mantengono identità distinte. L’Impero d’Oriente, sotto Giustiniano, tenta di restaurare l’unità romana con campagne militari costose e effimere. Giustiniano riorganizza il diritto romano nel Corpus Iuris Civilis e interviene nelle dispute religiose, ma l’impero è indebolito da guerre, peste e nuove invasioni (Longobardi in Italia, Slavi, Avari, Arabi). L’Impero d’Oriente perde province ricche come Siria ed Egitto a causa dell’invasione araba nel VII secolo. In Occidente, la riconquista bizantina è di breve durata; l’Italia viene invasa dai Longobardi nel 568, che stabiliscono ducati autonomi. Il regno longobardo si consolida, si converte al cattolicesimo e mette per iscritto le leggi, ma l’espansione verso Roma porta il papa a chiedere aiuto ai Franchi. I Franchi, unificati sotto i Merovingi e poi i Carolingi, intervengono in Italia, sconfiggono i Longobardi e cedono terre alla Chiesa romana, segnando l’inizio dello Stato Pontificio. L’incoronazione di Carlo Magno a imperatore nell’800 sancisce la nascita del Sacro Romano Impero e lega strettamente potere laico ed ecclesiastico. L’islam nasce a Mecca nel VII secolo con Maometto e si espande rapidamente sotto i califfi, conquistando vasti territori. Sotto gli Omayyadi, il califfato si struttura amministrativamente, ma divisioni interne portano alla loro caduta per mano degli Abbasidi. Parallelamente, le prime comunità cristiane definiscono la propria dottrina e il canone del Nuovo Testamento, affrontando eresie che mettono in discussione aspetti fondamentali della fede. Il cristianesimo, inizialmente perseguitato, ottiene libertà di culto con Costantino e diventa religione di Stato con Teodosio I, creando un legame stretto tra impero e Chiesa. Dopo la caduta dell’Occidente, la Chiesa a Roma assume funzioni civili e temporali, con figure come Gregorio Magno che gestiscono vasti possedimenti. La donazione di Sutri segna il riconoscimento politico della giurisdizione papale. L’aspirazione universale della Chiesa romana impedisce la formazione di un regno nazionale in Italia. L’unzione dei sovrani franchi da parte dei papi li legittima e li rende protettori della Chiesa. L’evangelizzazione si estende tra i popoli barbari. L’età tardoantica vede un cambiamento nell’istruzione, con la Chiesa che assume un ruolo crescente, specialmente attraverso il monachesimo. I monasteri diventano centri di cultura e formazione, con biblioteche e scriptoria. La dinastia carolingia promuove una riforma dell’istruzione basata sulle scuole monastiche ed episcopali. Contemporaneamente, nell’Impero bizantino, si sviluppa la controversia iconoclasta. Dalla metà del IX secolo, l’Impero bizantino sperimenta una fase di espansione sotto la dinastia macedone, mentre il Califfato Abbaside si frammenta. L’Europa sperimenta una presenza islamica stabile in al-Andalus e in Sicilia, caratterizzate da un notevole connubio culturale. Nel nord della penisola iberica, la resistenza cristiana dà origine a nuovi regni. Il regno dei Franchi sposta il suo centro verso l’Europa continentale e, dopo la morte di Carlo Magno, si divide con il trattato di Verdun nell’843, portando a instabilità e invasioni normanne. Si sviluppa il feudalesimo, un sistema basato sul vassallaggio e la concessione di feudi, che contribuisce alla frammentazione del potere. Il sistema giuridico medievale è caratterizzato da pluralismo, con coesistenza di leggi etniche, consuetudini locali, diritto feudale e diritto canonico. Dopo la deposizione dell’ultimo sovrano carolingio nell’887, il regno d’Italia è conteso tra famiglie aristocratiche, aggravato dalle incursioni di Ungari e Saraceni. Ottone I di Germania interviene, sconfigge i pretendenti e viene incoronato imperatore nel 962, incorporando l’Italia nel Sacro Romano Impero Germanico. Questo periodo di instabilità accelera la frammentazione del potere pubblico e il rafforzamento dei poteri signorili. L’esperienza monastica, con la diffusione della Regola di san Benedetto, diventa predominante e i monasteri acquisiscono importanza economica e sociale. La dissoluzione dell’Impero carolingio causa frammentazione del potere centrale e il papato romano finisce sotto il controllo di famiglie aristocratiche locali. Ottone I promuove una *renovatio imperii* legando potere imperiale e Chiesa e stabilisce il *Privilegium Othonis* per controllare l’elezione papale. Il Medioevo iniziale presenta un paesaggio segnato da un ritiro umano, con vaste aree boschive e una diminuzione della popolazione. L’ambiente diventa prevalentemente rurale, basato sul sistema della *curtis*. Le città si ridimensionano e cambiano funzione. Una crescita demografica riprende gradualmente tra l’VIII e il IX secolo, accelerando dopo il X secolo. Con l’indebolimento del potere pubblico, i grandi proprietari terrieri estendono il loro controllo, passando dalla signoria fondiaria a quella rurale o bannale, accompagnata dalla costruzione di castelli. Il bosco costituisce un elemento centrale per la vita economica e sociale. Gli animali, reali e immaginari, rivestono grande importanza simbolica. L’economia si basa principalmente sulla *curtis*, con scambi limitati. Il commercio su lunga distanza è dominato da mercanti non latini come Ebrei e Arabi, mentre nel Nord Europa emergono Frisoni e Scandinavi. L’Impero Bizantino mantiene un’economia più strutturata con controllo statale sul commercio, ma Venezia emerge come potenza marittima. La fine dell’unità romana porta a una contrazione del commercio mediterraneo, ma porti come Amalfi e Venezia fungono da tramite. L’epoca carolingia vede una ripresa dei traffici. Fra il V e l’XI secolo, la società europea subisce profondi cambiamenti. La posizione delle comunità ebraiche si ridefinisce, avviando un processo di emarginazione. L’aristocrazia si trasforma, legandosi al controllo territoriale e emergendo una nuova élite militare di cavalieri. Si organizza l’assistenza ai poveri, con vescovi e monasteri che assumono un ruolo centrale. La guerra cambia, integrando l’attività militare nella struttura sociale barbarica. L’organizzazione militare romana scompare, sostituita dal “bannum”. Nel regno dei Franchi si sviluppa il sistema vassallatico, che permette di mantenere guerrieri meglio equipaggiati, specialmente cavalieri. Il concetto di “vita religiosa” si evolve, definendosi come uno stato specifico regolato da norme. Nonostante l’idea cristiana di uguaglianza, le donne aristocratiche esercitano potere reale come reggenti o tutrici. La vita materiale nell’alto Medioevo è caratterizzata da condizioni difficili, con insediamenti isolati, abitazioni semplici e alimentazione basata su cereali. Malattie come lebbra ed ergotismo causano sofferenze. Le pratiche sociali e ludiche cambiano, con la cultura cristiana che tende a considerare il tempo libero negativamente, pur persistendo giochi e spettacoli. La conoscenza deriva dai documenti, la cui disponibilità è limitata, e la scrittura è praticata soprattutto da ecclesiastici. Il pensiero di Agostino di Ippona mostra un dialogo tra ragione e fede. Nel Medioevo, il sapere antico viene conservato e trasmesso tramite traduzioni e commentari, influenzato dal neoplatonismo. Figure come Boezio, Cassiodoro e Isidoro di Siviglia sono fondamentali per la trasmissione del sapere greco in Occidente, integrando il sapere pagano nella cultura cristiana. I monasteri diventano centri vitali di studio. La teologia medievale è pervasa da temi escatologici, con l’attesa della fine dei tempi che si intensifica tra X e XI secolo. Nel mondo islamico, la Casa della Sapienza promuove la traduzione di opere greche, e studiosi come al-Khwarizmi e Thabit ibn-Qurra sviluppano matematica e astronomia. La medicina araba sintetizza diverse tradizioni, con Galeno come autorità principale, e si sviluppano ospedali come luoghi di cura e insegnamento. L’alchimia, con radici greche e mistiche, mira a perfezionare la materia e l’uomo, con figure come Jabir ibn Hayyan e al-Razi che mostrano approcci differenti. La tradizione araba ha un ruolo importante nello sviluppo della chimica e della metallurgia, mettendo a punto apparati per la distillazione e tecniche come la coppellazione. Le opinioni sulle arti meccaniche cambiano, superando la svalutazione classica. L’impulso fondamentale arriva dalla civiltà islamica, che arricchisce il sapere antico con contributi originali e nuove tecniche manifatturiere e strumenti. L’Estremo Oriente, in particolare la Cina, raggiunge un alto livello di sviluppo tecnico e scientifico, con Bisanzio che funge da punto di passaggio cruciale. In Occidente, la scienza greca viene vista con sospetto, sviluppando cosmologie alternative basate sulle Scritture. L’esplorazione stimola la conoscenza geografica, rappresentata in mappe simboliche o schematiche. Le *artes liberales* diventano la base dell’istruzione. Giovanni Filopono critica la fisica aristotelica, introducendo concetti come l’*impetus*. La cultura del Medioevo è segnata dal monachesimo, che cerca la perfezione spirituale attraverso la preghiera e lo studio. La trasmissione dei testi classici avviene attraverso il filtro cristiano. La rinascita carolingia promuove lo studio e la conservazione dei testi antichi, standardizza il latino e sviluppa una nuova scrittura. La poesia latina fiorisce, integrando modelli classici e temi locali. La storia è considerata sacra, guidata dalla Provvidenza, e gli storici medievali usano schemi biblici per interpretare le epoche. Si sviluppano generi storiografici come storia, cronaca e annali, e storie etniche per integrare i popoli barbari. La natura è vista in modo simbolico e allegorico, come un linguaggio di Dio. Il meraviglioso è considerato una forma del reale, interpretato come azione divina o demoniaca. La cultura bizantina unisce tradizione classica e cristiana, conservando e rielaborando il sapere antico. La conoscenza dell’Islam in Europa medievale si basa inizialmente su fonti denigratorie, ma dal XII secolo si sviluppa un approccio più strutturato basato su fonti arabe. Il quadro linguistico europeo si definisce con la coesistenza di latino e volgari, che iniziano ad essere attestati per iscritto. La Bibbia è il riferimento principale, con diverse traduzioni e l’esegesi come attività intellettuale centrale. I testi apocrifi influenzano la cultura medievale nonostante le condanne. L’agiografia presenta modelli di santità e le visioni dell’aldilà descrivono paradiso e inferno. Gregorio Magno e Beda il Venerabile sono figure centrali in questi generi. Dal IV secolo compaiono preghiere in poesia cantata, evolute negli inni liturgici. Ambrogio di Milano è centrale per l’innodia latina. In Oriente, la poesia religiosa bizantina innova con l’innografia. Gli spettacoli pagani declinano, ma pratiche come il mimo sopravvivono. Le pratiche dello spettacolo nell’alto Medioevo fondono tradizioni, con feste stagionali che influenzano i rituali cristiani e il recupero del teatro classico nelle scuole vescovili. Lo spazio sacro cristiano si evolve con la costruzione di basiliche e *martyria*, e la venerazione delle reliquie influenza l’architettura. Lo spazio sacro ebraico si trasforma con la costruzione di sinagoghe. Il palazzo è l’edificio centrale per il potere secolare, mentre la Chiesa lega la sua autorità a edifici monumentali. L’arte figurativa mescola tradizione tardoantica e apporti orientali, servendo a veicolare dottrine e messaggi politici. Costantinopoli è dominata dalla rappresentazione del potere imperiale e poi dalla cristianizzazione monumentale. Gerusalemme diventa un centro cruciale per i cristiani, meta di pellegrinaggi. Ravenna si arricchisce di edifici paleocristiani che mostrano una sintesi di influenze. L’arte ottoniana si sviluppa dai modelli carolingi, influenzata dai contatti con Italia e Bisanzio, promuovendo una ricostruzione culturale e legando potere imperiale e Chiesa. La pittura monumentale e i bronzi monumentali sono espressioni importanti di quest’arte. L’arte bizantina in epoca macedone sperimenta una “rinascenza” con un ritorno al gusto classico. La musica è vista sia come scienza matematica che come pratica liturgica. La teoria musicale si fonda sull’opera di Boezio. Queste idee antiche vengono trasmesse nel Medioevo. La riforma carolingia unifica i repertori liturgici con il canto gregoriano e stimola lo sviluppo della notazione musicale. Si sviluppano nuove forme come tropi e sequenze, e appaiono i primi trattati sulla polifonia. La conoscenza degli strumenti musicali medievali deriva principalmente dall’iconografia. Le concezioni del corpo influenzano l’esperienza della danza, vista sia come sede del peccato che come tempio dell’anima. La civiltà medievale è definita “civiltà del gesto”.Riassunto Lungo
1. Un Impero che cambia pelle, non crolla
L’Impero romano d’Occidente non finisce all’improvviso nel 476. Quella data è solo la conclusione di un lungo processo di trasformazione iniziato già nel III secolo. Questo cambiamento porta i territori dell’impero a diventare sempre più indipendenti e meno collegati tra loro. Già nel III secolo nascono spinte alla separazione, con la creazione di regni autonomi come l’impero gallico e quello di Palmira, anche se poi vengono riconquistati. Nel IV secolo, diventa normale che capi locali cerchino di creare regni separati. Rivolte come quelle dei Bagaudi in Gallia mostrano anche tensioni tra popolazioni diverse e contadini contro il governo centrale.La divisione interna dell’Impero
Il potere centrale contribuisce a dividere il territorio. Vengono nominati più governanti per gestire un impero enorme con grandi differenze tra le regioni, soprattutto tra Oriente e Occidente. La divisione ufficiale nel 395 tra i figli dell’imperatore Teodosio rende formale una separazione che esisteva già. Ma la rottura definitiva avviene quando l’Oriente non riconosce l’autorità di Stilicone su tutto l’impero, portando a scontri.La nascita dei regni romano-barbarici
In Occidente, l’impero si sfalda più velocemente. La Britannia viene lasciata a sé stessa nel 410 e arrivano nuove popolazioni. Sul continente, i regni formati dai popoli chiamati ‘barbari’ nascono spesso da accordi con Roma. Questi accordi permettevano ai gruppi barbari di stabilirsi in cambio di aiuto militare. Questa usanza si basa su pratiche romane più antiche di far insediare popolazioni straniere. I re barbari ottengono riconoscimento dall’imperatore romano e spesso ricevono titoli importanti, come quello di comandante dell’esercito. Molte strutture di governo e di tasse romane rimangono in uso. All’inizio, l’autorità di questi re dipende dall’imperatore romano, e solo col tempo diventano davvero indipendenti. Ad esempio, sulle monete si continuano a trovare i nomi degli imperatori. Anche le leggi cercano di mescolare le regole romane con le tradizioni dei popoli barbari.La trasformazione delle città
Le città non spariscono, ma cambiano profondamente. Non hanno più le vecchie cariche di governo, ma i vescovi diventano le figure più importanti e potenti. L’aspetto delle città cambia: si costruiscono nuove mura e edifici religiosi. Anche se perdono l’indipendenza nelle leggi, l’idea che la città sia il simbolo della civiltà rimane forte nel IV secolo. Però, tra il V e il VII secolo, molte attività economiche e le case dei ricchi si spostano verso le campagne. Questo spezza il legame che c’era prima tra la città e la zona intorno. Le diverse funzioni (guidare il territorio, la religione, il commercio) si distribuiscono in luoghi diversi.I cambiamenti nel lavoro agricolo
Anche il modo di lavorare la terra cambia. Il modello delle grandi proprietà (ville) con molti schiavi usate per produrre e vendere merci diminuisce dopo il III secolo. Nella tarda antichità diventa più comune il colonato: i contadini, che potevano essere liberi o schiavi, lavorano piccoli appezzamenti di terra e sono legati a quella terra, spesso per motivi legati alle tasse. Questo legame alla terra passa dai genitori ai figli. La situazione dei coloni è diversa tra Oriente e Occidente. È importante sapere che questo ‘colonato’ non è la stessa cosa della ‘servitù della gleba’ del Medioevo. Quest’ultima è un concetto legale che nasce dopo e non descrive bene le tante forme di dipendenza che esistevano all’inizio del Medioevo.Se l’Impero cambia pelle, ma non crolla, quale ruolo ha avuto la Chiesa in questa ‘nuova pelle’?
Il capitolo accenna al crescente potere dei vescovi, ma sorvola sul ruolo politico, economico e culturale fondamentale che l’istituzione ecclesiastica nel suo complesso ha giocato nel processo di trasformazione dell’Impero d’Occidente. La Chiesa non fu solo un sostituto delle vecchie magistrature cittadine, ma spesso l’unica struttura organizzata capace di interagire con le nuove realtà dei regni romano-barbarici, preservando elementi della tradizione romana e mediando tra diverse popolazioni. Per comprendere appieno questa ‘nuova pelle’ dell’Europa occidentale, è indispensabile approfondire la storia della Chiesa tardoantica e altomedievale. Discipline come la patristica e la storia sociale della tarda antichità sono essenziali, e autori come Peter Brown o Henri Pirenne offrono spunti di riflessione, sebbene le loro tesi siano state oggetto di dibattito.2. Popoli in movimento e il crollo dell’Occidente
Le migrazioni di popoli tra il IV e il V secolo rappresentano un momento cruciale nel lungo confronto tra società nomadi e sedentarie. Questo periodo vede enormi masse di persone spostarsi attraverso l’Europa, mettendo sotto pressione i confini degli imperi esistenti. L’Impero romano, in particolare, che era una vasta area di stabilità basata sull’agricoltura e su un sistema politico centralizzato, si trova a dover reagire alla spinta di gruppi che arrivano da nord e est. Dopo periodi di tensione ai confini, la grande migrazione vera e propria inizia nel 375 dalla regione danubiana. Questo massiccio spostamento di popoli porterà alla fine del potere unitario romano in Occidente entro un secolo.I Popoli Germanici e i Confini dell’Impero
I popoli germanici provengono originariamente dalla Scandinavia meridionale e dalla penisola danese. Si sono espansi gradualmente, raggiungendo il Reno e il Danubio, fiumi che sono diventati i confini, chiamati limes, dell’Impero romano. Già dal II secolo a.C. si registrano scontri tra queste popolazioni e i Romani, ma le pressioni sui confini aumentano notevolmente nel III secolo. Gruppi come Goti, Alamanni, Franchi e altri iniziano a effettuare incursioni più frequenti. L’esercito romano, per far fronte a questa situazione, comincia a includere sempre più persone di origine barbarica, e alcuni di questi gruppi vengono anche insediati come coloni all’interno del territorio imperiale.L’Arrivo degli Unni e la Grande Migrazione
Un cambiamento profondo e decisivo avviene a metà del IV secolo con l’arrivo degli Unni, un popolo nomade proveniente dall’Asia centrale. La loro avanzata spinge altri popoli verso ovest, innescando così la grande migrazione che cambierà il volto dell’Europa. I Visigoti, in particolare, fuggono dalla pressione degli Unni e nel 375 chiedono di potersi stabilire all’interno dell’Impero romano. La gestione di questo insediamento si rivela difficile e porta alla sconfitta dell’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli nel 378. Nonostante successivi accordi che permettono insediamenti, la crescente debolezza imperiale non riesce a fermare le incursioni. Un evento significativo è il saccheggio di Roma da parte dei Visigoti nel 410, prima che si stabiliscano in Gallia e in Spagna.Le Invasioni e il Crollo dell’Impero d’Occidente
Un altro momento cruciale per l’Occidente è il 31 dicembre 406. In quella data, gruppi come Alani, Vandali e Suebi attraversano il fiume Reno, ghiacciato in quell’inverno. Questi popoli si diffondono prima in Gallia e poi raggiungono la Spagna. I Vandali, in particolare, attraversano lo stretto di Gibilterra e passano in Africa nel 429, dove creano un regno potente che rappresenta una seria minaccia per l’Impero. Nel frattempo, altri gruppi come i Burgundi si insediano in Gallia, mentre Angli, Sassoni e Juti occupano la Britannia, isolandola dal continente. In Italia, il potere imperiale si indebolisce progressivamente, finendo per essere controllato da generali di origine barbarica. Questa situazione culmina nel 476, quando il generale Odoacre depone l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augustolo. Odoacre decide di non nominare un nuovo imperatore, segnando così la fine formale della parte occidentale dell’Impero romano.Le Trasformazioni dei Popoli Migranti
I popoli che migrano, specialmente i Germani, non rimangono immutati a contatto con il mondo romano. Subiscono profonde trasformazioni nella loro economia e organizzazione sociale. Molti passano da strutture tribali a monarchie militari, più adatte a gestire i nuovi territori e i rapporti con le popolazioni residenti. Anche il loro diritto si modifica, pur mantenendo alcuni elementi delle tradizioni proprie. Per quanto riguarda la religione, le loro credenze pagane lasciano alcune tracce nella cultura popolare, ma il cristianesimo si diffonde ampiamente tra queste popolazioni. Spesso, la forma di cristianesimo che adottano inizialmente è quella ariana, che differisce dall’ortodossia cattolica.L’Espansione dei Popoli Slavi
Successivamente, a partire dal VII secolo, si assiste a un’altra importante fase di migrazioni: l’espansione dei popoli slavi. Questi gruppi si spostano dall’Europa centro-orientale verso diverse direzioni. Anch’essi hanno caratteristiche proprie nel modo di insediarsi e nella loro economia, che si basa principalmente sull’allevamento e su un tipo di agricoltura estensiva. La loro struttura sociale è inizialmente di tipo tribale. La conversione al cristianesimo avviene più tardi rispetto ai Germani e porta a una divisione significativa. Alcuni gruppi slavi adottano il rito romano (cattolicesimo), mentre altri si convertono al rito ortodosso, una distinzione che sarà influenzata e rafforzata dalle dinamiche politiche e culturali tra l’Europa occidentale e l’Impero Bizantino.Davvero le “migrazioni” bastano a spiegare il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, o il capitolo trascura le sue profonde crisi interne?
Il capitolo pone l’accento sullo spostamento dei popoli come causa principale della fine dell’Impero in Occidente, ma questa visione rischia di essere riduttiva. La caduta di Roma fu un processo complesso, influenzato tanto dalle pressioni esterne quanto da una serie di debolezze strutturali interne all’Impero stesso: problemi economici, instabilità politica, difficoltà fiscali e militari croniche. Le migrazioni furono un fattore determinante, ma agirono su un organismo già indebolito da decenni, se non secoli, di crisi. Per una comprensione più completa, è essenziale approfondire la storia sociale, economica e istituzionale del tardo Impero Romano. Autori come Peter Brown o Chris Wickham offrono prospettive che evidenziano la complessità e la lunga durata delle trasformazioni che portarono alla fine del potere imperiale in Occidente.3. Popoli in Movimento e Nuovi Regni
Tra il IV e il VI secolo, l’Europa centrale vede l’arrivo di popolazioni nomadi dalle vaste steppe asiatiche. Tra queste, spiccano gli Unni, gli Avari e i Bulgari. A differenza dei popoli germanici, che in molti casi cercarono forme di integrazione con la cultura romana, questi nuovi arrivati tendono a mantenere con forza le proprie tradizioni, venendo percepiti come estranei e spesso pericolosi dalle popolazioni locali e dall’Impero.L’arrivo dalle steppe: Unni e Avari
Gli Unni giungono in Europa a metà del IV secolo. La loro pressione sulle popolazioni che vivono lungo il Mar Nero e il fiume Danubio innesca un vasto spostamento di genti, un vero e proprio “effetto domino”. Questo spinge i popoli germanici a cercare rifugio o nuove terre all’interno dei confini dell’Impero Romano, portando a violazioni delle frontiere e alle grandi migrazioni che segnano il V secolo. Sotto la guida di Attila, l’impero unno si pone in diretta contrapposizione a Roma. La relazione è fatta di guerre, ma anche di una diplomazia basata sul pagamento di tributi da parte romana. Attila lancia attacchi significativi in Occidente, prima in Gallia nel 451, nella battaglia dei Campi Catalaunici, e poi in Italia nel 452. Tuttavia, questi successi non portano a conquiste durature. Dopo la morte di Attila nel 453, l’impero unno si disgrega rapidamente, scomparendo di fatto nel 455.Circa cento anni dopo l’esperienza unna, gli Avari stabiliscono un impero che occupa territori simili. Anch’essi provengono dalle steppe e sono maestri nell’uso della cavalleria, innovando con l’introduzione della staffa, che migliora la stabilità del cavaliere. Si insediano stabilmente nel bacino dei Carpazi a partire dal 568. Da questa posizione, sottomettono le popolazioni circostanti, inclusi diversi gruppi slavi e parte dei popoli germanici, come i Longobardi, prima che questi scendano in Italia. Gli Avari lanciano attacchi frequenti contro l’Impero bizantino nei Balcani. Il loro potere subisce un colpo durissimo dopo il fallito assedio di Costantinopoli nel 626. La loro storia come potenza dominante si conclude alla fine dell’VIII secolo, quando vengono sconfitti e distrutti dalle campagne militari di Carlo Magno.I Bulgari: un regno duraturo
Un altro popolo di origine turco-mongola, i Bulgari, riesce a liberarsi dal dominio degli Avari a metà del VII secolo. Si spostano verso sud, attraversando il Danubio. Qui, si fondono gradualmente con le popolazioni locali di origine slava e trace, finendo per assimilare la cultura slava. Questa fusione dà vita a un regno potente e organizzato, capace di resistere ai tentativi di conquista da parte dell’Impero bizantino. Un passaggio cruciale nella storia bulgara è la conversione del re Boris al cristianesimo ortodosso nell’864. Questo evento lega culturalmente e religiosamente il regno bulgaro alla sfera di influenza bizantina. A differenza degli imperi effimeri di Unni e Avari, i Bulgari riescono a costruire un regno stabile e duraturo nei Balcani.I Regni Romano-Barbarici in Occidente
Parallelamente all’arrivo dei popoli dalle steppe, l’Impero Romano d’Occidente attraversa un profondo processo di indebolimento interno. Questo facilita l’insediamento di vari popoli germanici all’interno dei suoi confini. Inizialmente, molti di questi gruppi vengono accolti come alleati, i cosiddetti foederati, a cui viene concesso di stabilirsi in cambio di servizio militare. Tuttavia, la crisi crescente dell’autorità centrale romana e l’infiltrazione progressiva di militari di origine germanica nelle alte sfere dell’esercito imperiale aprono la strada alla formazione di veri e propri regni barbarici nel corso del V secolo.Questi nuovi regni mostrano gradi diversi di interazione con l’eredità romana. Alcuni, come i regni degli Ostrogoti in Italia, dei Visigoti in Gallia e poi in Spagna, dei Burgundi e dei Franchi, mantengono una notevole continuità con le istituzioni amministrative e l’aristocrazia romana preesistente. In questi regni, si assiste anche alla redazione di leggi scritte che combinano elementi germanici e romani. Altri regni, come quelli degli Alemanni e dei Bavari in aree più periferiche, dei Vandali in Nord Africa e degli Anglo-Sassoni in Britannia, mostrano invece un’integrazione minore con le strutture e la cultura romana. Molti di questi regni romano-barbarici soffrono di debolezze interne, spesso legate a conflitti dinastici o tensioni religiose tra le popolazioni germaniche (spesso ariane) e quelle romanze (cattoliche). Questa fragilità li rende vulnerabili. Nel VI secolo, l’Impero bizantino, sotto l’imperatore Giustiniano, lancerà campagne militari che porteranno alla riconquista di vaste aree, come l’Italia, il Nord Africa e parte della Spagna visigota.Altre realtà al di fuori dell’Impero
Al di fuori dello spazio direttamente controllato o profondamente influenzato dall’Impero Romano e Bizantino, diverse popolazioni mantengono identità e percorsi distinti. Nelle isole britanniche, i Celti, in particolare in Irlanda, non vengono mai romanizzati in modo significativo. L’Irlanda diventa un importante centro di monachesimo e cultura latina, da cui partono missionari che contribuiscono alla diffusione del cristianesimo e del sapere in diverse aree d’Europa. Nella penisola scandinava, si sviluppano prosperi regni tribali. Queste società nordiche, con la loro abilità nella navigazione, saranno all’origine delle incursioni vichinghe che, a partire dalla fine dell’VIII secolo, avranno un impatto notevole su molte coste e regioni interne d’Europa. Nel Nord Africa, le popolazioni locali dei Mauri resistono a lungo al pieno controllo romano. Essi riescono a formare regni locali che si oppongono sia ai Vandali, che conquistano la regione nel V secolo, sia ai Bizantini, che la riconquistano nel VI secolo. La loro resistenza continua fino all’arrivo e alla successiva sottomissione da parte delle forze islamiche nel VII secolo.Se la musica medievale si fondava sull’armonia cosmica e i rapporti numerici, come si spiega l’emergere della polifonia, un fenomeno che sembra più legato all’ingegno umano e alle esigenze pratiche che alle sfere celesti?
Il capitolo presenta la teoria musicale medievale partendo dai fondamenti matematici e filosofici ereditati dall’antichità, per poi descrivere lo sviluppo del canto gregoriano, della notazione e l’apparizione della polifonia. Tuttavia, il legame diretto tra la visione teorica della musica come scienza dei numeri e armonia universale e la nascita concreta della polifonia non viene esplicitato a sufficienza. La transizione dalla monodia alla sovrapposizione di voci è un passaggio cruciale nella storia della musica occidentale, influenzato da molteplici fattori che vanno oltre la mera applicazione di rapporti numerici. Per comprendere meglio questo sviluppo e il suo rapporto (o la sua distanza) con le teorie cosmologiche iniziali, è opportuno approfondire la storia delle forme musicali e della composizione nel Medioevo, consultando studi sulla polifonia antica e autori come Gustave Reese o Richard Hoppin.46. L’Eco Visibile del Medioevo: Strumenti e Gesti
La conoscenza degli strumenti musicali usati nel Medioevo arriva soprattutto dalle immagini che ci sono rimaste, perché pochi strumenti originali sono arrivati fino a noi. Le raffigurazioni nell’arte non sono fotografie precise, ma mostrano come l’artista vedeva la musica, spesso mescolando idee storiche, religiose e culturali. Gli artisti che dipingevano questi strumenti di solito non erano musicisti. Nelle opere d’arte sacra, la musica serviva a toccare l’anima delle persone che guardavano. Spesso si vedono “orchestre di angeli” con tanti strumenti diversi, un’immagine che trova giustificazione nel Salmo 150 della Bibbia. Le liste di strumenti che si trovano nella Bibbia sono spesso generali e parlano di categorie come strumenti a fiato, a percussione o a corde. Le immagini nell’arte ci danno un quadro visivo, anche se queste rappresentazioni riprendono spesso tradizioni molto antiche.Gli Strumenti Musicali
Tra gli strumenti a corda che si suonavano con l’arco c’erano la viola, che veniva costruita in modo semplice come una tavola, la viella, che aveva i piroli (i perni per accordare) a forma di freccia, e la ribeca, uno strumento scavato da un unico pezzo di legno, che veniva dai paesi arabi. Gli strumenti a corda che si suonavano pizzicando le corde erano molto diffusi, come la citara e il liuto. Anche il liuto era di origine araba e lo si riconosce dalla cassa fatta di doghe (listelli curvi) e dal manico piegato all’indietro. La mandola era una versione più piccola del liuto.I fiati comprendevano le trombe, lo shofar (un corno di animale usato in contesti religiosi) e strumenti che usavano un’ancia, simili all’antico aulos greco, oltre ai flauti di vario tipo. L’organo portativo, una versione piccola che si poteva trasportare, appare spesso nelle immagini sacre ed era visto come un simbolo del potere divino. L’organistrum, o ghironda, era uno strumento che produceva suono sfregando le corde con una ruota. Tra le percussioni c’erano vari tipi di tamburi e campane. Il salterio, uno strumento a corde pizzicate spesso associato al re David, era molto importante e rappresentato.
Il Corpo, il Gesto e la Danza
Il modo in cui si pensava al corpo nel Medioevo, specialmente nell’alto Medioevo, cambiava anche il modo di vivere la danza. C’era un contrasto forte: da un lato si condannava il corpo e i suoi desideri, dall’altro lo si vedeva in modo positivo. Il cristianesimo affrontava il tema del corpo considerandolo sia la fonte del peccato sia il luogo sacro dove risiede l’anima. Il corpo veniva capito in relazione all’anima; per questo, un gesto fatto con il corpo diventava la manifestazione visibile di ciò che c’era nell’anima e un modo per controllare e disciplinare se stessi.La società medievale viene definita una “civiltà del gesto” perché i gesti erano fondamentali per stabilire i rapporti tra le persone e mostrare le differenze di posizione sociale. I capi della Chiesa e le regole dei monasteri stabilivano quali gesti erano considerati giusti e corretti. Accanto ai gesti di rinuncia e disciplina (ascetici), c’era anche un tipo di “gesticolare santo” che includeva la danza e la musica. Nell’arte, il corpo medievale diventava esso stesso un gesto pieno di significato.
La danza risentiva di queste idee sul corpo. Si praticava in diversi luoghi e spazi, e si muoveva tra due esempi opposti presi dalla Bibbia: il pio re David che danza in modo sacro e la malvagia Salomè. Questa visione ambivalente del corpo si rifletteva nella danza, che riusciva a esprimere il legame tra ciò che è elevato e spirituale e ciò che è terreno e materiale.
Ma davvero possiamo parlare di una “civiltà del gesto” coerente, quando il capitolo stesso descrive una visione del corpo così lacerata tra sacro e profano?
Il capitolo introduce il concetto di una “civiltà del gesto” ma non approfondisce sufficientemente come questa si manifestasse concretamente e quali conflitti sorgessero dalla coesistenza di gesti sociali, liturgici e quelli legati a una visione ambivalente del corpo. Per comprendere meglio questa complessità, sarebbe utile esplorare studi sulla storia sociale del Medioevo, l’antropologia del gesto e la storia della mentalità. Autori come J. Le Goff o A. Gurevich hanno analizzato in profondità questi aspetti della cultura medievale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]