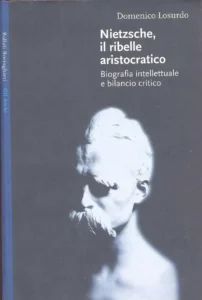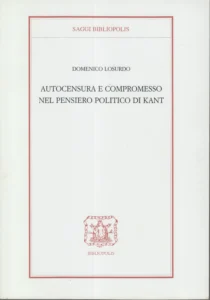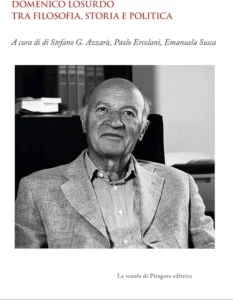1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere” di Domenico Losurdo è un libro che ti fa vedere la storia del marxismo globale da una prospettiva diversa. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre e la Prima Guerra Mondiale, il marxismo si è diviso in due strade: una in Occidente, più concentrata sulla critica della guerra e dello stato, a volte quasi anarchica, e una in Oriente, soprattutto in Asia, dove la lotta principale era contro il colonialismo e per l’indipendenza nazionale. Losurdo ti spiega come questo marxismo “orientale”, con figure come Lenin, Mao Zedong e Togliatti, ha messo al centro la lotta anticoloniale e la necessità di costruire stati forti e sviluppati per resistere all’imperialismo. Critica invece il marxismo occidentale e la “teoria critica”, mostrando come pensatori anche famosi come Hannah Arendt o Michel Foucault abbiano spesso ignorato o minimizzato la questione coloniale e il razzismo, che invece sono stati centrali nella storia del capitalismo e delle lotte per l’emancipazione. Il libro ti fa capire che per il marxismo occidentale, se vuole rinascere, è fondamentale smettere di ignorare queste lotte reali e concrete che hanno segnato il Novecento e continuano a essere importanti oggi.Riassunto Breve
La diffusione globale del marxismo tra il 1914 e il 1917, con la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre, ha portato a una divisione tra le sue forme in Occidente e in Oriente. In Occidente, la spinta principale è il rifiuto della guerra e dello stato militarista, generando una critica radicale del sistema politico-sociale responsabile della carneficina. Alcuni pensatori vedono l’economia del denaro e la tecnica come strumenti di dominio e oppressione, cercando una liberazione totale e sviluppando speranze utopistiche o messianiche. In Oriente, specialmente in Asia, la Rivoluzione d’Ottobre rappresenta una svolta per la lotta contro l’oppressione colonialista. Il marxismo-leninismo è visto come uno strumento per la liberazione nazionale e la costruzione di uno stato indipendente, con un approccio pragmatico verso economia, scienza e tecnica, considerate essenziali per lo sviluppo e la resistenza. La lotta per il riconoscimento in Occidente si concentra sulla polarizzazione sociale interna e l’insufficienza dell’eguaglianza formale, mentre in Oriente è primariamente una reazione all’oppressione coloniale, combattendo la de-umanizzazione e l’umiliazione nazionale. Lenin riconosce l’importanza crescente delle lotte anticoloniali come parte integrante della lotta contro l’imperialismo, ampliando il motto rivoluzionario ai popoli oppressi. Le grandi guerre della metà del Novecento sono viste come guerre nazionali e anticoloniali. Nei paesi meno sviluppati, la modernizzazione e lo sviluppo economico diventano prioritari per garantire una reale indipendenza contro il neocolonialismo, una prospettiva che si distingue da parte del marxismo occidentale, spesso concentrato su dinamiche interne o questioni teoriche astratte. Molte correnti di pensiero occidentali mostrano un “angolo cieco” sulla questione coloniale e razziale, trascurando le radici coloniali di concetti come la biopolitica e il totalitarismo e non riconoscendo il ruolo cruciale delle lotte per il riconoscimento da parte di gruppi de-umanizzati. Questo porta a visioni incomplete del capitalismo e delle sue manifestazioni più brutali. Il marxismo occidentale, spesso distante dal potere statale e concentrato sulla critica o su ideali astratti, fatica a comprendere la fase di edificazione economica e tecnologica necessaria per consolidare l’indipendenza dopo la lotta politica, come avviene in paesi come Cina e Vietnam. Questa distanza dal reale si manifesta nell’incapacità di analizzare adeguatamente le dinamiche neocoloniali contemporanee e le guerre che ne derivano. La scissione globale del marxismo deriva da queste diverse priorità e prospettive, con l’Oriente impegnato nel completamento della rivoluzione anticoloniale tramite lo sviluppo economico e l’Occidente spesso bloccato in dibattiti teorici o critiche astratte, perdendo di vista il contributo storico del comunismo alla fine del sistema colonialista e la necessità di confrontarsi con le lotte di emancipazione concrete nel mondo reale.Riassunto Lungo
1. Due Vie del Marxismo Globale
Tra il 1914 e il 1917, due grandi eventi cambiano il mondo: la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre. In questo periodo, il pensiero di Marx si diffonde in molti paesi, ma prende strade diverse. In Occidente e in Oriente, le persone si avvicinano a queste idee per ragioni differenti e le interpretano in modi specifici.Il Marxismo in Occidente
In Europa e in Occidente, la ragione principale per cui le persone si interessano al comunismo è il forte rifiuto della guerra. La violenza e le morti terribili del conflitto mondiale causano un grande senso di disgusto e rabbia. Pensatori importanti come György Lukács e Ernst Bloch vedono nella Rivoluzione d’Ottobre una speranza. Sperano che possa nascere un sistema diverso da quello che, secondo loro, ha portato alla guerra, vista come un errore morale gravissimo. L’orrore per la guerra totale e per il potere militare dello Stato li porta a criticare duramente lo Stato stesso, che vedono come uno strumento usato per obbligare le persone e per fare violenza. Alcuni di questi pensatori arrivano a idee molto simili a quelle dell’anarchismo, rifiutando l’idea di nazione e di uno stato basato sulla forza militare.Il Marxismo in Oriente
In Oriente, specialmente nei paesi dell’Asia, la Prima Guerra Mondiale non ha avuto lo stesso tipo di impatto. Qui, le persone soffrono già da molto tempo a causa del sistema basato sul denaro e sulle colonie, che porta oppressione e violenza. Esempi di questa sofferenza sono le Guerre dell’Oppio in Cina. La Rivoluzione d’Ottobre è vista come un momento di svolta molto importante. Questo evento promette di mettere fine al dominio e alla schiavitù imposti dalle potenze coloniali. Capi e pensatori come Sun Yat-Sen e Ho Chi Minh capiscono che le idee di Marx e Lenin possono essere uno strumento potente. Le usano per lottare per la libertà della loro nazione e per costruire uno Stato indipendente. La lotta contro chi vuole imporre il proprio dominio e il desiderio di essere riconosciuti come nazione diventano centrali. Amare la propria patria non è visto come qualcosa di contrario all’idea di unione tra i popoli, ma come il modo pratico per combattere chi ha stabilito le colonie. Il grande desiderio è quello di farla finita con l’essere trattati male e disprezzati dalle potenze straniere.Il capitolo riduce l’adesione al marxismo a una reazione morale alla guerra in Occidente e a una lotta anticoloniale in Oriente. Ma dove finisce la lotta di classe?
Il capitolo, pur offrendo una dicotomia interessante, rischia di trascurare il motore fondamentale del pensiero marxista: la lotta di classe. Presentare l’adesione a queste idee in Occidente quasi esclusivamente come rifiuto morale della guerra e in Oriente come mero strumento anticoloniale semplifica eccessivamente dinamiche complesse. Per comprendere appieno la diffusione del marxismo in quel cruciale periodo, è indispensabile approfondire sia i testi fondativi di autori come Marx e Lenin, sia gli studi storici che analizzano come le categorie di classe si siano intrecciate con le specifici contesti nazionali e internazionali, al di là delle sole reazioni alla guerra o al colonialismo.2. Contrasti rivoluzionari: denaro, scienza e messianismo
Dopo la Prima Guerra Mondiale, le idee rivoluzionarie in Occidente e in Oriente prendono strade molto diverse, soprattutto riguardo al ruolo dell’economia, della scienza e della tecnica nella società.La visione occidentale
In Occidente, l’economia basata sul denaro e la mentalità mercantile sono viste come la causa principale dei problemi e del materialismo diffuso. C’è un forte desiderio di liberarsi completamente dall’economia e dagli interessi legati alle classi sociali. L’economia non è vista come qualcosa da cambiare, ma come una forza pericolosa da eliminare del tutto. Anche la scienza e la tecnica sono considerate strumenti di controllo, usati per fare guerre e opprimere le persone, parte di un grande sistema statale che porta distruzione. La crisi economica del 1929 conferma questa idea: il progresso tecnico non porta libertà, ma disoccupazione, trasformando l’operaio in una semplice parte di una macchina. Questa visione riprende idee anarchiche che rifiutano la scienza quando è legata al potere e allo sfruttamento.La visione orientale
In Oriente, specialmente in Cina e Indocina, l’approccio all’economia, alla scienza e alla tecnica è differente. L’economia basata sul denaro e il commercio sono considerati necessari per sopravvivere e resistere contro l’oppressione. Scienza e tecnica sono viste come strumenti essenziali per far crescere il paese e per la lotta tra le classi sociali. Chi porta avanti la rivoluzione in Oriente studia la tecnologia occidentale proprio per usarla contro i colonizzatori. Qui non si cerca di rompere completamente con il passato, ma piuttosto di andare oltre, mantenendo e migliorando le capacità di produrre.Differenze nel messianismo
Questa differenza di vedute si manifesta anche nel modo in cui si guarda al futuro e a un possibile cambiamento radicale, una sorta di “messianismo”. In Occidente, le grandi crisi della storia e la tradizione religiosa portano ad aspettare una salvezza totale, un mondo completamente nuovo e libero dal male. Questo tipo di attesa influenza alcune idee del marxismo occidentale, che si caricano di speranze utopistiche e messianiche. In Oriente, invece, la cultura e le esperienze storiche portano a un modo di affrontare la rivoluzione e la costruzione della società più concreto e meno legato all’attesa di un cambiamento miracoloso.Ma davvero il capitolo pretende di racchiudere la vastità e le contraddizioni del pensiero rivoluzionario post-bellico in una dicotomia così semplicistica tra un ‘Occidente’ monolitico e un ‘Oriente’ altrettanto uniforme?
Il capitolo presenta una divisione molto netta tra le visioni rivoluzionarie in Occidente e Oriente, che rischia di ignorare la molteplicità di posizioni e dibattiti interni sia in Europa che in Asia nel periodo considerato. Non tutti in Occidente rifiutavano in blocco scienza ed economia, né tutti in Oriente le abbracciavano acriticamente. Esistevano diverse correnti di pensiero, anche radicali, con approcci sfumati o addirittura opposti a quelli descritti come prevalenti. Per comprendere meglio queste complessità, sarebbe utile approfondire la storia intellettuale e politica del periodo in diverse aree geografiche, studiando le specifiche declinazioni dei movimenti rivoluzionari. Approfondire autori che hanno analizzato la storia delle idee politiche e sociali nel XX secolo, o storici delle diverse rivoluzioni e dei movimenti anti-coloniali, può fornire una visione più sfaccettata e meno generalizzante.3. La Duplice Battaglia per il Riconoscimento
Il capitalismo e l’imperialismo creano grandi differenze e ingiustizie. Le critiche a questo sistema e la lotta per avere gli stessi diritti prendono strade diverse in Occidente e in Oriente.La Lotta in Occidente
Nei paesi occidentali, l’attenzione è sulla divisione che esiste all’interno della società. Avere gli stessi diritti solo sulla carta, per legge, non basta. Le leggi sembrano proteggere gli interessi di chi ha il potere. Un esempio è che sia i ricchi che i poveri non possono rubare legna o dormire per strada, ma questa regola colpisce in modo diverso chi non ha niente. Questa analisi spesso guarda solo alla situazione dei lavoratori e delle persone comuni in Europa, dimenticando quello che succede nelle colonie.La Lotta in Oriente
Nei paesi orientali, la lotta per l’uguaglianza nasce soprattutto come reazione al dominio coloniale. L’ingiustizia non è solo una questione di leggi, ma è una realtà di tutti i giorni. I popoli colonizzati non hanno nemmeno le garanzie legali più semplici. Subiscono povertà, fame e vengono arrestati senza motivo, mentre i colonizzatori e quelli che si comportano come europei hanno molti privilegi. Liberarsi significa ottenere riconoscimento non solo per la singola persona, ma per l’intera nazione. Si combatte contro l’umiliazione nazionale, gli accordi non equi e il fatto che gli stranieri possano vivere con le loro regole, quasi fossero uno stato a parte dentro il paese.La Posizione della Russia Sovietica
La Russia sovietica si trova in una situazione particolare, di passaggio. All’inizio, si aspettava una rivoluzione che cambiasse tutto il mondo e facesse sparire le nazioni. Però, dover costruire e guidare uno stato in un paese poco sviluppato ha richiesto di imparare in fretta e cambiare idea. Leader come Lenin sono passati da grandi idee teoriche a concentrarsi sulla costruzione dello stato e sull’uso attento di alcune tecniche tipiche del capitalismo. Questo cambiamento mostra una difficoltà interna: da una parte si guardava alla rivoluzione in Occidente, dall’altra si doveva dare priorità alla costruzione del proprio paese. Questo creava visioni diverse tra i capi del partito.Le Due Battaglie per il Riconoscimento
Emergono così due tipi di lotta per essere riconosciuti. Una è quella delle nazioni che subiscono il dominio coloniale e combattono per non essere trattate come meno che umane. L’altra è quella dei lavoratori che non vogliono essere solo forza lavoro usata dalle classi più ricche. Queste lotte, pur guardando allo stesso sistema di potere, lo vedono da punti di vista diversi. Per questo, capirsi e sostenersi a vicenda completamente non è qualcosa che accade da solo, ma richiede sforzo e comprensione.Se il marxismo occidentale è così distante dal reale, come suggerisce il capitolo, quali sono le specifiche ragioni storiche e teoriche di questo presunto distacco?
Il capitolo presenta una dicotomia netta tra due modi di intendere il marxismo, ma non approfondisce le cause storiche e intellettuali che avrebbero portato il marxismo occidentale a concentrarsi su ideali astratti o futuri lontani, piuttosto che sulle lotte concrete. Questa mancanza di contesto rende l’argomentazione meno convincente. Per comprendere meglio questa dinamica, sarebbe utile esplorare la storia del pensiero marxista nel XX secolo, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, e le specifiche condizioni socio-economiche dei paesi occidentali sviluppati. Approfondire autori associati al cosiddetto “marxismo occidentale”, come Horkheimer, Adorno, Marcuse o Althusser, può aiutare a capire le loro preoccupazioni teoriche e come queste si relazionassero (o meno) con le lotte politiche del loro tempo.18. La Scissione Globale del Marxismo
L’espansione del marxismo, nato in Occidente, in diverse parti del mondo ha portato a una netta divisione tra le sue forme. Esiste un marxismo occidentale e uno orientale. Il marxismo occidentale è profondamente influenzato dalla tradizione ebraico-cristiana e incorpora aspetti messianici, quasi come se il comunismo fosse la fine dei conflitti e della storia stessa. Nelle culture orientali, come quella cinese, l’attenzione è invece molto più rivolta alla realtà concreta e sociale, e questa idea di un futuro messianico non è presente.Un confronto storico con il Cristianesimo
Un processo simile a questa divisione si è già visto nella storia con la diffusione del cristianesimo. In Cina, ad esempio, i missionari gesuiti furono inizialmente accolti favorevolmente. Questo accadde perché mostravano grande conoscenza e una notevole capacità di adattarsi alla cultura locale, arrivando persino a onorare Confucio e il culto degli antenati. Tuttavia, quando il papa intervenne per imporre l’ortodossia e difendere la dottrina europea, l’imperatore cinese decise di respingere il cristianesimo. La religione fu percepita come un elemento estraneo e destabilizzante nel momento in cui smise di rispettare la cultura e i legami sociali già radicati nel paese.La “sinificazione” del Marxismo in Cina
Anche il marxismo ha vissuto un’esperienza simile. In Cina, il Partito Comunista ha attivamente promosso la “sinificazione del marxismo”. Questo significa che il marxismo è stato adattato per servire obiettivi specifici del contesto cinese, come la liberazione nazionale, lo sviluppo economico e il rinnovamento del paese dopo un lungo periodo coloniale. La visione di una società socialista rimane centrale, ma viene vista come un percorso storico molto lungo. Questo percorso unisce l’emancipazione sociale del popolo all’indipendenza nazionale del paese. Il marxismo occidentale, al contrario, tende a guardare con critica a questa versione orientale. Spesso la considera poco credibile dal punto di vista di un marxismo più legato a un futuro utopico e meno concentrato sulle condizioni materiali e le necessità immediate.Altri esempi e le ragioni della scissione
Questa divisione non riguarda solo la Cina. Anche altri paesi mostrano dinamiche simili. Il Vietnam, ad esempio, è ora focalizzato sulla costruzione economica. Per questo motivo, riceve meno attenzione e interesse da parte del marxismo occidentale rispetto a quando era impegnato nella lotta armata per l’indipendenza. Anche Cuba, che ha introdotto elementi di mercato per rafforzare la propria indipendenza economica, ha perso parte del suo fascino agli occhi di quei marxisti occidentali che la vedevano come un’utopia che si stava realizzando. La scissione tra il marxismo occidentale e quello orientale nasce in gran parte dall’incapacità del marxismo occidentale di comprendere la fase attuale della rivoluzione anticoloniale. Questa rivoluzione si è spostata dalla lotta politica per l’indipendenza a una lotta per l’indipendenza economica e tecnologica.Superare le divisioni
Questa divisione tra le due forme di marxismo è dannosa. È fondamentale superare gli atteggiamenti troppo rigidi e dottrinari e confrontarsi con la realtà presente. Questo è necessario per il futuro stesso del marxismo in Occidente. Esistono differenze reali tra Oriente e Occidente, legate alla cultura, ai livelli di sviluppo e ai compiti storici (il completamento della rivoluzione anticoloniale in Oriente, la lotta contro il capitalismo e il militarismo in Occidente). Queste differenze esistono e sono legittime, ma non devono assolutamente trasformarsi in un conflitto o un antagonismo aperto.Definire il marxismo occidentale come prevalentemente ‘messianico’ non rischia di ignorare la ricchezza e la diversità delle sue correnti?
Il capitolo, nel delineare la scissione globale del marxismo, propone una dicotomia netta tra un marxismo occidentale ‘messianico’ e uno orientale ‘pragmatico’. Tuttavia, questa caratterizzazione rischia di semplificare eccessivamente un panorama intellettuale e politico molto più complesso. Il cosiddetto ‘marxismo occidentale’ non è un blocco monolitico, ma comprende una vasta gamma di correnti teoriche e politiche, molte delle quali profondamente radicate nell’analisi delle condizioni materiali e delle lotte sociali concrete, ben oltre una presunta attesa messianica. Allo stesso modo, le esperienze dei paesi orientali presentano notevoli differenze interne. Per cogliere appieno le sfumature di questa scissione, è fondamentale approfondire la storia del pensiero marxista nelle sue diverse declinazioni regionali e nazionali. Utile è lo studio della storia intellettuale e della storia politica comparata. Autori come Perry Anderson o Leszek Kołakowski offrono prospettive sulla diversità interna del marxismo, mentre specialisti di specifiche aree geografiche possono illuminare le concrete dinamiche di adattamento ideologico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]