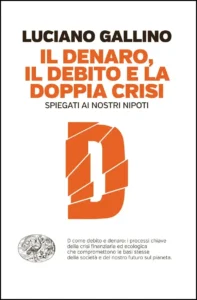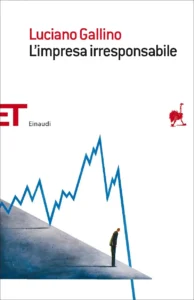1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità” di Luciano Gallino è un libro che ti fa capire davvero cosa c’è dietro il tanto discusso lavoro flessibile. Non è solo un modo diverso di lavorare, ma ha un costo umano enorme, creando precarietà per milioni di persone. Gallino esplora come la globalizzazione e le esigenze delle aziende di ridurre i costi abbiano spinto verso l’uso massiccio di contratti atipici, trasformando il lavoro quasi in una merce da comprare e vendere, lontano dalle tutele che avevamo con lo Statuto dei lavoratori. Il libro smonta l’idea che più flessibilità significhi automaticamente più occupazione, mostrando come spesso porti solo a lavori frammentati e mal pagati. La realtà, dice Gallino, è una polarizzazione che aumenta le disuguaglianze e indebolisce i legami sociali. È una lettura fondamentale per capire perché la precarietà non è un destino inevitabile, ma il risultato di scelte politiche ed economiche precise, e perché dobbiamo ripensare il lavoro partendo dal principio che non è una merce.Riassunto Breve
Il lavoro flessibile richiede alle persone di adattare la propria vita alle esigenze delle aziende, creando costi umani significativi per chi lo sperimenta a lungo. Esiste la flessibilità dell’occupazione, legata ai tipi di contratto (a termine, part-time, ecc.), e la flessibilità della prestazione, che riguarda orari, mansioni e luogo di lavoro. Stimare il numero esatto è difficile, ma si parla di 10-11 milioni di persone in Italia, inclusa una vasta area di lavoro sommerso senza diritti. Le aziende cercano flessibilità per produrre “giusto in tempo” e “solo su domanda”, riducendo i costi del lavoro e spostando i rischi sui lavoratori. La globalizzazione e la tecnologia facilitano questo, frammentando la produzione e mettendo i lavoratori in competizione. Questo rende le imprese meno responsabili verso i lavoratori e indebolisce l’organizzazione sindacale, creando un mercato del lavoro polarizzato con pochi lavori stabili e molti precari. La pressione per alti profitti spinge ulteriormente verso la compressione dei costi del lavoro. L’idea che più flessibilità crei più occupazione è diffusa, ma i dati non la supportano chiaramente; spesso aumenta il numero di contratti brevi o part-time senza aumentare le ore totali lavorate o la stabilità. Le statistiche sull’occupazione sono complesse e i confronti internazionali non mostrano una relazione positiva provata tra flessibilità e volume totale dell’occupazione. Storicamente, la legge sul lavoro proteggeva i lavoratori, trattando il lavoro come parte della persona, non una merce. Dagli anni Settanta, c’è stata una tendenza opposta, la “ri-mercificazione”, trattando il lavoro come un oggetto da comprare e vendere. Leggi italiane dagli anni Novanta hanno accelerato questo processo, indebolendo le tutele e favorendo i contratti atipici, come la somministrazione, che separa il lavoratore dall’impresa utilizzatrice. Questa evoluzione non ha portato a un aumento netto e stabile dell’occupazione e può ridurre produttività e sicurezza. La precarietà, una sequenza di contratti brevi senza certezza, è il costo umano principale. Causa insicurezza oggettiva e soggettiva, difficoltà a fare progetti di vita e professionali, un senso di impotenza e rassegnazione. Molti lavori flessibili non permettono di accumulare esperienza trasferibile o costruire un’identità lavorativa, fondamentale per l’identità personale. La flessibilità erode le sicurezze del “lavoro dignitoso”: stabilità, crescita professionale, sicurezza sul lavoro (le aziende investono meno in formazione per lavoratori a breve termine), sicurezza del reddito (redditi annui inferiori), sicurezza di rappresentanza sindacale e sicurezza previdenziale (pensioni basse). La precarietà ha effetti psicologici e sociali negativi, anche sui figli. I costi variano per tipo di lavoro e colpiscono di più donne, giovani, over 40-45, persone con basso titolo di studio, immigrati e residenti in aree meno sviluppate. Contrariamente all’idea che la tecnologia elimini i lavori a bassa qualificazione, questi aumentano, spesso con ritmi intensi simili alle vecchie catene di montaggio (es. call center, logistica). La teoria di una “società flessibile” promuove autonomia e funzionamento continuo, vedendo le vecchie leggi come ostacoli. La realtà mostra una polarizzazione a “clessidra”: un piccolo nucleo stabile e ben pagato e una grande maggioranza in lavori frammentati, ripetitivi e a bassa qualità. La flessibilità riduce l’integrazione sociale, erodendo legami sul lavoro, ritualità tradizionali e indebolendo famiglia, comunità e sindacati. La precarietà globale deriva dalla riorganizzazione produttiva delle imprese che cercano bassi costi del lavoro nel mondo, mettendo i lavoratori in competizione. La “flessicurezza” cerca di bilanciare flessibilità per le imprese e sicurezza sociale per i lavoratori (indennità, formazione), ma non elimina i costi umani della precarietà e richiede sistemi di welfare costosi non facilmente replicabili. Affrontare le cause richiede una politica del lavoro globale che imponga responsabilità a stati e imprese per i diritti dei lavoratori e una nuova legge nazionale basata sui principi costituzionali che affermi che il lavoro non è una merce e ristabilisca il contratto a tempo indeterminato come norma. La realizzazione di queste politiche dipende dalla volontà politica e dalla consapevolezza pubblica che la precarietà è un attacco allo stato sociale.Riassunto Lungo
1. Il lavoro flessibile: numeri, cause e conseguenze
La flessibilità del lavoro significa dover adattare la propria vita alle richieste che cambiano spesso da parte delle aziende. Chi vive questa condizione per molto tempo paga un prezzo alto a livello umano. Questa flessibilità si presenta in due modi principali: c’è la flessibilità dell’occupazione, che riguarda quanti lavoratori vengono impiegati e si vede nei tipi di contratto non standard come quelli a termine, part-time, in somministrazione, co.co.co., a progetto, intermittente o occasionale. Poi c’è la flessibilità della prestazione, che permette di cambiare orari, compiti e dove si lavora. Capire esattamente quanti lavoratori flessibili ci siano è complicato per via delle statistiche, ma si stima che in Italia riguardi tra i 10 e gli 11 milioni di persone. Questo numero include sia chi ha un contratto flessibile riconosciuto (circa 5-6 milioni) sia chi lavora senza regole nell’economia sommersa. Milioni di persone in questa situazione non hanno diritti e dipendono completamente dal datore di lavoro.Perché le aziende cercano flessibilità
Le aziende chiedono flessibilità principalmente per seguire due idee: avere tutto quello che serve esattamente quando serve (“just in time”) e produrre solo quello che viene chiesto (“su domanda”). Queste logiche si sono diffuse molto con la globalizzazione e le nuove tecnologie. Il loro scopo è chiaro: tagliare i costi legati al lavoro e far ricadere sui lavoratori i rischi che prima erano dell’azienda. Le imprese dividono la produzione in tante parti e le spostano in giro per il mondo per trovare posti dove costa meno e ci sono meno regole, mettendo così in competizione i lavoratori tra loro. Anche la forte richiesta di profitti da parte degli investitori spinge le aziende a ridurre i costi del lavoro, usando proprio la flessibilità come strumento.Le conseguenze per i lavoratori e il mercato
Questa tendenza alla flessibilità ha effetti importanti. Da un lato, le aziende si sentono meno responsabili per il futuro dei loro dipendenti. Dall’altro, la forza lavoro si ritrova divisa e frammentata, il che rende molto più complicato per i sindacati organizzarsi e difendere i diritti. Il risultato è un mondo del lavoro spaccato in due: solo una piccola parte di persone ha lavori sicuri e ben pagati, mentre la grande maggioranza si ritrova con impieghi temporanei e incerti. È importante notare che anche la pubblica amministrazione ricorre spesso a forme di lavoro flessibile.Ma la flessibilità del lavoro è solo una conseguenza inevitabile delle ‘logiche’ di mercato e della globalizzazione, o è stata anche una precisa scelta politica e legislativa?
Il capitolo, pur descrivendo le cause economiche della flessibilità, non approfondisce il ruolo cruciale delle decisioni politiche e legislative che hanno progressivamente deregolamentato il mercato del lavoro, favorendo l’adozione di contratti non standard e indebolendo le tutele. Non si tratta solo di una dinamica di mercato, ma anche dell’esito di specifiche scelte di politica economica e sociale. Per comprendere meglio questo aspetto, è fondamentale studiare la storia delle riforme del diritto del lavoro, analizzare il dibattito politico che le ha accompagnate e confrontarsi con le opere di economisti e sociologi che hanno indagato il rapporto tra stato, mercato e lavoro.2. La trasformazione del lavoro in merce e i suoi effetti sull’occupazione
È diffusa l’idea che rendere il lavoro più flessibile porti a un aumento dei posti di lavoro. Molti pensano che facilitare i licenziamenti o usare contratti di breve durata sia necessario per essere competitivi nel mondo e creare nuove opportunità di impiego. Tuttavia, il legame tra flessibilità e occupazione non è così diretto. Il termine “occupazione” può significare sia il numero di persone che lavorano, sia il totale delle ore lavorate. Spesso, una maggiore flessibilità porta a più contratti a tempo parziale o determinato, aumentando il numero di persone occupate, ma senza un aumento significativo delle ore lavorate complessivamente.Misurare l’occupazione e i risultati
Misurare l’occupazione è complicato perché ci sono diversi modi per farlo e diverse definizioni (contratti registrati, liste di chi cerca lavoro, indagini fatte su un campione, economia non ufficiale). Questo rende difficile avere un quadro preciso. Anche confrontare i dati tra paesi diversi, spesso basandosi su indagini campionarie, non dimostra in modo chiaro che dove c’è più flessibilità ci siano anche più posti di lavoro in totale. Dati storici dell’OCSE mostrano che i paesi con leggi sul lavoro meno severe non hanno sempre creato più posti di lavoro rispetto a quelli con leggi più rigide. Un rapporto OCSE del 2004 ha ammesso che non c’è una relazione positiva chiara e provata tra la flessibilità e il numero totale di occupati.Dal lavoro protetto alla merce
Le leggi sul lavoro, nel corso della storia, hanno cercato di proteggere i lavoratori. Hanno considerato il lavoro come una parte importante della persona, non come una semplice merce da comprare e vendere. Questo principio è stato affermato nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944 e ha guidato lo sviluppo delle leggi sul lavoro in molti paesi europei, inclusa l’Italia con lo Statuto dei lavoratori. Dagli anni Settanta, però, si è vista una tendenza opposta: il lavoro ha iniziato a essere trattato di nuovo come una merce. Questo significa considerarlo come un oggetto separato dal lavoratore, che può essere scambiato seguendo le stesse regole di un normale contratto commerciale.Le leggi italiane e i loro effetti
Le leggi italiane dagli anni Novanta hanno accelerato questo cambiamento. Il protocollo del 1993, il “pacchetto Treu” del 1997, il decreto del 2001 sui contratti a termine e il decreto del 2003 hanno introdotto e reso più comuni forme di lavoro flessibile come il lavoro a chiamata e la somministrazione, che è una specie di lavoro in affitto. Queste misure hanno diminuito le protezioni per i lavoratori, eliminato i limiti su quante persone potevano essere assunte con contratti diversi da quello standard e hanno favorito accordi individuali, riducendo il potere del lavoratore nel negoziare. La somministrazione, in particolare, crea un rapporto commerciale tra due aziende per l’uso della forza lavoro, separando di fatto il lavoratore dall’impresa dove svolge il suo lavoro.I risultati concreti e le tendenze attuali
Questa evoluzione delle leggi, voluta per dare più flessibilità alle aziende, tratta il lavoro come una merce. Cedere questa “merce” non tiene conto abbastanza delle conseguenze sulla persona del lavoratore. Nonostante le promesse, non ci sono prove solide che questa maggiore flessibilità abbia portato a un aumento stabile e significativo dei posti di lavoro in totale. Anzi, l’uso diffuso di contratti brevi può avere effetti negativi su quanto si produce e sulla sicurezza di chi lavora. La tendenza a trattare il lavoro sempre più come una merce continua a essere promossa anche in Europa, per esempio con l’idea di “flessicurezza”. Questo concetto, pur volendo unire flessibilità e sicurezza, rischia di rafforzare l’idea del lavoro come pura merce attraverso accordi sempre più individuali.Come si può criticare la flessibilità del lavoro senza affrontare le ragioni economiche che, a detta dei suoi sostenitori, la rendono indispensabile?
Il capitolo analizza in modo efficace le conseguenze negative della flessibilità e la deriva verso la mercificazione del lavoro, ma lascia in ombra le ragioni economiche che, secondo i sostenitori di tali politiche, le rendono necessarie in un contesto globale sempre più competitivo. Per comprendere appieno il dibattito e formulare risposte efficaci, è fondamentale approfondire le teorie economiche sulla competitività, l’innovazione e l’adattamento dei mercati del lavoro. Utile sarebbe leggere autori che hanno analizzato le trasformazioni del capitalismo contemporaneo e le diverse risposte politiche, come Stiglitz o Piketty, o studi specifici sui modelli di mercato del lavoro comparati (es. i modelli nordici vs. i modelli continentali).3. Il Rovescio della Medaglia Flessibile
Il lavoro flessibile non è solo un modo diverso di lavorare, ma porta con sé costi importanti per le persone, le famiglie e la società. Impone pesi nuovi e difficili rispetto a un lavoro stabile. Molti sentono che i contratti a termine o occasionali causano preoccupazione e riducono i loro diritti. Le esperienze di lavoro spezzettate nel tempo creano vuoti nella formazione e obbligano a rimandare i progetti di vita, rendendo più complicato trovare lavoro in futuro. Il costo umano più grande è la mancanza di sicurezza, una condizione che nasce da una serie di contratti brevi senza la certezza di continuare. Questa mancanza di sicurezza è reale e sentita, e dal lavoro si estende alla vita, perché lavoro e guadagno dipendono da un permesso che può essere tolto. Questa situazione riporta le condizioni lavorative indietro rispetto alla stabilità raggiunta in passato. Sentirsi insicuri cambia anche come le persone vedono se stesse e porta a sviluppare nuovi comportamenti.Difficoltà nel Fare Progetti e Costruire un’Identità
La mancanza di sicurezza limita la possibilità di fare progetti per il futuro, sia per la carriera che per la vita personale. La vita e quello che succederà sembrano dipendere da cose casuali e non prevedibili, non dalle proprie azioni. Questo senso di non poter fare nulla alimenta la sfiducia nella politica e la rassegnazione. Inoltre, la maggior parte dei lavori flessibili non permette di accumulare esperienza che si possa usare altrove o di costruire una carriera e un senso di chi si è attraverso il lavoro. Avere un’identità legata al lavoro è fondamentale per sentirsi bene con se stessi e nella società; non poterla costruire causa sofferenza.Meno Sicurezza nel Lavoro
La crescita dei lavori flessibili indebolisce le protezioni del “lavoro dignitoso”, come definito a livello internazionale. Diminuisce la stabilità del posto di lavoro e rende difficile crescere professionalmente e creare un’identità legata al lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro è messa a rischio perché le aziende non investono nella formazione di lavoratori che rimangono per poco tempo. Questi lavoratori, a loro volta, non hanno il tempo o la spinta per imparare le regole di sicurezza, e spesso trascurano la propria salute per non perdere il lavoro. Avere un reddito sicuro è molto più difficile. Chi ha contratti a termine o collaborazioni guadagna molto meno all’anno rispetto a chi ha un posto fisso o è davvero autonomo. Questo succede perché lavorano meno mesi all’anno e ricevono pochi soldi quando non lavorano. La possibilità di essere rappresentati dai sindacati diminuisce perché i lavoratori cambiano spesso e i rapporti di lavoro sono più individuali. Di conseguenza, anche la sicurezza per la pensione futura si riduce, con prospettive di assegni molto bassi per chi ha lavorato a lungo con contratti precari.Effetti sulla Persona e sulla Società
La mancanza di sicurezza ha effetti sulla mente e sulle relazioni sociali. Porta a fare propria l’incertezza e può causare problemi nel modo di essere e di comportarsi. I figli di genitori che vivono questa insicurezza possono mostrare difficoltà e modi di agire che vanno dalla rassegnazione alla voglia di ribellarsi.Costi Diversi a Seconda del Lavoro e Chi è Più Colpito
Le difficoltà legate al lavoro flessibile sono diverse a seconda del tipo di impiego. Nei lavori molto organizzati e ripetitivi, si rischia di essere considerati “troppo vecchi” presto, e le competenze non sono facili da usare in altri ambiti. Nei lavori che richiedono poche qualifiche, i salari diminuiscono a causa della forte competizione. Nei lavori dove si è un po’ autonomi ma non del tutto indipendenti, c’è il timore di perdere il lavoro in età avanzata e di vedere diminuire la propria posizione sociale. Nei lavori che richiedono alte qualifiche, alcuni all’inizio apprezzano i contratti brevi per l’esperienza, ma nel tempo le loro competenze possono diventare superate, e non hanno il tempo per formarsi. Altri lavoratori qualificati che cercano stabilità provano una forte frustrazione perché la loro professione sembra perdere valore. Questi pesi del lavoro flessibile colpiscono in modo maggiore alcuni gruppi. Questi includono donne, giovani, persone disoccupate sopra i 40-45 anni, chi ha studiato meno, gli immigrati e chi vive in zone meno sviluppate.Ma se la teoria della “società flessibile” promette autonomia e crescita, perché la sua realizzazione concreta sembra produrre solo precarietà e disuguaglianza?
Il capitolo descrive efficacemente la discrepanza tra l’ideale di un lavoro flessibile che promuove autonomia e formazione continua, e la realtà di una forza lavoro polarizzata, con la maggioranza intrappolata in mansioni ripetitive e instabili. Questa tensione tra teoria e prassi è un punto cruciale che meriterebbe maggiore esplorazione. Per comprendere meglio le ragioni di questo divario, è utile approfondire non solo le dinamiche del mercato del lavoro contemporaneo, ma anche le origini e le diverse interpretazioni del concetto stesso di flessibilità, analizzando come le strutture economiche e di potere influenzino la sua applicazione. Approfondire le opere di autori che hanno criticato le trasformazioni del capitalismo e del lavoro, come Richard Sennett o Zygmunt Bauman, può offrire prospettive preziose su come la flessibilità, da potenziale liberazione, si sia trasformata per molti in una fonte di insicurezza e frammentazione sociale.5. La Precarietà Globale e le False Soluzioni
La flessibilità nel mondo del lavoro ha costi personali e sociali molto alti. Questa situazione nasce dalla scelta delle grandi imprese di riorganizzare la produzione a livello globale. Le aziende spostano i loro stabilimenti dove i salari sono più bassi e i diritti dei lavoratori sono quasi inesistenti. Questo crea una competizione tra lavoratori che hanno tutele elevate e quelli che ne hanno pochissime. Questo processo, che chiamiamo globalizzazione, è reso possibile da leggi che considerano il lavoro come una semplice merce da comprare e vendere. Il risultato è che milioni di persone vivono nell’incertezza riguardo al loro impiego, al reddito, alla possibilità di fare carriera e al loro futuro in generale.La “flessicurezza”: una soluzione parziale
Per rendere questa flessibilità più gestibile, si discute su come intervenire, se sulle cause profonde del problema o solo sui suoi effetti. La strategia della “flessicurezza” si concentra sugli effetti. L’idea è quella di trovare un equilibrio: dare alle imprese la libertà di licenziare (flessibilità) e allo stesso tempo garantire ai lavoratori una rete di protezione sociale (sicurezza). Questa rete include indennità in caso di perdita del lavoro, opportunità di formazione e servizi per trovare un nuovo impiego. Spesso si cita il modello della Danimarca, che offre un sistema di ammortizzatori sociali molto generoso, servizi di supporto all’impiego e aiuto alle famiglie. Tuttavia, questo modello richiede tasse molto alte, che l’Italia, con il suo sistema attuale, non potrebbe sostenere. Gli ammortizzatori sociali oggi disponibili in Italia offrono tutele molto inferiori rispetto a quelli danesi. Anche un sistema di flessicurezza avanzato, però, non riesce a eliminare completamente i costi umani legati all’insicurezza del lavoro. Rimangono l’incertezza personale, le difficoltà nel costruire una carriera solida e la sensazione di non avere il controllo sulla propria vita.Affrontare le cause: la politica globale
Per risolvere il problema alla radice, è necessaria una politica del lavoro che agisca a livello globale. Le grandi aziende transnazionali sono le principali responsabili della spinta verso la flessibilità, perché cercano continuamente costi del lavoro più bassi nei paesi in via di sviluppo. Le linee guida internazionali che esistono oggi per tutelare i lavoratori sono volontarie e quindi poco efficaci. Una politica globale che funzioni davvero dovrebbe imporre precise responsabilità legali sia agli stati che alle imprese quando vengono violati i diritti dei lavoratori. Dovrebbe anche fare in modo che i finanziamenti internazionali siano legati al rispetto degli standard lavorativi minimi. Sarebbe fondamentale promuovere codici di responsabilità sociale che siano obbligatori e non solo facoltativi. Infine, servirebbero accordi globali tra i sindacati e le grandi imprese per garantire condizioni di lavoro dignitose ovunque.La politica nazionale necessaria
Sul piano nazionale, l’Italia ha bisogno di una nuova legge sul lavoro. Questa legge dovrebbe basarsi sui principi fondamentali della Costituzione italiana. Deve affermare chiaramente che il lavoro non è una merce qualsiasi, ma un diritto e un valore sociale. È essenziale ristabilire il contratto a tempo indeterminato come forma contrattuale normale e preferibile. La nuova legge dovrebbe anche affrontare in modo deciso il problema del lavoro irregolare e sommerso. Realizzare queste politiche, sia a livello globale che nazionale, non è semplice. Dipende dalla volontà di chi prende le decisioni politiche e dalla consapevolezza dei cittadini che la precarietà non è un problema isolato, ma fa parte di un attacco più ampio al sistema di protezione sociale che abbiamo costruito nel tempo.Ma è davvero così semplice imporre regole globali e tornare al contratto a tempo indeterminato come unica soluzione, ignorando le dinamiche economiche che spingono alla flessibilità?
Il capitolo presenta una critica forte e condivisibile alla precarietà e alle sue cause, proponendo soluzioni drastiche a livello globale e nazionale. Tuttavia, l’argomentazione potrebbe beneficiare di una maggiore esplorazione delle complessità economiche e politiche legate all’implementazione di tali soluzioni. La proposta di imporre responsabilità legali alle imprese transnazionali e di ristabilire il contratto a tempo indeterminato come norma è ambiziosa, ma il capitolo non approfondisce a sufficienza le sfide pratiche, i potenziali costi economici (anche in termini di competitività o disincentivi all’investimento) e le resistenze politiche che tali misure incontrerebbero. Per comprendere meglio il quadro, sarebbe utile approfondire gli studi di economia del lavoro che analizzano i compromessi tra flessibilità e sicurezza, le ricerche sulle dinamiche del capitalismo globale e le difficoltà della governance internazionale. Autori come Zygmunt Bauman hanno esplorato le dimensioni sociali della precarietà, mentre economisti che studiano i mercati del lavoro comparati possono offrire spunti sulle diverse strategie adottate dai paesi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]