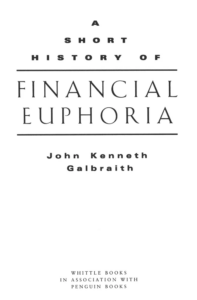1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il grande crollo del 1929” di John Kenneth Galbraith ti porta dritto nel cuore di Wall Street e dell’America degli anni ’20, un’epoca di ottimismo sfrenato e speculazione finanziaria che ha portato al disastro. Questo libro non è solo la cronaca del crollo del mercato azionario del 1929, ma scava a fondo nelle cause della Grande Depressione che ne è seguita, mostrando come una cattiva distribuzione del reddito, un sistema bancario fragile con figure come Charles Mitchell e Albert Wiggin coinvolte in operazioni rischiose, e l’ascesa degli investment trust, che gonfiavano il mercato, abbiano creato una bolla pronta a scoppiare. Galbraith analizza l’inazione della Federal Reserve di fronte alla febbre speculativa e la caduta di simboli come Richard Whitney, che ha portato a nuove regole come il Securities Act e la creazione della SEC, evidenziando come l’avidità e la mancanza di lungimiranza, anche da parte di esperti e autorità, possano avere conseguenze devastanti, un monito ancora attuale sulla fragilità dei mercati e sulla necessità di una solida regolamentazione finanziaria.Riassunto Breve
Negli anni che precedono il 1929, l’economia americana vive un periodo di apparente benessere, ma c’è una forte spinta a fare soldi velocemente che alimenta una speculazione crescente. Questa febbre inizia nel mercato immobiliare e poi si sposta con forza sulla borsa. I prezzi delle azioni salgono in modo esagerato, spinti anche da una politica della Federal Reserve che immette liquidità nel sistema, abbassando i tassi di interesse. In questo clima nascono e si diffondono rapidamente gli investment trust, società che raccolgono denaro vendendo azioni e obbligazioni per comprare azioni di altre aziende. Questi trust permettono di gonfiare il mercato perché il valore dei loro titoli spesso supera di molto il valore reale delle attività che possiedono, e usano la leva finanziaria, un meccanismo che amplifica sia i guadagni che le perdite. Nonostante alcuni avvertimenti, l’ottimismo domina e la speculazione diventa un’attività diffusa. Le autorità, pur vedendo il pericolo di una bolla, non riescono o non vogliono intervenire in modo deciso per fermarla, anche a causa dell’opposizione di banchieri potenti. L’economia, intanto, mostra già segni di rallentamento. Il crollo del mercato azionario, che culmina nei giorni di panico di ottobre 1929, non è l’unica causa della Grande Depressione che segue, ma ne accelera l’inizio e ne peggiora gli effetti in modo drammatico. Il crollo distrugge la fiducia degli investitori e del pubblico nelle figure di spicco e nelle istituzioni finanziarie, portando alla scoperta di scandali e imbrogli, come quello che coinvolge il presidente della Borsa di New York, Richard Whitney. Questo porta a nuove leggi per regolare il mercato, come la creazione della SEC. La Depressione è causata da problemi più profondi nell’economia, come una distribuzione del reddito non equilibrata, un sistema bancario debole e politiche economiche inadeguate. I tentativi iniziali del governo di rassicurare la popolazione e i mercati si rivelano inefficaci. Dopo il crollo, si diffondono anche miti, come quello dei suicidi di massa legati alla borsa, mentre un effetto reale è la scoperta di molti casi di appropriazione indebita legati alla speculazione. Il mercato continua a scendere per anni, dimostrando che la crisi è profonda e complessa.Riassunto Lungo
1. Le Conseguenze del Crollo e le Cause della Depressione
Il crollo del mercato azionario del 1929 ebbe un impatto devastante sulla reputazione di molte figure di spicco, minando la fiducia nella loro competenza e integrità. Le previsioni eccessivamente ottimistiche di alcuni, come quelle del Presidente Hoover, si rivelarono clamorosamente errate, mentre i commenti rassicuranti di economisti di fama, come quelli della Harvard Economic Society, furono smentiti dal corso degli eventi. Anche le spiegazioni fornite in seguito, come quella di Irving Fisher, non riuscirono a convincere il pubblico.Le banche e la crisi di fiducia
Le banche di New York, in particolare la Chase National Bank e la National City Bank, subirono perdite ingenti e la loro immagine fu gravemente compromessa. I loro dirigenti, Albert H. Wiggin e Charles E. Mitchell, si erano impegnati in operazioni di mercato azzardate e spregiudicate, spesso utilizzando i fondi delle loro stesse banche per fini speculativi. Wiggin, attraverso una serie di società private, aveva speculato sulle azioni della Chase, traendone profitto personale. Mitchell, nel tentativo di salvare una fusione con la Corn Exchange Bank, si era esposto con ingenti debiti verso la J.P. Morgan. Entrambi furono coinvolti in scandali finanziari e subirono processi che ne minarono ulteriormente la credibilità.Il caso Whitney e le nuove regolamentazioni
La ricerca di un capro espiatorio a Wall Street portò all’arresto di Richard Whitney, presidente della Borsa di New York, accusato di appropriazione indebita. La sua caduta in disgrazia rappresentò il culmine della sfiducia nel mercato azionario e accelerò l’introduzione di nuove e più stringenti regolamentazioni governative. Tra queste, il Securities Act del 1933 e il Securities Exchange Act del 1934, che portarono alla creazione della Securities and Exchange Commission (SEC), un ente di vigilanza con il compito di controllare e regolamentare il mercato azionario.Le cause profonde della Grande Depressione
La Grande Depressione seguì il crollo del mercato azionario, con un drastico calo del prodotto nazionale lordo e un tasso di disoccupazione che raggiunse livelli senza precedenti. La speculazione sfrenata del 1928-29, alimentata da un ottimismo irrazionale e da una fiducia cieca nel mercato, pose le premesse per un crollo inevitabile. Tuttavia, la depressione fu causata da una combinazione di fattori strutturali, tra cui una distribuzione del reddito fortemente squilibrata, una struttura aziendale debole e inefficiente, un sistema bancario fragile e vulnerabile, uno squilibrio nella bilancia commerciale e, infine, una politica economica inadeguata e miope.Debolezze strutturali e politiche economiche errate
Il crollo del mercato azionario, pur non essendo l’unica causa della depressione, ne accelerò l’inizio e ne amplificò gli effetti. Le debolezze strutturali dell’economia, come la marcata disuguaglianza nella distribuzione del reddito e la fragilità del sistema aziendale, resero il sistema economico particolarmente vulnerabile agli shock esterni. Le politiche economiche dell’epoca, ancorate al dogma del pareggio di bilancio e ossessionate dalla paura dell’inflazione, impedirono di fatto l’adozione di misure efficaci per contrastare la crisi. Nonostante le riforme introdotte successivamente, il rischio di una nuova ondata di speculazione, seguita da un inevitabile crollo, rimane sempre presente. La storia dimostra che la competenza finanziaria e l’acume politico non sempre vanno di pari passo, e che la ricerca del profitto a breve termine spesso prevale su considerazioni di prudenza e di stabilità a lungo termine.Se da un lato il capitolo attribuisce la Grande Depressione a una combinazione di fattori strutturali, tra cui la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e la fragilità del sistema bancario, dall’altro non si può ignorare come esso stesso evidenzi il ruolo chiave della speculazione sfrenata e dell’irrazionale ottimismo del 1928-29: non è forse una contraddizione affermare che il crollo del mercato azionario “pur non essendo l’unica causa della depressione, ne accelerò l’inizio e ne amplificò gli effetti”, sminuendo di fatto il peso di quell’evento scatenante che lo stesso capitolo riconosce come determinante?
Il capitolo, pur fornendo un quadro generale delle cause della Grande Depressione, sembra minimizzare l’impatto del crollo del mercato azionario, definendolo un fattore che “ne accelerò l’inizio e ne amplificò gli effetti” ma non la causa principale. Questa affermazione appare in contrasto con l’enfasi posta sulla speculazione del 1928-29 e sul ruolo di figure come Wiggin e Mitchell. Per approfondire l’argomento e comprendere meglio il peso dei diversi fattori, sarebbe utile esplorare la macroeconomia, con un focus particolare sulla storia del pensiero economico e sulle diverse interpretazioni della Grande Depressione. In questo senso, un’analisi delle teorie di economisti come Keynes, Friedman o Hayek potrebbe fornire una prospettiva più completa e sfaccettata. Inoltre, un approfondimento sulla storia della finanza, con particolare attenzione alle bolle speculative e ai meccanismi di contagio finanziario, potrebbe aiutare a chiarire il ruolo del crollo del ’29.2. L’Euforia Speculativa e l’Inazione delle Autorità
Nel 1928, gli Stati Uniti attraversano un periodo di forte crescita economica, caratterizzato da un aumento della produzione e dell’occupazione. Nonostante alcune disuguaglianze sociali, l’ottimismo è diffuso, alimentato da una forte spinta a diventare ricchi rapidamente. Questo desiderio di arricchimento rapido si manifesta inizialmente nel boom immobiliare della Florida. Terreni di scarso valore vengono venduti a prezzi elevati, grazie alla speculazione e alla convinzione che la domanda sia destinata a crescere costantemente.Dalla Florida a Wall Street
Successivamente, la febbre speculativa si sposta verso il mercato azionario. I prezzi delle azioni aumentano costantemente, sostenuti da guadagni aziendali positivi e da un clima di fiducia generalizzata. In questo contesto, la Federal Reserve, con l’intento di supportare l’economia britannica, decide di abbassare i tassi di interesse, immettendo così una maggiore liquidità nel sistema. Questa manovra, sebbene mossa da buone intenzioni, contribuisce involontariamente ad alimentare ulteriormente la speculazione finanziaria.L’Incapacità di Intervento
Nel 1929, la situazione raggiunge un punto critico, con una speculazione ormai fuori controllo. Le autorità, pur consapevoli del pericolo imminente, esitano ad agire. La Federal Reserve, la cui leadership è in quel momento caratterizzata da figure non sempre competenti, si dimostra incapace di adottare misure efficaci per frenare la bolla speculativa. Gli strumenti tradizionali di controllo monetario, come la vendita di titoli di stato e l’aumento dei tassi di sconto, si rivelano inefficaci nel contenere l’euforia del mercato. La paura di danneggiare l’economia reale e la mancanza di una forte volontà politica impediscono un intervento deciso e tempestivo.La Sconfitta della Moral Suasion
La Federal Reserve tenta di mitigare la situazione attraverso una blanda “moral suasion”, ma i suoi avvertimenti vengono completamente ignorati dagli operatori di mercato. Charles E. Mitchell, un potente banchiere dell’epoca, si oppone apertamente ai tentativi di controllo, iniettando ulteriore liquidità nel mercato e alimentando così la speculazione. Di fronte a questa sfida, la Federal Reserve è costretta a ritirarsi, lasciando il mercato in balia di se stesso. L’inazione delle autorità, combinata con l’euforia speculativa, crea le condizioni per un inevitabile crollo.Se la Federal Reserve era a conoscenza dei pericoli imminenti di una speculazione fuori controllo, perché ha esitato così a lungo prima di adottare misure efficaci, permettendo di fatto che la situazione degenerasse fino al punto di non ritorno?
Il capitolo descrive l’inazione della Federal Reserve di fronte all’euforia speculativa del 1928-1929 come il risultato di una leadership incompetente e della paura di danneggiare l’economia reale. Tuttavia, questa spiegazione appare semplicistica e non tiene conto di altri fattori che potrebbero aver influenzato le decisioni della Fed. Ad esempio, sarebbe utile approfondire il contesto politico dell’epoca e le pressioni esercitate sulla Fed da parte di diversi gruppi di interesse. Inoltre, il capitolo liquida la “moral suasion” come strumento inefficace, senza analizzare a fondo le ragioni del suo fallimento. Un’analisi più approfondita del dibattito interno alla Fed e delle diverse strategie di intervento prese in considerazione potrebbe fornire una comprensione più completa delle dinamiche che hanno portato all’inazione. Per ampliare la prospettiva, si potrebbero esplorare le teorie economiche di John Maynard Keynes, per comprendere meglio le diverse scuole di pensiero riguardo al ruolo delle banche centrali nella gestione dei cicli economici. Inoltre, un confronto con le crisi finanziarie successive, come quella del 2008, potrebbe aiutare a contestualizzare meglio le azioni, o le non-azioni, della Federal Reserve nel 1929.3. L’Ascesa e la Caduta degli Investment Trust
Nel 1929, la scarsità di azioni comuni disponibili sul mercato favorì la nascita di nuove società, tra cui gli investment trust. Questi ultimi non finanziavano nuove imprese, ma consentivano agli investitori di possedere quote di società già esistenti attraverso la creazione di nuove entità. In questo modo, il volume dei titoli societari si separava dal valore reale delle attività, permettendo una crescita esponenziale del mercato.Origini e Sviluppo degli Investment Trust
L’idea degli investment trust proveniva dalla Gran Bretagna, dove piccoli investitori univano le loro risorse. Negli Stati Uniti, inizialmente, i promotori erano cauti, ma presto i trust divennero società di investimento, vendendo azioni e obbligazioni per investire a discrezione. La Borsa di New York inizialmente li guardava con sospetto, ma la fiducia nei gestori era alta. Nel 1929, gli investment trust crebbero rapidamente, con un aumento di capitale di miliardi di dollari. La loro nascita era spesso sponsorizzata da banche e altre società finanziarie, che traevano profitto dai contratti di gestione e dalla vendita di azioni a prezzi maggiorati. Alcuni, come John J. Raskob, proposero piani per permettere anche ai meno abbienti di investire, ma la speculazione era già in pieno svolgimento.La Leva Finanziaria e la Goldman Sachs Trading Corporation
Il valore di mercato dei titoli degli investment trust superava spesso il valore delle attività sottostanti, riflettendo la fiducia nella competenza finanziaria. Gli esperti, inclusi professori universitari, venivano assunti per aumentare questa percezione. La leva finanziaria, ottenuta emettendo obbligazioni e azioni privilegiate per acquistare azioni comuni, amplificava i guadagni, ma anche le perdite. Goldman Sachs, entrata tardi nel settore, creò la Goldman Sachs Trading Corporation, che crebbe rapidamente. La società emise azioni, si fuse con altri trust e lanciò Shenandoah e Blue Ridge Corporation, applicando la leva finanziaria in modo aggressivo. Queste operazioni, insieme ad altre, portarono a un’enorme emissione di titoli.La Crescita del Mercato Azionario e la Speculazione
Il mercato azionario cresceva senza sosta, con un aumento dei prestiti dei broker. Molti esperti e banchieri sostenevano la solidità del mercato, mentre alcuni, come Paul M. Warburg, mettevano in guardia contro la speculazione. La stampa finanziaria, in generale, era ottimista, ma alcuni, come il New York Times, mantenevano una visione più sobria. La speculazione divenne centrale nella cultura, con molti che si dedicavano al mercato, anche se la partecipazione era limitata a una piccola parte della popolazione. Le operazioni di manipolazione erano comuni, con gruppi che cercavano di far salire i prezzi di azioni specifiche. La speculazione divenne un’attività a tempo pieno, con i broker che installavano uffici anche sulle navi.Il Picco e l’Inizio del Declino
Il 3 settembre 1929, il mercato azionario raggiunse il suo picco, seguito da un calo dopo le previsioni pessimistiche di Roger Babson. Nonostante le smentite, il mercato iniziò una fase di declino, segnando la fine di un’era di illusioni.Se il crollo del mercato azionario del ’29 non fu la causa scatenante della Grande Depressione, ma solo un sintomo di problemi preesistenti, perché il capitolo si concentra tanto su di esso, tralasciando un’analisi più approfondita delle cause strutturali della crisi?
Il capitolo, pur riconoscendo che il crollo di Wall Street fu un riflesso di criticità economiche già in atto, dedica ampio spazio alla descrizione degli eventi del “giovedì nero” e del “martedì nero”, nonché ai tentativi di stabilizzazione del mercato, per poi liquidare in poche righe le cause profonde della crisi. Per comprendere appieno le radici della Grande Depressione, sarebbe opportuno approfondire le dinamiche macroeconomiche dell’epoca, con particolare attenzione a temi come la sovrapproduzione, la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, le politiche monetarie della Federal Reserve e il ruolo del protezionismo nel commercio internazionale. Un’analisi più accurata di questi aspetti, magari attraverso lo studio di economisti come John Maynard Keynes o Milton Friedman, permetterebbe di contestualizzare meglio il crollo del ’29 e di coglierne appieno il significato all’interno di un quadro economico già fortemente compromesso.5. Miti, Menzogne e Riunioni Inutili
Dopo il crollo del mercato azionario del 1929, si diffuse la falsa credenza di un’ondata di suicidi tra gli speculatori. In realtà, i tassi di suicidio aumentarono gradualmente negli anni successivi, ma non in modo significativo nel periodo immediatamente successivo al crollo. La stampa e l’opinione pubblica collegarono i suicidi alla crisi finanziaria, creando un mito che non corrispondeva ai dati reali.Effetto del crollo sull’appropriazione indebita
L’effetto del crollo sull’appropriazione indebita fu più rilevante. Durante i periodi di prosperità, l’appropriazione indebita aumenta a causa della fiducia e della disponibilità di denaro. La crisi del mercato azionario portò a una rapida scoperta di questi crimini, poiché la fiducia si trasformò in sospetto. Molti dipendenti che avevano sottratto fondi per giocare in borsa furono scoperti.Incontri e reazione del mercato
Dopo il crollo, il mercato azionario si fermò temporaneamente per poi riprendere a scendere. Il presidente Hoover cercò di rassicurare l’opinione pubblica con tagli fiscali e incontri con leader industriali. Questi incontri, tuttavia, non portarono a soluzioni concrete, ma servirono a dare l’impressione di un’azione governativa. Tali riunioni, in realtà, sono un modo per simulare attività quando non si sa cosa fare. Il mercato azionario continuò a peggiorare fino al 1932, con valori che crollarono drasticamente.Parole e tentativi di rassicurazione
Nonostante i tentativi di rassicurazione, la situazione economica peggiorò. Le parole di Hoover, che inizialmente aveva affermato che le parole non avevano importanza in tempi di crisi, furono smentite dai suoi stessi tentativi di rassicurazione, che si rivelarono inefficaci.Se le riunioni con i leader industriali erano così inefficaci, perché il presidente Hoover le ha organizzate, e come mai questo comportamento è così diffuso, ancora oggi, tra i leader politici ed i potenti in generale?
Il capitolo si concentra molto sull’inefficacia delle parole e delle azioni di rassicurazione di fronte a una crisi economica tangibile, come dimostrato dal continuo peggioramento del mercato azionario fino al 1932. Tuttavia, non viene adeguatamente analizzato il ruolo psicologico e sociale di tali incontri, al di là della semplice constatazione che servivano a “dare l’impressione di un’azione governativa”. Per approfondire la questione, si potrebbero esplorare discipline come la psicologia sociale e la sociologia delle organizzazioni, che studiano il comportamento dei gruppi e dei leader in situazioni di crisi. Potrebbe essere utile, ad esempio, esaminare gli studi di Irving Janis sul “groupthink” o quelli di Karl Weick sulla “sensemaking” nelle organizzazioni. Inoltre, un approfondimento sulla comunicazione politica e sulla costruzione del consenso potrebbe fornire ulteriori spunti di riflessione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]