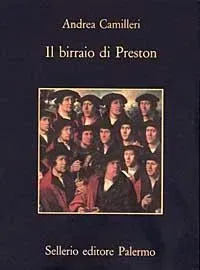1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il Gioco Della Mosca” di Andrea Camilleri non è un romanzo nel senso classico, ma un viaggio affascinante nel cuore della Sicilia attraverso il suo linguaggio. Questo libro esplora le espressioni siciliane più autentiche, quelle che nascono dalla vita di tutti i giorni, dagli aneddoti, a volte reali, a volte leggendari, che raccontano la storia e la mentalità di una comunità. Ogni modo di dire, come “A baddruzza o’ papà” o “A buttana di Sciacca”, ha una sua origine curiosa, legata a personaggi o eventi specifici, e racchiude la saggezza, l’ironia o persino il fatalismo della gente del posto. Camilleri ci mostra come queste frasi non siano solo parole, ma vere e proprie chiavi per capire la cultura siciliana, il modo di pensare e di affrontare la vita in un paese dove anche un semplice sguardo (“Taliarsi”) può essere una forma di comunicazione segreta. Attraverso queste storie e questi modi di dire, che a volte richiamano persino figure come Pirandello o eventi più ampi, “Il Gioco Della Mosca” dipinge un quadro vivido e genuino dell’anima siciliana, fatta di esperienze collettive e di un linguaggio ricco e profondo. È una raccolta che, come una “muzziata”, mette insieme pezzi diversi per rivelare un’immagine unica.Riassunto Breve
Il linguaggio locale conserva significati profondi spesso legati a eventi specifici personaggi o modi di vivere della comunità Molte espressioni comuni derivano da aneddoti reali o leggendari che condensano la saggezza l’ironia o il fatalismo del luogo Frasi come “A baddruzza o’ papà” descrivono azioni apparentemente altruiste ma con un tornaconto personale nate dall’osservazione di comportamenti come quello di Gnazio Spidicato che si nutriva dei tuorli d’uovo lanciati dai figli “A buttana di Sciacca” illustra come un evento inatteso possa portare a esiti sorprendenti e positivi come il matrimonio della guardia Agatino “Accussì accussì accussì” rappresenta una risposta vaga ma accettata per affrontare questioni complesse originata dal modo di fare di zi’ Totò Il detto “Addifenditi Rinardu!” riflette un senso di lealtà e fair play anche verso un avversario nato da un episodio all’Opera dei pupi “Amminchià cu pupu” indica l’ostinazione irragionevole esemplificata dalla reazione di zu’ Cosimo sulla natura delle statuette di San Calogero “Annacari” descrive l’atto di illudere o prendere tempo specialmente in contesti come le raccomandazioni politiche “A passata do palermitano” si usa per indicare sfortune o ingiustizie inspiegabili come quelle subite da Tano Brucculeri a causa di un equivoco burocratico Queste espressioni radicate nella vita quotidiana e nelle esperienze collettive non sono semplici modi di dire ma chiavi per comprendere la mentalità e la storia del luogo Altre espressioni includono “Puci siccu mangia maccu” che descrive fame estrema e un forte legame identitario o “Ruvina di la me’ casa!” un modo scherzoso per definire un uomo incapace nei lavori femminili “Scrusciu di carta e cubbàita nenti” indica qualcosa di appariscente ma privo di sostanza mentre “Sunnu cosi di Pirinnellu” commenta situazioni intricate o paradossali riflettendo la visione popolare delle opere di Pirandello “Taliarsi” è una comunicazione segreta basata sugli sguardi nata dalla necessità di diffidare delle parole “Unn’è cosa di spartiricci u pani ‘nzemmula” è la peggiore accusa per chi tradisce l’ospitalità Personaggi come il generale Patton definito “fitusu” da un suo soldato o l’uso di soprannomi e nomi locali da parte di Pirandello per i suoi personaggi mostrano come la realtà e il linguaggio del paese si intreccino con eventi più ampi e con l’arte La “muzziata” intesa come un insieme eterogeneo di cose o eventi riassume la natura stessa di questa raccolta di modi di dire ognuno con la sua storia unica Queste espressioni delineano aspetti della cultura e della psicologia locale.Riassunto Lungo
1. Le parole, le storie, la vita
Il linguaggio del posto racchiude significati profondi, strettamente connessi a eventi specifici, a personaggi che hanno lasciato il segno o a modi di vivere caratteristici della comunità. Molte espressioni di uso comune non sono nate per caso, ma derivano da aneddoti, a volte reali, a volte leggendari, che condensano la saggezza popolare, l’ironia o persino il fatalismo tipico del luogo.Le storie dietro le espressioni
Ogni modo di dire ha una sua origine particolare, spesso legata a vicende personali o collettive che ne spiegano il senso più intimo. Queste storie, tramandate nel tempo, offrono uno spaccato autentico della vita e della mentalità della gente.- “A baddruzza o’ papà”: Questa frase descrive azioni che sembrano disinteressate ma nascondono un tornaconto. L’espressione nasce dall’osservazione del comportamento di Gnazio Spidicato, che si nutriva dei tuorli d’uovo che i figli gli lanciavano, mostrando un apparente gesto di affetto che in realtà soddisfaceva un suo bisogno.
- “A buttana di Sciacca”: Indica come un evento inatteso possa portare a risultati sorprendenti e positivi. L’origine si lega al matrimonio della guardia Agatino, un esito inaspettato che cambiò la sua sorte.
- “Accussì, accussì, accussì”: Rappresenta una risposta volutamente vaga e generica, usata per evitare di affrontare questioni complesse in modo diretto. Deriva dal modo di fare di zi’ Totò, noto per le sue risposte evasive.
- “Addifenditi, Rinardu!”: Questo detto riflette un forte senso di lealtà e rispetto, anche nei confronti di un avversario. Nasce da un episodio avvenuto all’Opera dei pupi, dove si manifestò questo spirito di fair play.
- “Amminchià cu pupu”: Descrive un’ostinazione irragionevole e priva di fondamento. L’espressione è esemplificata dalla reazione di zu’ Cosimo, che si fissò su una sua idea riguardo la natura delle statuette di San Calogero, rifiutando ogni altra spiegazione.
- “Annacari”: Significa illudere, prendere tempo, o rimandare decisioni, specialmente in contesti come le promesse o le raccomandazioni politiche, dove si tende a non dare risposte definitive.
- “A passata do palermitano”: Si usa per indicare sfortune improvvise o ingiustizie inspiegabili che colpiscono qualcuno. Un esempio è la vicenda di Tano Brucculeri, che subì una serie di sventure a causa di un equivoco burocratico.
Il linguaggio come specchio della comunità
Queste espressioni non sono solo modi di dire curiosi, ma vere e proprie chiavi per comprendere la mentalità, la storia e le esperienze collettive del luogo. Sono radicate nella vita di tutti i giorni e rivelano aspetti della cultura popolare che altrimenti rimarrebbero nascosti.Legami con eventi e figure note
La ricchezza del linguaggio locale si intreccia anche con eventi di portata maggiore e con il mondo dell’arte. Personaggi storici come il generale Patton, ad esempio, sono entrati nel lessico comune, definito “fitusu” da un suo soldato, mostrando come la realtà esterna venga filtrata e reinterpretata attraverso il linguaggio del posto. Anche l’uso di soprannomi e nomi locali da parte di autori come Pirandello per i suoi personaggi testimonia quanto profondamente la lingua e le storie del paese siano legate alla vita vissuta e possano ispirare la creazione artistica.La “muzziata”: una raccolta eterogenea
In fondo, questa collezione di modi di dire, ognuno con la sua storia unica e il suo significato, può essere paragonata a una “muzziata”. Questo termine locale indica un insieme eterogeneo, un miscuglio di cose diverse, proprio come lo sono queste espressioni che, prese insieme, compongono un ritratto sfaccettato della comunità e della sua lingua.Su quali basi possiamo affermare che queste storie siano l’origine certa di tali espressioni, e non semplici aneddoti o interpretazioni posteriori?
Il capitolo presenta queste storie come l’origine certa delle espressioni, ma non affronta il tema complesso della verifica etimologica. La nascita dei modi di dire è spesso avvolta nel tempo e nella tradizione orale, rendendo difficile distinguere l’origine reale dalla leggenda o dalla cosiddetta “etimologia popolare”, una spiegazione creata a posteriori. Per comprendere meglio questo aspetto, sarebbe utile approfondire gli studi di linguistica, in particolare l’etimologia e la sociolinguistica, che analizzano come il linguaggio si evolve e si relaziona con la società e il folklore. Autori come Tullio De Mauro o studiosi di dialettologia e tradizioni popolari offrono strumenti critici per affrontare queste tematiche con maggiore rigore.2. Il Senso Nascosto delle Frasi
La lingua siciliana è ricca di espressioni vivide che catturano l’essenza della vita e del pensiero locale. Queste frasi sono più di semplici parole; sono finestre sulla storia, sui costumi e sul modo unico in cui le persone vedono il mondo che le circonda. Spesso portano con sé strati di significato, mescolando umorismo, saggezza e osservazioni acute. Comprendere queste espressioni significa avvicinarsi al cuore della cultura.Espressioni e il loro significato
Diverse espressioni tipiche siciliane svelano aspetti profondi della cultura e della mentalità locale:- Puci siccu mangia maccu: Questa frase descrive un cibo povero e un fischio usato per riconoscersi tra compaesani. Indica una condizione di fame estrema e al tempo stesso un forte legame di identità tra le persone.
- Ruvina di la me’ casa!: È un modo scherzoso per definire un uomo considerato incapace nei lavori tradizionalmente femminili. L’esempio della reazione esagerata alla novità della conserva in scatola illustra bene l’uso ironico di questa espressione.
- Scantusu: Si riferisce sia a qualcosa che incute paura sia a una persona paurosa. È stata usata, ad esempio, per descrivere la percezione popolare di Luigi Pirandello.
- Scrusciu di carta e cubbàita nenti: Questa espressione indica qualcosa che fa molto rumore o è appariscente, ma manca di sostanza. Può essere usata per discorsi politici vuoti o per imballaggi eccessivi e inutili.
- Sfunnapedi: Descrive un tranello o una trappola. L’origine è legata a un gioco crudele che si faceva sulla spiaggia, rendendo l’idea di qualcosa che fa perdere l’equilibrio inaspettatamente.
- Sticchiu di zoppa u cavaddru ‘un azzoppa: È una credenza popolare legata al piacere sessuale, un detto che riflette particolari visioni sulla sessualità.
- Sunnu cosi di Pirinnellu: Commenta situazioni intricate, paradossali o difficili da comprendere. Riflette la visione popolare delle opere di Luigi Pirandello, spesso percepite come complesse o assurde.
- Taliarsi: Indica una forma di comunicazione segreta basata esclusivamente sugli sguardi. È nata dalla necessità storica di diffidare delle parole e trovare altri modi per intendersi.
- Tiniri u mortu dintra u ripostu: Significa attendere con impazienza un’eredità o un beneficio futuro, come se si nascondesse in casa il “morto” da cui si aspetta qualcosa.
- Tragediaturi: Definisce una persona che organizza scherzi pesanti, a volte crudeli, che possono avere conseguenze inaspettate o spiacevoli per la vittima.
- U iocu da musca: Era un gioco che, sorprendentemente, poteva portare alla meditazione e influenzare i percorsi di vita dei partecipanti, dimostrando come anche attività semplici potessero avere risvolti profondi.
- Un centilimetro cchiù, un centilimetro meno, nella flabbica non porta pinione: È una giustificazione ironica per costruzioni che non sono perfettamente dritte o precise, ma che sono comunque solide e funzionali, tipica di una certa praticità e tolleranza verso l’imperfezione.
- Unn’è cosa di spartiricci u pani ‘nzemmula: È considerata la peggiore accusa che si possa rivolgere a qualcuno. Viene usata per chi tradisce il sacro legame dell’ospitalità, rifiutando persino di condividere il pasto.
- U ‘ngrisi scurdatu e tempii: Descrive una persona che appare smarrita, confusa o disorientata, come uno straniero che si è perso e non sa dove andare.
- U rimorsu di Vicenzu Inclima ca fili dannu peiu di prima: Indica che i tentativi di rimediare a un errore o a una situazione difficile possono, in realtà, peggiorare ulteriormente le cose, un monito contro le soluzioni affrettate.
- U sticchiu unn’avi né storia né mimoria: Esprime la credenza popolare che le donne dimentichino facilmente le esperienze passate, in particolare quelle legate alla sfera affettiva o sessuale.
Ma una semplice raccolta di detti popolari può davvero svelare gli “aspetti profondi della cultura e della mentalità locale” senza un’analisi metodologica rigorosa?
Il capitolo presenta le espressioni come rivelatrici di aspetti profondi della cultura e della mentalità locale, ma non chiarisce la metodologia utilizzata per derivare tali significati e generalizzazioni. Per comprendere appieno il valore e i limiti di un approccio basato sui proverbi, sarebbe utile approfondire le discipline della linguistica, dell’antropologia culturale e della sociologia del linguaggio. Autori come Ferdinand de Saussure per la linguistica, Clifford Geertz per l’antropologia interpretativa, o Pierre Bourdieu per la sociologia potrebbero offrire strumenti concettuali per analizzare in modo più critico e contestualizzato il rapporto tra lingua, cultura e società.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]