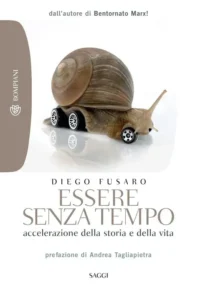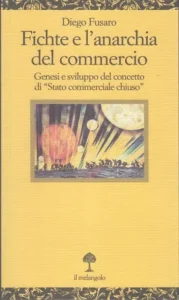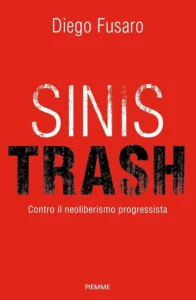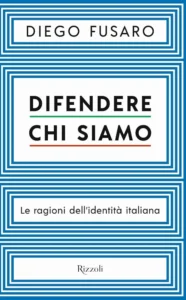1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il futuro è nostro. Filosofia dell’azione” di Diego Fusaro è un libro che ti sbatte in faccia la realtà di oggi: quella sensazione di essere chiusi in una gabbia, lontani dall’idea di libertà che un tempo ci spingeva a uscire dalla “caverna”. Il problema, dice Fusaro, è che la società capitalistica ci ha convinto che questo mondo, per quanto imperfetto, sia l’unico possibile, spegnendo l’immaginazione e la voglia di cambiare, lasciandoci soli e rassegnati (l’individuo atomizzato nella civiltà di Robinson Crusoe). Il libro analizza la violenza silenziosa del mercato, la precarietà che ci ruba il futuro e l’alienazione (o reificazione) che ci fa sentire estranei a noi stessi e agli altri, trasformando i rapporti umani in legami tra cose. Ma non è solo una critica al capitalismo e alla globalizzazione; è una chiamata a riscoprire la ragione dialettica, un modo di pensare che smaschera i falsi realismi e ci ricorda che la realtà non è un destino immutabile, ma è fatta dalla nostra azione (prassi trasformatrice). È un invito a usare il pensiero critico, a capire che l’essere deriva dal fare (deduzione dell’essere dal fare) e che l’idealismo dialettico è uno strumento per riprenderci la nostra libertà. Fusaro parla anche del ruolo dello Stato nazionale contro il potere del mercato finanziario e l’eurocrazia. In sintesi, è un libro che ti spinge a riaccendere l’utopia, a credere di nuovo nella possibilità di cambiare il mondo (il reincanto del mondo), perché il futuro non è scritto, ma dipende dalla nostra filosofia dell’azione.Riassunto Breve
L’emancipazione umana, un tempo vista come un’uscita verso la libertà e la verità, si è trasformata nell’immagine di una gabbia, un orizzonte che sembra impossibile superare. La società di oggi, dominata dalla logica del mercato, non appare più come qualcosa che si può migliorare, ma come una realtà imperfetta che non si può cambiare, l’unico mondo possibile. Questa idea si diffonde perché non si riesce più a immaginare un futuro diverso, e la voglia di cambiare le cose viene sostituita da una rassegnazione cinica. Le persone si sentono sole e isolate, anche se vivono in mezzo agli altri; sono potenti come consumatori, ma impotenti di fronte alle forze del mercato. La società si divide in individui egoisti, uniti solo dal desiderio di comprare, in un sistema che dice che tutti sono uguali ma mantiene grandi differenze. Questa solitudine diffusa crea una società spenta, piena di insoddisfazione. La rabbia non trova sfogo collettivo e diventa frustrazione personale, portando a un atteggiamento passivo, dove le persone accettano la loro condizione senza cercare alternative.Anche la critica rischia di non servire a nulla, limitandosi a denunciare i problemi senza proporre soluzioni. La gabbia, che prima sembrava un limite da superare, diventa un destino accettato. Esiste una violenza economica nascosta ma potente, che si manifesta con il potere dei mercati globali e la precarietà del lavoro, limitando la libertà. L’ideologia dominante nasconde questa violenza, concentrandosi su problemi passati per non far vedere quelli presenti. La libertà che viene esaltata è solo la libertà di comprare. Il lavoro precario toglie il futuro alle nuove generazioni, costringendole a vivere senza certezze, e questo viene accettato come normale.Il pensiero che cerca di capire le contraddizioni del sistema (il pensiero dialettico) viene messo da parte a favore di un modo di pensare unico che accetta tutto, anche se si presenta in forme diverse. Questo pensiero unico celebra molte idee e modi di vivere diversi, ma in realtà nasconde il dominio assoluto del mercato. Le persone perdono la capacità di agire per cambiare la realtà. L’economia di mercato diventa quasi una religione, con leggi che sembrano divine e inevitabili. Anche la scienza, concentrata sui numeri, serve questo sistema, senza una visione critica. La tecnica, usata dal capitale, rende tutto più veloce ma impedisce di pensare a un futuro diverso, intrappolando le persone in un presente dove conta solo comprare e vendere, in una ricerca continua di qualcosa che non soddisfa mai.Il pensiero dialettico oggi sembra strano perché è legato alla critica, alla possibilità di cambiare e alla storia, cose che non piacciono allo spirito del tempo. Pensare in modo dialettico significa vedere la realtà come qualcosa che cambia continuamente, non come qualcosa di fisso. La realtà è piena di contraddizioni e si supera sempre. La critica vera cerca di cambiare la realtà che contesta, e l’azione trasformatrice è la messa in pratica della critica. Una critica che non vuole cambiare le cose non è una vera critica. Il realismo di oggi, che si basa sui fatti, è una falsa realtà perché dimentica che la realtà è creata dalle azioni umane e cambia sempre. Anche la scienza, a volte, si perde in questa visione astratta, dividendo la realtà in pezzi senza vedere il quadro generale.Il dibattito tra chi dice che la realtà è fissa (nuovo realismo) e chi dice che tutto è interpretabile (postmodernismo) alla fine porta allo stesso risultato: accettare il mondo così com’è e non usare il pensiero dialettico. Queste posizioni, anche se sembrano diverse, sono modi per mantenere l’ordine attuale, impedendo un pensiero critico che voglia cambiare le cose. L’idealismo dialettico, spesso frainteso, mostra che il mondo non è un dato immutabile, ma è il risultato delle azioni umane. L’idealismo dice che il soggetto e l’azione vengono prima dell’oggetto: l’essere deriva dal fare. La conoscenza non è solo guardare la realtà, ma è un atto creativo del pensiero. L’idealismo è una filosofia della libertà perché riconosce che le persone possono cambiare la realtà.L’alienazione è quando le persone dimenticano di essere loro a creare il mondo e si sentono perse in una realtà che sembra esterna e indipendente. L’idealismo cerca di superare questa alienazione. La nostalgia può essere una forza che rifiuta il presente e spinge verso un futuro migliore. L’idealismo è una filosofia pratica che vuole cambiare il mondo e far sì che le persone riprendano il controllo della propria vita. Il mondo moderno è segnato da una mancanza di autenticità, dove le persone sono ridotte a cose, senza un vero futuro. Questa situazione si vede nella produzione e nel consumo, dove la produzione crea il consumatore a sua immagine. Le cose create dagli uomini sembrano vive, e gli uomini diventano solo strumenti in un mercato che sembra divino.Questa alienazione non è solo dal proprio lavoro, ma dalla possibilità di realizzare pienamente le proprie capacità. La produzione domina la vita, trasformando le persone in ingranaggi di un sistema che funziona per se stesso. Questo crea un mondo strano, dove la vita di tutti i giorni è governata da logiche poco chiare. L’alienazione nasce quando si dimentica il legame tra soggetto e oggetto, pensando che l’oggetto esista da solo. Il mondo del mercato appare rovesciato, dove le persone sono formalmente libere ma in realtà schiave. I prodotti creati dagli uomini (il non-Io) diventano i “signori del mondo”, imprigionando le persone.Il capitale non è solo una cosa, ma un rapporto sociale che appare come una cosa. Il feticismo delle merci nasconde il lavoro umano, trasformando i rapporti tra le persone in rapporti tra cose. Le idee stesse possono riflettere e giustificare questa situazione, presentando un mondo capovolto. È necessario capire come le idee nascono dalla realtà storica e sociale per smascherare l’ideologia che fa sembrare naturale il dominio dell’oggetto sul soggetto. L’idea di progresso impedisce di criticare il sistema attuale, portando a visioni che, pur criticando l’autorità, finiscono per favorire il capitalismo globale. Si critica l’idea di un “comunismo capitalistico” che addomestica l’idea di comunismo.Si sottolinea invece l’importanza dello Stato nazionale per opporsi alla globalizzazione e al potere finanziario, pianificando l’economia per i cittadini e agendo come forza morale contro la divisione causata dal mercato. L’eurocrazia, dominata dalla finanza, è vista come un passo verso un capitalismo totale che indebolisce gli Stati e i diritti sociali. Uscire dall’euro e riprendere la sovranità nazionale sono considerate azioni rivoluzionarie per ricostruire la comunità e contrastare il potere finanziario. L’immigrazione e l’idea di società multiculturale sono criticate perché viste come utili al capitale per abbassare i costi del lavoro e favorire l’omologazione globale. Si propone un’idea di comunità che valorizzi le identità nazionali e culturali contro l’omologazione del mercato e l’influenza americana.La filosofia deve tornare a criticare e a voler cambiare le cose, opponendosi al conformismo degli intellettuali e promuovendo un pensiero che riapra la possibilità di cambiare contro l’idea che nulla possa cambiare. La filosofia idealistica, che mette al centro l’azione e il soggetto, è vista come uno strumento per superare l’alienazione capitalistica, in contrasto con chi vede la tecnica e il sistema come un destino inevitabile. In un mondo che sembra aver perso ogni magia, è necessario ritrovare un senso di meraviglia per dare significato alle aspirazioni politiche. Ritrovare questo senso è l’unico modo per superare l’apatia attuale, causata dalla perdita di punti di riferimento. L’utopia non è una fuga dalla realtà, ma uno strumento per affrontarla, immaginando scenari diversi e possibilità concrete di cambiamento.L’utopia, intesa come “fantasia concreta”, rifiuta l’idea che solo ciò che esiste sia possibile. Mostra nuove possibilità, opponendosi alla realtà attuale. La possibilità è l’essenza stessa della realtà; l’essere esiste perché è reso possibile. La realtà che vediamo è solo una delle tante forme possibili. In una realtà alienata e dominata dalle merci, la soluzione è duplice: mostrare che ciò che sembra naturale è in realtà storico e sociale, e risvegliare la capacità di immaginare possibilità diverse e un futuro dimenticato. L’azione che vuole cambiare le cose si impegna a contestare l’idea che le cose non possano cambiare, mostrando che il mondo oggettivo ha una base soggettiva e riaffermando la capacità umana di modificare la realtà.Il conflitto e l’opposizione al sistema economico tornano a essere possibili, soprattutto nell’immaginazione. L’invito è “osa fare!”, un appello a un pensiero critico che non si arrende. Cambiare la realtà dipende dalla capacità di pensarla come qualcosa che si può cambiare. L’azione efficace è preceduta dalla convinzione che sia possibile. Immaginare il cambiamento è la condizione necessaria per realizzarlo. È necessario cambiare il modo di pensare per vedere la realtà in modo nuovo e renderla diversa. Riattivare la possibilità di pensare all’azione e l’invito ad agire sono i punti centrali di una filosofia dell’azione rinnovata.Riassunto Lungo
1. Dalla Caverna alla Gabbia: L’Orizzonte Invalicabile
Il cambiamento della liberazione umana
Un tempo, immaginavamo la liberazione umana come l’uscita dalla caverna descritta da Platone. Questo simbolo rappresentava un percorso di crescita verso la verità e la libertà collettiva. Oggi, questa idea è cambiata radicalmente. Al posto della caverna, troviamo l’immagine della gabbia d’acciaio di Weber. Questa gabbia rappresenta la società attuale, percepita come un limite invalicabile, un orizzonte chiuso.La società capitalistica e l’assenza di alternative
La società di oggi è dominata dal capitalismo. Non la vediamo più come un sistema che può migliorare, ma come una realtà difettosa ma impossibile da cambiare. È diventata l’unico mondo possibile nelle nostre menti. Questa idea si basa sulla mancanza diAlternative immaginarie. Abbiamo smesso di sognare grandi cambiamenti e ci accontentiamo di sopportare la realtà con cinismo e rassegnazione.L’isolamento dell’individuo nella società moderna
Nella società moderna, l’individuo si sente solo e isolato, come Robinson Crusoe sulla sua isola. Viviamo una solitudine strana: ci sentiamo potenti come consumatori, ma impotenti di fronte alle forze impersonali del mercato. La società si divide in individui egoisti, uniti solo dalla voglia di consumare. In questo sistema, si parla di uguaglianza, ma le differenze tra le persone rimangono profonde.La frustrazione e l’assenza di cambiamento
Questa solitudine diffusa crea una società spenta, piena di insoddisfazione e impotenza. La rabbia delle persone non riesce a diventare un cambiamento collettivo, ma si trasforma in frustrazione personale. Questo porta a una mancanza di speranza, un nichilismo passivo. Le persone diventano come l’ultimo uomo descritto da Nietzsche, contento di essere sottomesso e incapace di immaginare un futuro diverso.La critica sterile e la rinuncia al cambiamento
Anche chi critica la società rischia di diventare inutile. La critica può trasformarsi in un esercizio intellettuale che denuncia i problemi del mondo senza proporre soluzioni. Questi critici si trovano in una posizione privilegiata, come in un “Grand Hotel Abisso”, dove possono osservare il mondo con distacco, ma senza fare nulla per cambiarlo. La gabbia d’acciaio, che una volta sembrava un limite da superare, diventa una prigione accettata, un destino senza via d’uscita.Se la gabbia d’acciaio è davvero invalicabile, come si spiega la storia delle lotte sociali e dei cambiamenti che hanno plasmato la società?
Il capitolo presenta una visione piuttosto statica e pessimistica, trascurando la natura dinamica e contestata delle strutture sociali. Per affrontare questa lacuna, si potrebbero esplorare teorie sociologiche del cambiamento sociale, come quelle di Marx, Gramsci o Touraine, che enfatizzano l’azione umana, il conflitto e la possibilità di trasformazione. Approfondire autori come Marx, Gramsci e Touraine potrebbe fornire una prospettiva più sfumata sul cambiamento sociale e la resistenza.2. La Violenza Silenziosa del Mercato
La Violenza Economica Nascosta
La società di oggi è segnata da una forma di violenza economica che non si vede, ma che è ovunque e molto forte. Questa violenza si manifesta attraverso il potere dei mercati internazionali, le politiche economiche che favoriscono il libero mercato e il lavoro precario. Tutto ciò toglie libertà alle persone, sia a livello singolo che collettivo, andando oltre le forme di violenza fisica che conosciamo. La divisione tra destra e sinistra non sembra più adatta per affrontare il problema principale: è necessario opporsi al capitalismo per liberare veramente le persone, rifiutando di accettare senza discutere il sistema economico attuale.La Falsa Libertà del Consumo
L’idea dominante è quella di nascondere questa violenza del mercato, spostando l’attenzione sugli orrori del passato per non far vedere le difficoltà di oggi. La libertà che viene tanto esaltata si riduce alla possibilità di comprare e consumare, mentre il sistema di produzione continua a esercitare una violenza economica che nega ogni altro tipo di libertà. Il lavoro precario, simbolo di questa violenza, ruba il futuro alle nuove generazioni, obbligandole a vivere in una situazione instabile e senza sicurezze, accettata con rassegnazione come se fosse inevitabile.Il Pensiero Critico Ostacolato
Il pensiero capace di capire e denunciare le contraddizioni del sistema viene messo da parte, preferendo un modo di pensare unico che si presenta in diverse forme, dal non credere in niente allo scetticismo. Questo pensiero unico esalta una varietà di valori e modi di vivere che in realtà nascondono il potere assoluto del mercato. La difficoltà di agire concretamente per cambiare le cose è un’altra conseguenza di questo sistema. Le persone, ridotte a consumatori isolati e disillusi, accettano passivamente la precarietà e la violenza economica, in una società che spinge a dimenticare l’importanza di stare insieme e che distrugge ogni forma di aiuto reciproco.Il Mercato come Religione
L’economia di mercato diventa quasi una religione, un sistema che impone le sue regole come se fossero leggi divine e immutabili. La scienza stessa, con la sua attenzione ossessiva per i numeri e i calcoli, si mette al servizio di questa religione, esaltando l’ordine esistente e rinunciando a criticare e a voler cambiare la realtà. La tecnologia, usata completamente per fare gli interessi del denaro, accelera i ritmi di produzione e di consumo, ma allo stesso tempo blocca la possibilità di immaginare un futuro diverso, imprigionando l’umanità in un presente continuo dominato dagli oggetti da comprare e dalla ricerca continua di un piacere che non soddisfa mai veramente.Ma è davvero utile definire “violenza” un sistema economico, equiparandolo implicitamente alla violenza fisica e sminuendo così la gravità di entrambe le categorie?
Il capitolo descrive in modo efficace un disagio diffuso, ma l’uso del termine “violenza” per descrivere fenomeni economici rischia di essere fuorviante e di impedire un’analisi più precisa delle dinamiche in gioco. Per comprendere meglio le diverse forme di potere e coercizione presenti nelle società contemporanee, e per distinguere tra diverse categorie analitiche, sarebbe utile approfondire il pensiero di autori come Michel Foucault, che ha analizzato le microfisiche del potere e le diverse forme di controllo sociale, o Pierre Bourdieu, che ha studiato le forme di “violenza simbolica” e le disuguaglianze sociali riprodotte attraverso meccanismi culturali e sociali.3. Dialettica contro i falsi realismi
La ragione dialettica e la sua percezione attuale
Oggi, in un periodo storico in cui tecnologia e realismo dominano il pensiero comune, la ragione dialettica appare come qualcosa di estraneo. Questa sensazione di distanza nasce dal fatto che la dialettica è legata a concetti come critica, possibilità e storicità. Questi concetti non si accordano facilmente con lo spirito del nostro tempo. Infatti, pensare in modo dialettico significa considerare la realtà come un processo storico in continuo movimento, non come qualcosa di fisso e immutabile. La realtà dialettica è piena di contraddizioni interne e si trasforma costantemente.Critica e azione trasformatrice nella dialettica
La ragione dialettica unisce in sé due aspetti fondamentali: la critica e l’azione che mira a cambiare le cose. La critica vera ha lo scopo di modificare la realtà che contesta, mentre l’azione concreta è il modo in cui la critica si realizza. Una critica che non vuole portare a un cambiamento è considerata una critica falsa, che in realtà finisce per difendere la situazione esistente. Critica e azione sono separate solo a livello teorico, ma nella pratica sono strettamente collegate. La critica autentica valuta la realtà e agisce per farla diventare come dovrebbe essere, sfruttando al massimo le sue potenzialità.Il realismo contemporaneo come falsa realtà
Il realismo di oggi, che si basa sull’idea di oggettività e sui fatti concreti, si rivela in realtà una forma di realtà ingannevole, perché priva di una vera concretezza storica. Questo realismo confonde la realtà con un’oggettività che ha dimenticato la storia, non considerando che la realtà è il risultato delle azioni umane e che è in continua evoluzione. Anche la scienza, tanto apprezzata dai realisti, cade in questa mancanza di concretezza, dividendo la realtà in piccole parti isolate e perdendo di vista l’insieme dinamico e storico.Convergenza tra nuovo realismo e postmodernismo
Il confronto tra nuovo realismo e postmodernismo, che sembrano opposti, in realtà si unisce nel rifiuto della ragione dialettica e nell’accettazione della realtà così com’è. Entrambe queste correnti di pensiero, anche se in modi diversi, spingono a sopportare il mondo attuale, annullando la forza critica che porta al cambiamento. Il postmodernismo, con la sua attenzione all’interpretazione infinita, e il nuovo realismo, con la sua idea che la realtà non si può cambiare, evitano di mettere in discussione la situazione presente. Al contrario, la ragione dialettica riconosce in queste posizioni, apparentemente diverse, delle forme di pensiero che difendono il potere dominante, eliminando la possibilità di una riflessione critica e di un cambiamento reale.Ma è davvero utile e sensato parlare di “finanzmarxismo” per descrivere le dinamiche attuali?
Il capitolo introduce un concetto vago come quello di “finanzmarxismo” senza definirlo chiaramente, rischiando di generare confusione e di oscurare analisi più precise delle dinamiche economiche e politiche contemporanee. Per comprendere meglio le critiche al capitalismo globale e le diverse posizioni ideologiche, sarebbe utile approfondire le teorie marxiste classiche, ma anche le analisi più recenti sulla globalizzazione e sul ruolo della finanza nell’economia contemporanea. Autori come David Harvey o Giovanni Arrighi potrebbero offrire strumenti concettuali più solidi per analizzare le trasformazioni del capitalismo.7. Il Reincanto del Mondo
Nel mondo di oggi, sembra che ci sia una perdita di magia, un senso di disincanto generale. Per questo, è importante ritrovare un nuovo incanto verso il mondo che ci circonda. Questo significa dare di nuovo un significato profondo alle nostre speranze politiche. Riacquistare questo senso è l’unico modo per superare la mancanza di stimoli che caratterizza il nostro tempo, in cui sembra che abbiamo perso le nostre guide principali. L’utopia, che spesso viene vista come qualcosa di negativo o irrealizzabile, diventa invece uno strumento fondamentale per affrontare i problemi di oggi. Non è un modo per scappare dalla realtà, ma piuttosto un modo per immaginare e costruire un futuro diverso e migliore partendo da quello che abbiamo adesso.L’Utopia come strumento concreto
L’utopia, vista come una “fantasia concreta”, non si limita a ciò che esiste già. Ci apre gli occhi su nuove possibilità per il mondo, opponendosi attivamente alla situazione attuale. Seguendo l’idea che la pratica è fondamentale, la potenzialità diventa l’essenza stessa della realtà, una forza che cambia e influenza tutto ciò che esiste. La realtà che vediamo è il risultato di ciò che è stato reso possibile: l’essere è conseguenza del potere di fare. Questo gioco tra ciò che è possibile e ciò che è reale, insieme all’importanza della libertà, sono le basi di un modo di pensare che possiamo chiamare “prassismo trascendentale”.La possibilità di cambiare
Esiste sempre la possibilità di cambiare le cose, di modificare ciò che ci sembra immutabile. La possibilità è più grande della realtà stessa, perché la realtà è solo una delle tante forme che il possibile può prendere. In un mondo che ci sembra strano e dominato dal denaro, la soluzione sta in due azioni principali: capire che ciò che ci sembra naturale è in realtà frutto della storia e della società, e risvegliare in noi la capacità di immaginare un futuro diverso e di ricordare le speranze che abbiamo dimenticato. Il “prassismo trascendentale” si impegna a mettere in discussione ciò che ci viene presentato come inevitabile, mostrando che il mondo che ci circonda è influenzato dalle persone e che noi abbiamo la capacità di cambiarlo e migliorarlo.Osare l’azione
Tornare a opporsi al sistema economico dominante è di nuovo possibile, soprattutto con l’immaginazione. Il motto diventa “osa fare!”, un invito a pensare in modo critico senza accettare passivamente la realtà. Cambiare la realtà dipende dalla nostra capacità di immaginarla diversa. Per agire efficacemente, dobbiamo prima credere che il cambiamento sia possibile. Immaginare il cambiamento è il primo passo per realizzarlo concretamente. Quindi, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per vedere la realtà in una luce nuova e trasformarla davvero. Rimettere in moto la capacità di pensare all’azione e spingere ad agire sono i punti chiave di una nuova filosofia dell’azione.Ma è davvero sufficiente “re-incantare il mondo” con l’utopia per risolvere problemi concreti, o rischiamo di ignorare le radici materiali e strutturali del “disincanto” stesso?
Il capitolo presenta l’utopia come strumento di cambiamento, ma sorvola sulle cause profonde del “disincanto” contemporaneo. Senza un’analisi delle strutture economiche e sociali che generano alienazione, il rischio è di proporre una soluzione idealistica che non affronta le questioni materiali. Per comprendere meglio le dinamiche del disincanto e le sue radici, sarebbe utile approfondire autori come Max Weber e le sue analisi sulla razionalizzazione del mondo moderno, o studiare le teorie critiche della società che indagano le basi materiali dell’alienazione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]