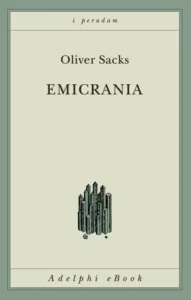Contenuti del libro
Informazioni
“Il fiume della coscienza” di Oliver Sacks ti porta in un viaggio pazzesco dentro la mente, ma non solo quella umana. Sacks, un po’ come Darwin con l’evoluzione delle piante e i loro ritmi nascosti, guarda come funziona la vita a livelli diversi. Scopri che l’intelligenza e la mente non sono solo roba da umani o animali complessi; anche i lombrichi o le meduse mostrano forme di apprendimento e comportamento complesso grazie ai neuroni. Ma la cosa forte è che la nostra stessa mente, quella umana, non è così affidabile come pensiamo. La memoria umana è fallibile, a volte ci convinciamo di ricordi che non sono nostri (criptomnesia), e la nostra percezione sensoriale costruisce una specie di verità narrativa, non è una registrazione perfetta. Poi c’è la creatività, che Sacks collega all’equilibrio interiore e all’omeostasi del corpo. E la coscienza stessa? Forse non è un flusso continuo ma una serie di scatti, come suggeriscono certi disturbi o la percezione visiva. Infine, Sacks ti fa notare come anche la storia della scienza ha i suoi “scotoma”, idee importanti che vengono dimenticate e poi riscoperte, mostrando che il progresso non è lineare. È un libro che ti apre gli occhi su quanto sia strano e affascinante il modo in cui percepiamo il mondo e noi stessi.Riassunto Breve
La vita nel mondo naturale mostra processi che si svolgono su scale temporali diverse dalla nostra percezione. Le piante, considerate statiche, evolvono e si adattano, come dimostrano gli studi sui fiori e sulle piante insettivore, mostrando dinamiche attive e strutture con funzioni precise. La percezione del tempo stesso è variabile e può cambiare in situazioni estreme o per disturbi neurologici, indicando una regolazione cerebrale della velocità. La capacità di mostrare comportamenti complessi non è solo degli animali superiori. Organismi semplici come i lombrichi e invertebrati marini possiedono sistemi nervosi organizzati che permettono movimenti coordinati e strategie di sopravvivenza. Anche i protozoi mostrano forme elementari di apprendimento. I neuroni sono simili in tutto il regno animale; la complessità deriva dal loro numero e organizzazione. Animali come insetti e polpi dimostrano notevoli capacità cognitive. La mente non è confinata a un’area specifica, ma è distribuita e dinamica. La memoria umana non è un registro perfetto; ricordi vividi possono essere imprecisi o basati su esperienze altrui, e idee esterne possono sembrare originali (criptomnesia). La percezione sensoriale, come l’udito, è una costruzione attiva del cervello, non una registrazione passiva, il che può portare a errori. Non esiste un meccanismo interno che garantisca la verità oggettiva di ricordi o percezioni; la verità è spesso una storia costruita. Questa fallibilità permette flessibilità e creatività. La creatività ha origine nel gioco e nell’imitazione, richiede maestria tecnica ma anche audacia e incubazione inconscia. Le intuizioni creative possono emergere improvvisamente. Il benessere fisico, regolato dall’equilibrio interno (omeostasi), è legato alla capacità creativa; il ristabilirsi dell’equilibrio dopo un disturbo può portare a un’esplosione di energia. La percezione e la coscienza, pur sembrando continue, potrebbero essere una successione rapida di momenti distinti, come suggerito da disturbi neurologici e ricerche sulla visione. La coscienza emerge dall’interazione di gruppi neuronali che si formano e dissolvono rapidamente. La storia della scienza mostra che scoperte importanti vengono spesso dimenticate per anni (scotoma) perché premature o non accettate, per poi essere riscoperte. Il progresso scientifico non è lineare, ma procede con salti e dimenticanze influenzati dal contesto.Riassunto Lungo
1. I Ritmi Nascosti della Vita
Charles Darwin ha osservato come il mondo naturale mostri processi che si svolgono su scale temporali diverse da quelle che percepiamo normalmente. Ha studiato le piante, spesso considerate immobili, dimostrando invece la loro evoluzione e l’adattamento attraverso la selezione naturale. Darwin ha analizzato come i fiori, con le loro forme, colori e profumi, si siano evoluti per favorire l’impollinazione grazie agli insetti, mostrando una complessa coevoluzione. Ha anche notato adattamenti specifici come la diversa lunghezza degli stili nelle primule (eterostilia) e i meccanismi di cattura e digestione nelle piante insettivore come la drosera, evidenziando capacità che sembrano quasi animali. Inoltre, ha studiato i movimenti delle piante, come la circumnutazione, un movimento circolare universale, suggerendo che anche gli organismi apparentemente fermi possiedono dinamiche attive. Queste osservazioni botaniche sono state prove importanti per l’evoluzione, mostrando il “senso” funzionale delle strutture biologiche e rivelando ritmi vitali che sfuggono alla nostra attenzione quotidiana.La Nostra Percezione del Tempo
La nostra stessa percezione del tempo e della velocità non è fissa, ma può variare in modo sorprendente. In situazioni estreme, come quelle di pericolo o durante sforzi fisici intensi, il tempo sembra rallentare. Alcune condizioni neurologiche, come il parkinsonismo e la sindrome di Tourette, mostrano alterazioni molto marcate nella velocità dei movimenti e dei pensieri, con stati di rallentamento o accelerazione che non sono normali. Questi disturbi ci fanno capire quanto il cervello regoli finemente la velocità delle nostre funzioni neurali e motorie. La capacità umana di percepire e interagire con il tempo è limitata dalla nostra biologia, ma gli strumenti tecnologici ci permettono di osservare fenomeni che avvengono a velocità molto diverse, dalla scala degli atomi alla storia dell’universo, ampliando enormemente la nostra comprensione delle dinamiche naturali e dei loro ritmi nascosti.Ma cosa c’entrano i lentissimi ritmi evolutivi delle piante con la percezione soggettiva e patologica del tempo umano?
Il capitolo presenta due aree di indagine molto distinte: da un lato, i processi biologici che si manifestano su scale temporali geologiche o comunque molto lente (l’evoluzione delle piante, la coevoluzione); dall’altro, la variabilità della percezione del tempo a livello neurologico e psicologico nell’essere umano. Il legame concettuale tra questi due ambiti, al di là della generica idea di “ritmi nascosti” o limiti della percezione, non è pienamente sviluppato, lasciando una lacuna argomentativa. Per comprendere meglio come scale temporali biologiche diverse e la percezione soggettiva del tempo possano essere messe in relazione, sarebbe utile approfondire discipline come la cronobiologia, la neurofisiologia della percezione e la filosofia del tempo. Autori come Oliver Sacks, per la parte neurologica e percettiva, e Henri Bergson, per le riflessioni sulla durata e il tempo vissuto, possono offrire spunti per colmare questa distanza concettuale.2. La Mente Oltre i Confini Tradizionali
Comportamenti complessi e la capacità di adattarsi, spesso visti come segni di “mente” o “intelligenza”, non si trovano solo negli animali che consideriamo più evoluti. Anche organismi apparentemente semplici mostrano capacità sorprendenti. Già Charles Darwin notò che i lombrichi sanno cambiare le loro reazioni in base a quello che succede intorno e risolvere piccoli problemi, quasi avessero una loro forma di “mente”. George Romanes, studiando animali marini senza spina dorsale come le meduse, scoprì che hanno sistemi nervosi organizzati. Questi permettono loro di muoversi in modo coordinato, di cacciare e sfuggire ai pericoli. Alcune meduse, come le cubomeduse, hanno persino occhi complessi e riescono a imparare e ricordare.La base nervosa delle capacità
Alla base di queste capacità ci sono le cellule nervose, chiamate neuroni. È interessante notare che i neuroni sono fatti in modo simile in quasi tutti gli esseri viventi, dai più semplici ai più complessi, come capì Sigmund Freud all’inizio dei suoi studi. Quello che cambia è quanti neuroni ci sono e come sono collegati tra loro, formando una rete di “sinapsi”. Questa rete permette scambi di informazioni molto veloci, grazie a speciali “canali” nelle cellule. Avere un sistema nervoso più sviluppato e veloce ha aiutato gli animali a imparare meglio e ad agire in modo più efficace nel loro ambiente.Forme elementari di apprendimento
Anche esseri viventi fatti di una sola cellula, come i protozoi, mostrano forme base di apprendimento. Possono diventare più sensibili a uno stimolo dopo averlo ricevuto più volte (sensibilizzazione) o, al contrario, smettere di reagire se lo stimolo si ripete senza conseguenze (abituazione). Negli animali che hanno un sistema nervoso, queste forme di apprendimento durano più a lungo. Studiare animali semplici come la lumaca di mare Aplysia ha aiutato gli scienziati a capire come funziona la memoria a livello delle cellule: si basa su cambiamenti nelle connessioni (sinapsi) tra i neuroni.Intelligenza in insetti e polpi
Salendo nella scala evolutiva, incontriamo animali con capacità cognitive ancora più sorprendenti. Gli insetti, ad esempio le api, sanno riconoscere forme e colori e usano una sorta di “danza” per comunicare alle altre api dove trovare il cibo. I polpi, che hanno un sistema nervoso molto grande e complesso distribuito anche nei tentacoli, sono noti per la loro intelligenza. Possono imparare guardando gli altri (apprendimento per osservazione) e risolvere problemi, mostrando comportamenti che a volte ci stupiscono per la loro complessità e furbizia.Una mente diffusa e dinamica
Questi esempi ci portano a considerare la “mente” non solo come qualcosa chiuso dentro un cervello, ma come una capacità più diffusa e in continuo cambiamento. Già Sigmund Freud aveva intuito questa idea di una mente “distribuita” e non fissa in un solo punto, influenzato dal pensiero di Hughlings Jackson che vedeva il sistema nervoso organizzato per livelli. Freud pensava che la memoria non fosse come un archivio dove mettiamo i ricordi, ma piuttosto un processo attivo: ogni volta che ricordiamo, in realtà “ricostruiamo” o “riscriviamo” l’esperienza passata, un po’ come dicono oggi le neuroscienze quando parlano di “ricategorizzazione”. In sostanza, la capacità di “pensare” o “elaborare” informazioni si manifesta in modi diversi a seconda di come è organizzato il corpo e il sistema nervoso nei vari tipi di animali.Ma definire “mente” o “intelligenza” anche le reazioni elementari non rischia di svuotare di significato questi concetti?
Il capitolo presenta un’interessante carrellata di capacità adattive in organismi diversi, ma l’uso estensivo dei termini “mente” e “intelligenza” per descrivere comportamenti che vanno dalla semplice abituazione nei protozoi alla risoluzione di problemi nei polpi solleva un dubbio fondamentale sulla definizione stessa di questi concetti. Equiparare risposte riflesse o meccanismi di apprendimento basici a ciò che intendiamo comunemente per mente o intelligenza, specialmente nel contesto umano, potrebbe creare confusione e offuscare le differenze qualitative significative. Per chiarire questo punto e approfondire la questione di cosa sia veramente la “mente” e dove tracciare il confine (se esiste), sarebbe utile esplorare il dibattito nella filosofia della mente e nella biologia cognitiva. Autori come Daniel Dennett o John Searle offrono prospettive molto diverse e stimolanti su questi temi, mettendo in discussione le definizioni funzionaliste e biologiche della coscienza e dell’intelligenza.3. Le Creazioni Fallibili della Mente
La memoria umana non funziona come un registro perfetto degli eventi passati. Anche i ricordi che ci sembrano molto vividi possono non corrispondere esattamente alla realtà. A volte, esperienze che ci sono state raccontate da altri vengono assimilate e percepite come se le avessimo vissute in prima persona. Pensiamo, ad esempio, a ricordare un evento traumatico come un bombardamento basandosi sulla descrizione di qualcun altro, pur essendo convinti di esserci stati. Questa confusione sull’origine del ricordo è un fenomeno piuttosto comune.Quando i Pensieri Non Sono Nostri
Questa tendenza a incorporare informazioni esterne non riguarda solo i ricordi di eventi vissuti. Si manifesta anche nel modo in cui pensiamo e creiamo. Idee, frasi o concetti che abbiamo ascoltato o letto possono riemergere in seguito e sembrarci completamente originali. Questo fenomeno è conosciuto come criptomnesia e può portare, senza volerlo, a casi di plagio. La nostra mente assorbe e rielabora continuamente gli stimoli che vengono da fuori, rendendo difficile capire da dove provenga esattamente un pensiero o un’idea.Anche i Sensi Possono Sbagliare
La nostra mente non è infallibile solo per quanto riguarda la memoria del passato. Anche la percezione sensoriale, come l’udito, è un processo attivo di costruzione da parte del cervello. Quando i segnali uditivi che riceviamo sono incompleti o distorti, il cervello cerca comunque di dare un senso a ciò che sente, e questo a volte può portare a fraintendimenti o errori. Questi sbagli nella percezione dimostrano che il cervello costruisce attivamente la realtà che percepiamo, non si limita semplicemente a registrarla in modo passivo.La Verità È Una Storia Che Ci Raccontiamo
Nel cervello non esiste un meccanismo interno che garantisca che i nostri ricordi o le nostre percezioni corrispondano alla verità oggettiva. Ciò che una persona considera vero è il risultato di un insieme di esperienze sensoriali, immaginazione e una continua rielaborazione. La verità che sperimentiamo è spesso una “verità narrativa”, una storia che costruiamo e modifichiamo nel tempo. Questa natura fallibile della memoria e della percezione, pur potendo causare errori e distorsioni, offre anche una grande flessibilità, stimola la creatività e ci permette di assimilare conoscenze e punti di vista da altri, contribuendo a una comprensione che si costruisce insieme.Davvero la creatività sboccia magicamente dopo un’influenza, o il legame tra omeostasi e scintilla creativa è più un’ipotesi affascinante che una certezza scientifica?
Il capitolo suggerisce una correlazione diretta tra il ristabilirsi dell’equilibrio fisico dopo una malattia e un’esplosione di energia creativa. Questa connessione tra stato fisiologico e capacità creativa è intrigante, ma presentata in modo piuttosto assertivo per un campo di ricerca che è ancora complesso e dibattuto. La relazione tra processi biologici profondi come l’omeostasi e manifestazioni cognitive ed emotive complesse come la creatività non è un semplice rapporto causa-effetto lineare. Per approfondire questo aspetto e capire meglio le sfumature di tale legame, sarebbe utile esplorare studi nel campo della psiconeuroendocrinoimmunologia, che analizza le interazioni tra i vari sistemi del corpo e il loro impatto sul benessere psicologico e sulle funzioni cognitive superiori. Approfondire autori che si occupano di neuroscienze cognitive e psicologia della creatività potrebbe fornire una prospettiva più basata sull’evidenza scientifica dei meccanismi sottostanti.5. La Mente a Scatti e le Idee Dimenticate
La Natura Discontinua della Percezione
La percezione e la coscienza sembrano continue, come un flusso ininterrotto. Eppure, alcuni pensatori passati le hanno descritte come una serie molto veloce di momenti separati, quasi come un filo fatto di tante perle distinte. L’idea che la continuità sia costruita è suggerita anche da invenzioni come lo zootropio o il cinema, che prendono immagini fisse e le mostrano in rapida successione, ingannando il cervello e creando l’illusione del movimento continuo.
Ci sono anche condizioni mediche che fanno vedere la percezione visiva come una successione di “fotogrammi”. Questo accade, ad esempio, durante certi attacchi di emicrania o in un disturbo chiamato achinetopsia, dove non si percepisce il movimento fluido. Questo sostiene l’idea che quello che percepiamo come continuo sia in realtà un’integrazione fatta dal cervello di informazioni separate. Le ricerche più recenti sul cervello confermano che il sistema visivo elabora le informazioni in momenti successivi, che poi vengono uniti per farci avere una percezione fluida. La coscienza stessa sembra nascere dall’attività di grandi gruppi di neuroni che si formano e si dissolvono velocemente. Quando questi gruppi superano una certa soglia di attività e rimangono attivi per un breve istante, creano quello che percepiamo come un singolo momento cosciente.
Le Idee Dimenticate nella Scienza
Nella storia della scienza, succede spesso che scoperte o osservazioni importanti vengano dimenticate o non considerate per molto tempo. Questo fenomeno viene chiamato “scotoma”. Ci sono diverse ragioni per cui accade: a volte le idee arrivano troppo presto rispetto ai tempi, altre volte non si incastrano bene con le teorie accettate in quel momento, oppure vengono considerate poco importanti o relegate a campi di studio non riconosciuti. Ci può essere anche resistenza dovuta a pregiudizi o rivalità tra scienziati. Un esempio è la descrizione fatta nell’Ottocento di allucinazioni visive durante l’emicrania, o la perdita della percezione di un arto dopo una lesione, o la cecità ai colori acquisita (acromatopsia). Queste osservazioni furono dimenticate per decenni e riscoperte e accettate solo molto tempo dopo, quando il contesto scientifico era cambiato ed era più pronto ad accoglierle.
Questo dimostra che il progresso scientifico non segue un percorso dritto e lineare. Invece, procede con salti, momenti in cui le cose vengono dimenticate, e poi riscoperte. È un processo influenzato da tanti fattori esterni e dalla capacità della comunità scientifica di essere aperta a idee nuove, specialmente quelle che mettono in discussione le conoscenze già consolidate.
Se la coscienza è davvero un’illusione costruita da “momenti” neurali, come suggerisce il capitolo, non si rischia di semplificare eccessivamente il mistero dell’esperienza soggettiva e la sua apparente unità?
Il capitolo presenta l’idea di una percezione e coscienza discontinue come se fosse un dato di fatto ampiamente confermato, basato sull’attività di gruppi neuronali. Tuttavia, il salto dall’attività neuronale oggettiva all’esperienza soggettiva della coscienza, con la sua ricchezza qualitativa e il senso di un flusso unitario, rimane uno dei problemi più complessi e dibattuti nella scienza e nella filosofia. Ridurre la coscienza a una semplice “integrazione” di “momenti” neurali rischia di ignorare o minimizzare l’enigma di come l’attività fisica nel cervello dia origine alla consapevolezza interiore. Per esplorare più a fondo questa lacuna, è fondamentale addentrarsi nella filosofia della mente e nella neuroscienza della coscienza, confrontandosi con autori che hanno affrontato il “problema difficile” della coscienza e le diverse teorie sull’integrazione neurale e l’esperienza soggettiva.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]