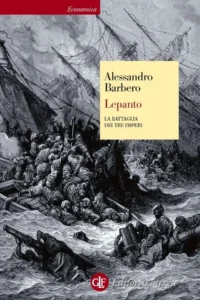1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano” di Alessandro Barbero ti porta nel cuore del Ducato di Savoia tra il tardo Medioevo e l’inizio dell’età moderna. Non aspettarti uno stato super organizzato, ma piuttosto un mosaico di territori dove il potere centrale del duca si scontra e si intreccia con le autonomie locali e le assemblee dei Tre Stati. Il libro scava a fondo nell’amministrazione sabauda, mostrandoti come funzionavano gli ufficiali locali, dai castellani ai balivi, e come la venalità degli uffici, cioè la pratica di pagarli o appaltarli, abbia trasformato radicalmente il rapporto tra il duca e chi gestiva il territorio, portando a figure come i luogotenenti che diventano i veri padroni sul campo. Scoprirai anche le sfide militari del Quattrocento, confrontando l’esercito sabaudo con quelli degli stati italiani, e capirai quanto la cronica crisi finanziaria abbia influenzato tutto, spingendo verso riforme e portando all’ascesa di centri di potere regionali come il Consiglio e poi il Senato di Torino in Piemonte. Non manca uno sguardo sulla corte ducale, centro di intrighi, fazioni nobiliari e rappresentazione del potere, che si evolve tra vecchie tradizioni e nuove organizzazioni, dalla gestione della Casa e della Camera ai servizi come la guardia e il servizio postale. È un viaggio affascinante per capire come funzionava davvero uno stato complesso come il Ducato di Savoia, stretto tra Francia e Italia, attraverso la lente della sua amministrazione e della sua corte.Riassunto Breve
Il ducato di Savoia nel tardo Medioevo si presenta come un territorio non centralizzato, ma un insieme di aree con amministrazioni locali autonome, basate sulle comunità e sui signori feudali. Le assemblee dei Tre Stati partecipano alla vita politica approvando i sussidi richiesti dal duca. L’organizzazione territoriale varia, con castellanie e balivati, ma anche ufficiali diversi come vicari e capitani, specialmente in Piemonte. Gli ufficiali locali rappresentano il duca, gestiscono il demanio e la giustizia, spesso legati alle élite locali. Dalla fine del Trecento, la venalità degli uffici diventa comune: gli ufficiali prestano denaro al duca e gli uffici vengono appaltati. Questo porta i titolari a delegare le funzioni a luogotenenti privati, che diventano i veri amministratori sul territorio. Sotto duchi deboli, gli uffici sono concessi gratuitamente, i titolari diventano assenteisti e la venalità si sposta sulla nomina del luogotenente, che paga per incassare gli emolumenti. L’ufficio si sdoppia: il titolare riceve una rendita, il luogotenente gestisce. Le entrate pubbliche vengono appaltate direttamente al luogotenente, portando a malversazioni e privatizzazione. All’inizio del Cinquecento, gruppi finanziari controllano gli uffici, aggirando le regole e limitando i rendiconti. La debolezza finanziaria è una caratteristica centrale. L’amministrazione è decentrata, con la Camera dei Conti che controlla solo a posteriori. Il tesoriere generale deve anticipare denaro al duca con prestiti personali, un requisito fondamentale per l’incarico. La crisi finanziaria spinge a proposte di riforma per accentrare le entrate, ma queste incontrano resistenza, soprattutto l’idea di non anticipare fondi. La gestione finanziaria rimane disordinata, con alto ricambio di tesorieri e difficoltà a trovare candidati disposti a rischiare il patrimonio. Il ducato manca di un sistema di debito pubblico, dipendendo dai prestiti degli ufficiali. L’esercito sabaudo si basa sulla cavalleria con arcieri a cavallo e fanteria composta da leve comunali poco affidabili e mercenari. Il reclutamento dei nobili è una chiamata di volontari pagati, non un obbligo rigido, portando a un esercito meno professionale rispetto alle compagnie di ventura italiane. La struttura di comando è meno centralizzata. Il bilancio annuo è molto inferiore rispetto agli stati italiani, rendendo i costi militari insostenibili e limitando il numero e la permanenza delle truppe. Parallelamente, il sistema di governo si evolve. Il Consiglio cismontano per le province piemontesi acquisisce autonomia e si stabilisce a Torino, diventando un centro di governo regionale con prerogative crescenti. La sua importanza cresce con il peso del Piemonte. Questo porta a una progressiva integrazione con la componente giudiziaria del Consiglio residente, che si sposta anch’essa a Torino. Dalla simbiosi nasce il Senato di Torino, principale tribunale e centro amministrativo, che supera il Consiglio di Chambéry e sopravvive all’occupazione francese. Emerge la figura del governatore provinciale, un funzionario con poteri estesi, diverso dal balivo, che agisce da mediatore tra il principe e gli interessi locali, difendendo le autonomie provinciali nei periodi di debolezza ducale. La corte ducale è un centro di dinamiche politiche e sociali, dove la nobiltà compete per il favore del principe ma difende anche la propria autonomia. Si formano fazioni che possono attirare l’intervento di potenze vicine, limitando la sovranità ducale e mostrando la fragilità del potere centrale. La corte sotto Carlo II si trasforma da organizzazione per la vita quotidiana a centro di rappresentanza, articolata in Casa, Camera, Scuderia, Cappella, guardia e araldi. Introduce innovazioni come il servizio a quartieri per gli scudieri e sviluppa il servizio postale. La corte della duchessa Beatrice ha autonomia finanziaria e personale proprio. La corte rappresenta un costo elevato per il bilancio ducale, gestito riducendo stipendi o offrendo incarichi senza paga fissa, contando sulla lealtà. La corte mostra un mix di usanze medievali e tendenze organizzative che anticipano le corti dell’Antico Regime.Riassunto Lungo
1. Il Ducato di Savoia: Un Mosaico di Poteri Locali
Il Ducato di Savoia nel tardo Medioevo non funziona come uno stato con un potere centrale forte, ma è piuttosto un insieme di territori diversi, ognuno con le proprie amministrazioni locali che godono di molta autonomia. L’organizzazione del governo si basa sulla comunità, che può essere sotto il controllo diretto del duca (demaniale) o affidata a un signore (infeudata). Queste comunità partecipano attivamente alla vita politica attraverso le assemblee chiamate i Tre Stati. È qui che vengono approvati i soldi richiesti dal duca, e queste assemblee diventano un punto di riferimento importante per il duca, specialmente nei momenti difficili.Come è organizzato il territorio
Il territorio è diviso in aree più piccole chiamate castellanie e balivati. Questa divisione è più chiara e definita nelle zone al di là delle Alpi (Oltralpe). In Piemonte, invece, le cose sono un po’ più complicate a causa delle diverse origini dei territori. Questo porta a una maggiore varietà di persone che ricoprono cariche locali, come vicari o capitani, e l’organizzazione in balivati è meno uniforme rispetto all’Oltralpe.Il ruolo degli ufficiali locali
Gli ufficiali locali, come i castellani e i balivi, rappresentano l’autorità del duca sul territorio. Sono responsabili della gestione dei beni del duca, dell’amministrazione della giustizia e del mantenimento dell’ordine pubblico. Spesso, queste figure hanno stretti legami con le famiglie importanti e potenti del luogo in cui operano.La pratica della vendita degli uffici
Dalla fine del Trecento, diventa comune la pratica di “vendere” gli uffici pubblici. Gli ufficiali iniziano a prestare denaro al duca, e in cambio ottengono l’appalto degli uffici. Questo sistema porta i titolari degli uffici a delegare le loro funzioni a persone di loro fiducia, chiamate luogotenenti privati. Sono questi luogotenenti a diventare i veri amministratori che gestiscono il territorio giorno per giorno. Anche se questa pratica viene criticata, continua a esistere e influenza profondamente il modo in cui il potere centrale del duca si relaziona con le aree più periferiche del ducato.Ma se la vendita degli uffici indeboliva il controllo ducale, perché mai il duca la permetteva, o addirittura la promuoveva?
Il capitolo accenna alla pratica della vendita degli uffici e al prestito di denaro al duca, ma non approfondisce sufficientemente le ragioni economiche e politiche che spinsero i duchi ad adottare e mantenere tale sistema, né le sue implicazioni a lungo termine per la struttura del potere. Per comprendere meglio questo apparente paradosso – un duca che sembra minare il proprio controllo vendendo cariche – sarebbe utile esplorare la storia finanziaria degli stati tardomedievali e le diverse strategie di costruzione statale. Approfondimenti in storia economica e storia delle istituzioni, magari leggendo autori che si sono occupati della formazione degli stati europei o specificamente della finanza ducale sabauda, possono offrire il contesto necessario per capire come questa pratica si inserisse nelle dinamiche di potere e quali compromessi comportasse per l’autorità centrale.2. Dallo Servizio al Guadagno: La Trasformazione degli Uffici Ducali
Gli uffici ducali, sia quelli centrali che quelli presenti nelle diverse località, venivano assegnati direttamente dal duca e prevedevano il pagamento di uno stipendio a chi li ricopriva. Spesso, però, la nomina a un ufficio implicava un versamento di denaro al principe. Questa pratica, che si potrebbe definire una forma di venalità, non consisteva in una vendita definitiva e trasmissibile per via ereditaria, ma piuttosto in un prestito, chiamato “prestanza”, che il funzionario doveva concedere al principe al momento della sua nomina. Nei momenti di difficoltà economica, si ricorreva anche all’appalto a termine, un sistema in cui l’ufficio stesso o le entrate che ne derivavano venivano affittati a chi offriva di più per un periodo limitato.Inizialmente, per l’ufficio di vicario nella città di Torino, venivano scelti nobili locali o funzionari che svolgevano questa professione per mestiere. Questi funzionari a volte prestavano denaro al principe, ottenendo in cambio una garanzia rappresentata dall’ufficio stesso. Sotto il governo di Amedeo VIII, si affermò maggiormente la pratica della “prestanza”, dove l’ufficiale anticipava denaro al duca ma continuava a ricevere uno stipendio ed era pienamente responsabile del suo operato. La vendita privata degli uffici, come l’appalto a terzi, era proibita, ma questa regola veniva aggirata attraverso la figura del luogotenente, che veniva scelto direttamente dal vicario titolare.La Crescita del Luogotenente e l’Appalto Privato
Sotto i duchi Ludovico e Iolanda, a causa della debolezza del potere ducale, si iniziò a concedere uffici gratuitamente ai favoriti di corte. Questi ultimi spesso non svolgevano effettivamente il lavoro, diventando di fatto degli assenteisti. In questa situazione, il luogotenente, che era il sostituto del vicario titolare, assunse un ruolo sempre più centrale e divenne la figura che gestiva realmente l’ufficio. La venalità, cioè la pratica di pagare per ottenere un incarico, si spostò quindi sulla nomina del luogotenente, che era disposto a pagare per ottenere la gestione effettiva dell’ufficio. Si diffuse così l’appalto privato: il luogotenente pagava una somma, chiamata “firma”, al vicario titolare per avere il diritto di incassare tutti i compensi e le entrate legati all’ufficio.Questo sistema portò a una vera e propria divisione dell’ufficio: il vicario titolare divenne essenzialmente una persona che percepiva una rendita, mentre il luogotenente era colui che si occupava della gestione pratica e incassava i guadagni effettivi. Il principe ratificava la nomina del luogotenente, spesso in cambio di un prestito di denaro. In alcuni casi, le entrate pubbliche che l’ufficio doveva gestire venivano appaltate direttamente al luogotenente. Questa situazione favorì la diffusione di malversazioni e portò a una progressiva privatizzazione delle funzioni pubbliche. Era comune che il luogotenente venisse chiamato “vicario” dalla popolazione, mentre il vicario titolare, che ormai aveva solo una funzione formale e di rendita, veniva definito “gran vicario”.Il Controllo dei Gruppi Finanziari
All’inizio del Cinquecento, il controllo degli uffici passò sempre più nelle mani di potenti gruppi finanziari. Questi gruppi utilizzavano uno strumento chiamato “rinuncia in favorem” per aggirare le regole che imponevano un’alternanza nelle cariche e mantenere il controllo degli uffici nel tempo. L’obbligo per chi gestiva l’ufficio di presentare un rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese cessò quasi completamente. Chi otteneva l’ufficio in appalto si limitava a pagare al duca la somma fissa che era stata concordata in precedenza, trattenendo per sé tutto il resto. Il duca Carlo II arrivò al punto di appaltare addirittura il titolo stesso di “gran vicario” a un finanziere, concedendogli il diritto di scegliere e nominare il vicario che avrebbe effettivamente gestito l’ufficio. In questo modo, l’ufficio pubblico si trasformò sempre più in uno strumento utilizzato dall’oligarchia finanziaria che dominava la città per i propri interessi economici.Ma questa trasformazione degli uffici fu solo un declino verso la privatizzazione e la corruzione?
Il capitolo descrive efficacemente il passaggio degli uffici ducali da strumenti di servizio a meccanismi di guadagno privato, evidenziando le pratiche di prestanza, appalto e il ruolo crescente dei gruppi finanziari. Tuttavia, l’enfasi quasi esclusiva sulle conseguenze negative come la privatizzazione e le malversazioni potrebbe non cogliere l’intera complessità del fenomeno. Per comprendere appieno questa trasformazione, è fondamentale considerare il contesto economico e fiscale dell’epoca, le pressioni finanziarie sui sovrani e le diverse prospettive storiografiche sulla venalità degli uffici, che a volte è stata interpretata anche come una forma di investimento o di consolidamento sociale. Approfondire la storia economica e amministrativa del periodo, e leggere autori che hanno studiato la formazione dello stato moderno e le sue necessità finanziarie, può offrire una visione più sfaccettata.3. Eserciti a Confronto: Savoia e Italia nel Quattrocento
La campagna militare del 1449, che vide il Ducato di Savoia opporsi a Francesco Sforza, mette in luce notevoli differenze nell’organizzazione militare rispetto agli stati italiani dell’epoca.Organizzazione Militare Sabauda
La cavalleria sabauda utilizzava la lancia composta da tre uomini a cavallo, una formazione simile a quella impiegata in Italia. Un elemento distintivo era la presenza di un consistente numero di arcieri a cavallo, aggregati direttamente agli uomini d’arme. Questa scelta di integrare tiratori a cavallo, sebbene da alcuni considerata un segno di tattica superata, rappresentava una caratteristica tipica delle forze transalpine. La sua efficacia sul campo di battaglia dipendeva in larga misura dalla quantità di arcieri schierati. Per quanto riguarda la fanteria, essa era formata in parte da leve comunali, soldati reclutati per brevi periodi e poco affidabili, e in parte da mercenari di provenienza italiana.Reclutamento e Struttura di Comando
Il sistema di reclutamento nel ducato si basava sulla chiamata dei nobili vassalli. Questo metodo si traduceva in una sorta di convocazione di volontari che venivano pagati, piuttosto che in un rigido obbligo di leva. Il risultato era un esercito composto in gran parte da soldati dilettanti, con scarsa esperienza militare, in netto contrasto con le compagnie di ventura italiane, formate da professionisti veterani. Anche la struttura di comando sabauda appariva meno centralizzata rispetto a quella italiana. I tentativi di introdurre figure come il “collaterale”, pensate per migliorare l’efficienza del comando, non ebbero il successo sperato.Debolezza Finanziaria e Conseguenze
La principale vulnerabilità del ducato risiedeva nelle sue finanze. Con un bilancio annuale significativamente inferiore rispetto a stati italiani come Venezia o Milano, sostenere i costi della guerra del 1449 si rivelò insostenibile, poiché l’intera spesa equivaleva all’intero bilancio annuale. L’ingaggio di condottieri italiani divenne una necessità per compensare l’inesperienza e le frequenti defezioni delle truppe sabaude. Tuttavia, questa spesa assorbiva una parte eccessiva delle risorse militari disponibili. La carenza di fondi limitava drasticamente il numero di soldati che potevano essere schierati e per quanto tempo potevano rimanere in servizio. Ciò portò a una netta inferiorità numerica rispetto all’esercito dello Sforza. L’inesperienza delle truppe e la mancanza di risorse finanziarie adeguate furono le ragioni fondamentali del fallimento della campagna.Ma la trasformazione della corte sotto Carlo II fu solo una questione di “mostrare il potere”, o c’erano ragioni più profonde e contesti europei che il capitolo trascura?
Il capitolo descrive le modifiche strutturali della corte sabauda sotto Carlo II, ma la spiegazione della sua trasformazione in un centro di potere e prestigio sembra limitata. Per comprendere appieno questo cambiamento, è fondamentale considerare il contesto politico e sociale più ampio dell’Europa del XVI secolo. Discipline come la storia politica, la storia sociale e la storia delle istituzioni possono fornire gli strumenti analitici necessari. Autori che hanno studiato le corti rinascimentali e la formazione degli stati moderni, come Norbert Elias o Peter Burke, possono offrire prospettive utili sulle dinamiche di corte e il loro ruolo nella costruzione del potere sovrano.7. La Corte Sabauda tra Servizio e Patronato
I Servizi della Corte Ducale
La corte ducale di Carlo II si organizza attraverso diversi servizi essenziali. La cappella, dotata di un proprio tesoriere, si occupa dei riti religiosi e della distribuzione delle elemosine. È guidata dal grande elemosiniere e include figure come elemosinieri, cantori (anche provenienti da altri paesi) e predicatori o confessori. Questo settore funziona anche come strumento di patronato, offrendo opportunità per carriere ecclesiastiche e benefici. La guardia degli arcieri costituisce l’unica forza di polizia stabile a disposizione del duca. Il suo compito è mantenere l’ordine pubblico, contrastare il banditismo e eseguire incarichi specifici per conto del duca e del Consiglio ducale. Gli arcieri, spesso di origine non nobile, potevano migliorare la propria posizione sociale e ottenere incarichi amministrativi, sebbene non fossero particolarmente ben visti dalla popolazione. Gli araldi, organizzati in una gerarchia sotto il re d’armi, servono come messaggeri per personalità di rilievo e svolgono funzioni cerimoniali, specialmente quelle legate all’ordine cavalleresco e alle rappresentanze simboliche.La Corte della Duchessa Beatrice
Accanto alla corte del duca, opera la corte della duchessa Beatrice. Questa corte gode di autonomia finanziaria e dispone di personale dedicato. Inizialmente composta da membri portoghesi, si arricchisce nel tempo con figure savoiarde e piemontesi. All’interno di questa corte esistono gerarchie specifiche, che danno maggiore rilievo alle donne e al personale di origine portoghese. È interessante notare che il personale portoghese veniva spesso pagato in scudi, una moneta il cui valore si rivalutava rispetto al fiorino, la moneta utilizzata per il personale locale maschile.Costi e Caratteristiche Generali
La gestione della corte, sia quella del duca che quella della duchessa, rappresenta un onere finanziario considerevole per le casse ducali. Le spese aumentarono in modo significativo dopo il matrimonio di Carlo II. Nonostante le difficoltà economiche e la crescita dell’inflazione, Carlo II cercò di contenere i costi riducendo gli stipendi o offrendo incarichi che non prevedevano una paga fissa. In questi casi, il duca faceva affidamento sulla lealtà dei suoi cortigiani. La corte di Carlo II combinava pratiche e usanze di stampo medievale con tendenze organizzative che prefiguravano le corti tipiche dell’epoca dell’Ancien Régime.Davvero la corte della duchessa si basava su una discriminazione salariale o c’è una spiegazione più complessa dietro il pagamento in scudi per i portoghesi e in fiorini per i locali?
Il capitolo evidenzia come il personale portoghese della duchessa ricevesse pagamenti in scudi, una moneta che si rivalutava rispetto al fiorino usato per il personale locale maschile. Tuttavia, limitarsi a constatare questa differenza senza esplorarne le ragioni economiche, politiche e sociali lascia una lacuna nell’argomentazione. Per comprendere appieno questa dinamica, sarebbe utile approfondire la storia economica del periodo, analizzando il valore reale delle diverse monete e le politiche finanziarie delle corti rinascimentali. Approfondire gli studi sulle corti, in particolare quelle italiane e transalpine, e l’opera di storici che si sono occupati della gestione del personale cortigiano e delle sue implicazioni sociali ed economiche, come ad esempio autori che studiano la storia sabauda o la storia economica del Rinascimento, aiuterebbe a contestualizzare meglio questa scelta e a capire se si trattasse di una forma di privilegio, di una necessità legata all’origine del personale, o di una pratica comune dell’epoca.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]