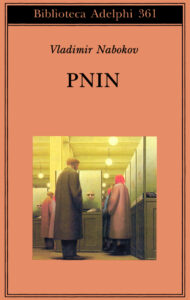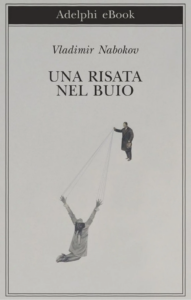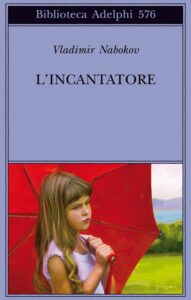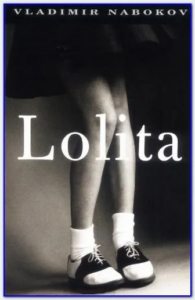1. Trasloco e Rivelazioni Letterarie
La primavera berlinese accoglie Fëdor Konstantinovič nella sua nuova dimora, in Tannenbergstrasse. Una via tranquilla, un microcosmo di negozi e vita quotidiana, improvvisamente animata da un furgone di traslochi. L’arrivo del furgone, proprio di fronte alla sua abitazione, innesca riflessioni sul continuo movimento della vita e sulla ricerca di un punto fermo. Una telefonata interrompe i preparativi. Aleksandr Jakovlevič Černyševskij porta notizie entusiasmanti: una recensione lusinghiera della raccolta di poesie di Fëdor, un’opera dedicata all’infanzia. L’animo del poeta si riempie di gioia, mentre ripercorre mentalmente i versi che celebrano i giochi, le paure notturne, i giocattoli e la tenuta di campagna di Lesino. La recensione sottolinea l’abilità di Fëdor nel fondere l’universale e il personale, creando piccole, potenti immagini poetiche. Ricordi luminosi e oscuri, giochi all’aperto e malattie, la njanja e le ombre della notte. Un evento tragico incombe: il suicidio di Jaša, figlio dei Černyševskij, coinvolto in un triangolo amoroso con Rudolf e Olja. Un’ombra di dolore e incomprensione si stende sulla vicenda. Una serata letteraria a casa Černyševskij attende Fëdor. Un ambiente intellettuale, stimolante ma soffocante, dove l’incontro con il critico Končeev accende il fuoco dell’ambizione e dell’insicurezza. La serata, però, precipita nel ridicolo con la lettura di una tragedia filosofica. Il ritorno a casa è un’odissea: senza soldi per il tram, con le chiavi sbagliate. Eppure, proprio in questa difficoltà, nasce l’ispirazione. Un verso inatteso, un rifugio nella creazione artistica. La notte berlinese, nella sua nuova “tana”, vede Fëdor comporre febbrilmente una nuova poesia, suggello di un nuovo inizio.2. Berlino, tra Letteratura e Memoria del Padre
A Berlino, dopo una serata dedicata alla letteratura russa, Fëdor Konstantinovič discute con Končeev di autori come Gončarov, Dostoevskij, Turgenev e Puškin. Analizzano insieme stili e temi, confrontando pregi e difetti di poeti e prosatori. Uscito dalla serata, Fëdor cammina per le strade di Berlino, ma la sua mente torna all’infanzia, alla tenuta di Lesino, ai genitori e alla sorella Tanja. Sul tram, diretto a una lezione di francese, prova fastidio per i passeggeri tedeschi, attenuato solo dall’incontro con un connazionale. La lezione si rivela l’ennesimo fallimento. Fëdor, invece di insegnare francese a un anziano industriale, sente il richiamo della scrittura. Abbandona l’idea della lezione, rinunciando a un guadagno immediato, per dedicarsi a un progetto letterario più importante. Passeggia tra gli alberi di Natale in vendita e il ricordo della recente visita della madre riaffiora. La madre spera ancora che il padre di Fëdor sia vivo. Ricorda i momenti passati con lei, le passeggiate immaginarie nei luoghi dell’infanzia e il comune desiderio del ritorno del padre. Il padre, famoso entomologo, è sempre nei suoi pensieri. La sua vita straordinaria, i viaggi, la passione per le farfalle, hanno profondamente influenzato Fëdor. L’ammirazione per il padre e l’amore per Puškin si fondono in un’idea: un libro sulla vita del padre, scritto con lo stile puro del grande poeta russo. Fëdor si dedica allo studio, raccoglie materiali, legge le opere del padre e di Puškin, preparandosi a celebrare la memoria di entrambi.6. La Tempesta Critica e l’Alba della Libertà
Il libro di Čerdyncev divide la critica russa all’estero: da un lato, accuse di superficialità e confusione stilistica, unite a irriverenza verso figure come Černyševskij; dall’altro, lodi per l’arguzia e il valore artistico, pur con riserve sullo stile. Questo clima di contrasti si riflette nella caotica vita associativa berlinese, dove emergono dispute finanziarie e lotte di potere, dalle quali Fëdor si tiene distante, preferendo la propria indipendenza. Un’oasi di pace, in questo contesto, è una giornata nel bosco di Grunewald, interrotta però da un furto che costringe Fëdor a un imprevisto incontro con Končeev. I due discutono di letteratura, dei difetti del libro di Fëdor e della natura stessa della poesia, in un dialogo che stimola profonde riflessioni. Ma la vera svolta è l’imminente partenza degli Ščëgolev per Copenaghen: la loro casa, fino ad allora rifugio e ostacolo per Fëdor e Zina, si svuota, aprendo la strada a una convivenza libera. La sera, i due cenano insieme, sognando un futuro condiviso e nuovi progetti letterari, come un romanzo che indaghi il ruolo del destino nelle loro vite. Un sogno vivido, in cui riappare il padre di Fëdor, turba la notte, ma è solo un’ombra passeggera. Il risveglio porta con sé la luce di una nuova libertà, di un futuro da costruire insieme a Zina, senza più ostacoli.7. La riscoperta del testo russo
Questa edizione italiana nasce da una novità importante: si basa sul testo russo originale de “Il Dono”, pubblicato nella sua interezza solo nel 1952. Prima, le traduzioni si rifacevano a una versione inglese, nata dopo il grande successo di “Lolita”. Fu proprio “Lolita” a far nascere un grande interesse per Nabokov, e in particolare per le sue opere russe scritte prima di emigrare. La traduzione inglese, curata da Michael Scammell e controllata dallo stesso Nabokov, era diventata il punto di riferimento. Ma tradurre un’opera così legata alla cultura russa è un’impresa difficile.“Il Dono” è stato quindi letto per anni attraverso un filtro, quello inglese. Certo, Nabokov non era contrario alle contaminazioni tra lingue. Oggi, però, sentiamo il bisogno di un approccio più diretto, filologico, al testo russo originale. Non è vero che alcune opere sono intraducibili: spesso è solo pigrizia, o una visione di Nabokov troppo legata a “Lolita”. Questa visione metteva in ombra le opere russe precedenti, considerate quasi minori. Ma “Il Dono” è un capolavoro della letteratura russa del Novecento.Nabokov stesso amava molto “Il Dono”. Diceva che era il suo romanzo russo più bello, più nostalgico, più russo (per come rappresenta la Russia perduta) e più classico (per la sua armonia). È un’opera pura, dove le parole esprimono con eleganza i temi più cari a Nabokov: la creazione artistica, la bellezza nascosta nella natura, l’inganno, l’errore, il legame profondo tra arte e vita. Il tutto animato da una passione che va oltre la realtà. Meno eccentrico di altre opere, “Il Dono” ci regala la meraviglia della narrazione, unendo perfettamente contenuto e linguaggio.Per capire a fondo “Il Dono”, bisogna conoscere bene la letteratura russa. Ci sono molti riferimenti, citazioni, allusioni. La traduzione italiana ha cercato di rendere chiaro quello che nel testo russo è sottinteso, senza però usare troppe note o spiegazioni complicate. Anche i giochi di parole, tipici di Nabokov, sono stati adattati per mantenere la loro forza.Un elemento impossibile da tradurre è il continuo riferimento alla “Vita di Černyševskij”, un’opera inventata che crea scandalo tra i russi emigrati. Questo libro immaginario si collega alla vera e vastissima letteratura critica su Nikolaj Gavrilovič Černyševskij, un personaggio storico russo molto discusso. La monografia inventata da Godunov-Čerdyncev ci mostra Černyševskij sotto una luce nuova, umana, diversa dalle interpretazioni sovietiche che lo esaltavano in modo esagerato.Un’altra presenza fondamentale, ma silenziosa, è quella di Puškin. Citazioni, atmosfere e personaggi che ricordano Puškin riempiono “Il Dono”, influenzando tutta la struttura del romanzo. “Il Dono” sembra quasi voler smentire l’idea che “Evgenij Onegin” di Puškin sia unico e irripetibile. Eppure, ne trae ispirazione per la sua natura di opera che parla di letteratura, per la sua capacità di cambiare stile e di inserire riflessioni e discussioni letterarie.Nabokov parla con naturalezza di scrittori russi di ogni epoca, dai grandi classici ai contemporanei. La letteratura russa diventa uno specchio, un punto di confronto per l’invenzione narrativa. Il romanzo ci racconta anche la vita degli intellettuali russi emigrati, con i loro riti e le loro discussioni letterarie, trasformando persone reali in personaggi. Il protagonista, Fëdor Godunov-Čerdyncev, ha molto in comune con Nabokov, ma rimane una figura a sé stante. Nabokov è un maestro nel trasformare la sua vita in qualcosa di più grande, che va oltre la semplice autobiografia.Il romanzo ha una struttura circolare, che genera un eterno presente, una sfida all’idea che il tempo scorra in modo lineare. Nel capitolo centrale, il terzo, assistiamo a una partita a scacchi immaginaria tra Puškin e Černyševskij. È una metafora del conflitto tra l’arte pura, che cerca solo la bellezza, e l’arte impegnata, che vuole cambiare il mondo. Il personaggio di Ščëgolev, invece, rappresenta la volgarità e la mediocrità, un vero e proprio incubo.L’arte di Nabokov, illuminata da Puškin, scopre il miracolo nelle cose di tutti i giorni, trasformando anche i dettagli più banali in qualcosa di straordinario. La realtà diventa come una foresta di simboli, dove ogni cosa rimanda a qualcos’altro. Ci fa riflettere su cosa sia reale e su come percepiamo il mondo. Ma questa trasparenza ha anche un lato oscuro: la presenza costante della morte. Le chiavi che Fëdor Konstantinovič porta sempre con sé simboleggiano il legame con la vita terrena, in contrasto con il finale aperto del romanzo. Un finale che ci invita a rileggere “Il Dono” all’infinito, come un processo creativo che non finisce mai, perché il confine tra arte e realtà è sottile come la morte.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]