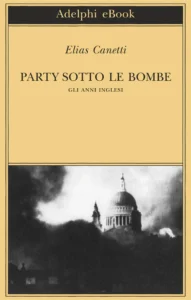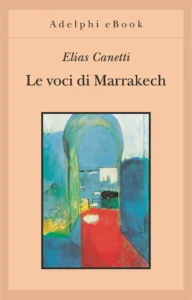L’esistenza si manifesta come un confronto incessante. La morte non è un punto di arrivo, bensì una presenza costante che richiede sfida. Il linguaggio rivela una vita autonoma, le parole creature sensibili e potenti. La memoria rielabora il passato, svelando dettagli insospettati che arricchiscono l’individuo. La verità emerge dalle domande personali, non dalla ricerca di approvazione pubblica. La vecchiaia trasforma la sensibilità, mentre l’incontro con l’altro genera un’eccitazione profonda e inerme. La scrittura si confronta con l’angoscia, cercando parole di forza. Ogni vita singola possiede un valore sacro. L’uomo lotta contro i propri limiti, la responsabilità si estende oltre il presente.
1. Sulla Sostanza della Vita e la Forza delle Parole
Scrivere è un processo continuo che richiede fiducia nella lingua. Questo processo deve concentrarsi sulla sostanza profonda della vita, evitando esperimenti linguistici che la trascurano o la rendono meno chiara. La morte è una presenza costante per i vivi, qualcosa che va affrontato attivamente, in contrasto con un atteggiamento di semplice rassegnazione. A volte, i pensieri filosofici su questi temi possono risultare ingannevoli. Ad esempio, la visione di Schopenhauer sulla morte sembra influenzata da elementi molto personali.Il Pensiero di Jacob Burckhardt
Jacob Burckhardt è una figura ammirata per diverse ragioni importanti. Si distingue per il suo netto rifiuto dei sistemi storici rigidi e predefiniti. Aveva una percezione acuta di un peggioramento in atto nella storia. Mostrava un profondo rispetto per le figure individuali e il loro ruolo. Possedeva un’intuizione preziosa sul valore duraturo dei testi antichi, un valore che giustifica pienamente una lettura attenta e approfondita di queste opere.Verità, Separazioni e Comprensione degli Altri
L’esposizione pubblica può compromettere l’onestà autentica. Una verità che sia veramente pubblica e sentita nasce invece da domande profondamente personali. Queste domande portano all’uso di parole che si caricano di un nuovo significato potente. Le separazioni, per quanto possano essere dolorose, sono uno strumento necessario. Permettono di ottenere lo spazio vitale indispensabile per il pensiero e la riflessione. Nella memoria, le persone vengono spesso ridotte a pochi “caratteri” dominanti. È fondamentale coltivare la capacità di vedere e apprezzare la loro unicità, anche creando nuovi modi per descrivere i tipi umani.La Forza della Lingua con Karl Kraus
La lingua usata da Karl Kraus è descritta come “corazzata”. Questa lingua offre una grande forza e uno slancio emotivo potente. Viene usata per opporsi con vigore a ciò che si rifiuta. Agisce con un’autorità che appare assoluta e laica. Questo è particolarmente evidente nella sua forte opposizione alla guerra. Attraverso la sua lingua, Kraus si identifica profondamente con le vittime.Desideri e la Realtà della Perdita
Esistono grandi desideri che rimangono irrealizzati. Tra questi, il desiderio più profondo è forse quello del ritorno dei morti. Questi desideri intensi e fondamentali sono diversi da quelli più superficiali. I desideri superficiali a volte possono essere soddisfatti. Ma la realtà inesorabile è che i morti non tornano.Ma è davvero sufficiente liquidare una visione filosofica come quella di Schopenhauer sulla morte semplicemente perché “sembra influenzata da elementi molto personali”?
Il capitolo accenna criticamente alla visione di Schopenhauer sulla morte, suggerendo che la sua presunta influenza personale la renda in qualche modo “ingannevole”. Questa affermazione, tuttavia, apre un varco logico significativo. Ci si potrebbe chiedere: in che misura le esperienze personali di un filosofo invalidano o, al contrario, informano e arricchiscono la sua prospettiva? La filosofia, dopotutto, non nasce forse spesso da una profonda riflessione sull’esistenza individuale e collettiva? Per esplorare questa complessa relazione tra vita e pensiero, sarebbe utile approfondire direttamente l’opera di Schopenhauer, ma anche confrontarsi con autori che hanno riflettuto sul ruolo della biografia nella filosofia, o che hanno offerto visioni alternative sulla morte e sul suo significato, come Nietzsche o Heidegger.2. Il Paesaggio Interiore e la Vita delle Parole
Il passato non è qualcosa di fisso e immutabile; la giovinezza si manifesta attraverso i dettagli trascurati della memoria, arricchendo la persona con ciò che sembrava perduto per sempre. Vivere non significa necessariamente seguire un percorso prestabilito; l’arte del vivere risiede piuttosto nella capacità di decidere cosa non fare. L’obbedienza a se stessi può soffocare la libertà interiore tanto quanto l’obbedienza imposta dagli altri; solo accettando una certa dose di incoerenza si può trovare vero respiro. Lo spazio interiore di una persona dipende dai salti e dai cambiamenti che è capace di compiere dentro di sé. Lo spirito, per nutrirsi, ha bisogno di afferrare le opportunità che il caso gli presenta.Il tempo che passa e la morte
Mentre il mondo sembra invecchiare ed espandersi, il futuro appare sempre più limitato e ristretto. In questo scenario, la morte si manifesta come una sfida profondamente personale, che ciascuno affronta senza poter ereditare regole o guide da chi lo ha preceduto. Trovare un senso può derivare dallo sfidare e disprezzare la morte, ma l’accettazione passiva e senza lotta non porta con sé alcun onore. È importante notare come, in certi casi, neanche il sopraggiungere della morte riesca a cancellare i sentimenti negativi come l’odio.La vita delle parole
La lingua non è un sistema statico, ma possiede una sua vitalità intrinseca; le parole stesse sono viste quasi come creature dotate di sensibilità propria. Per chi ha questa percezione, assistere alla deformazione delle parole è motivo di sofferenza profonda. Al contrario, la capacità di creare nuovi termini è considerata vitale, un modo per evitare che la lingua ristagni e si soffochi. Inoltre, la nostra percezione del mondo e il modo in cui diamo significato ai nomi sono profondamente influenzati dalla nostra etimologia personale, cioè dal legame con le prime lingue che hanno formato il nostro pensiero.L’invecchiare e la sensibilità che cambia
Il processo di invecchiamento non garantisce automaticamente un aumento della tolleranza, ma porta piuttosto a una trasformazione della sensibilità. Con il tempo, molte passioni si affievoliscono gradualmente. Persino l’aspirazione all’eternità, che in gioventù poteva apparire desiderabile, può assumere un aspetto inquietante man mano che ci si avvicina alla fine. La memoria, sebbene continui a funzionare, non è uno strumento docile; riporta alla luce ciò che era stato dimenticato in modo autonomo, seguendo logiche proprie e non la nostra volontà. Questo funzionamento capriccioso della memoria influenza profondamente la nostra percezione del passato.La scrittura autentica
Quando la scrittura è autentica, non punta a trovare un equilibrio o una mediazione, né si preoccupa di offrire tranquillità al lettore. Anzi, le opere che sembrano mancare di una vera intensità, di un fuoco interiore o di un’ossessione che le anima, risultano inevitabilmente deboli e quasi dolorose da leggere. Esistono esempi di autori che seguono strade molto diverse, come Robert Walser, la cui radicalità e capacità di raggiungere la verità in modo non diretto offrono un modello alternativo. Questo tipo di scrittura si distingue nettamente da quella di chi cerca di costruire una razionalità solo esteriore e artificiale.Relazioni e autonomia
A volte, mostrare benevolenza verso gli altri può nascondere una forma di soddisfazione personale e autocompiacimento. Capire veramente un’altra persona è un compito arduo, e il primo incontro è spesso caratterizzato da reazioni forti e immediate. La ricerca dell’autonomia e la lotta per la propria sopravvivenza si svolgono contando unicamente sulle proprie forze, senza aspettarsi aiuto da fonti esterne o superiori. La lode ricevuta dagli altri serve spesso a mettere in luce aspetti che non riconosciamo in noi stessi o qualità che non possediamo realmente. In ultima analisi, l’esistenza è un confronto incessante, sia con il proprio io interiore sia con la vastità e la diversità infinita del mondo che ci circonda.Ma se l’arte del vivere si riduce a decidere cosa non fare, non si rischia di svuotare l’esistenza di ogni slancio creativo e costruttivo?
Il capitolo, con la sua enfasi sulla negazione e sull’incoerenza come vie alla libertà, presenta una prospettiva stimolante ma potenzialmente limitante sulla natura dell’esistenza e dell’agire umano. Concentrarsi unicamente sulla sottrazione e sulla disobbedienza a sé stessi rischia di trascurare il ruolo fondamentale dell’azione positiva, della volontà che costruisce e del valore che può risiedere nella coerenza con i propri principi. Per approfondire il dibattito sulla libertà, l’azione e la costruzione del sé, confrontandosi con visioni che valorizzano l’aspetto propositivo dell’esistenza, si possono esplorare le opere di autori come Nietzsche, che ha indagato la volontà di potenza, Hannah Arendt, che ha riflettuto sull’azione nella sfera pubblica, o Sartre, per la sua analisi della libertà e della responsabilità.3. La resa dei conti con l’esistenza
Il peso della morte sull’esistenza Quando la morte si avvicina, impone di guardare all’esistenza in modo nuovo e profondo. Questa vicinanza richiede di vivere con intensità e serietà, concentrandosi solo su ciò che è davvero importante. Chiede una verità assoluta in ogni pensiero e parola. Questo confronto con la morte è un debito che bisogna onorare, un incontro diretto dove non servono difese o giustificazioni.La vita come dono e il tempo che passa La vita stessa può essere vista non come qualcosa a cui si ha diritto, ma come un regalo che può essere ripreso in qualsiasi momento. L’attaccamento eccessivo alla vita fa riflettere sull’avidità. Arrivare alla vecchiaia porta con sé la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni passate. C’è il rischio di sentirsi sminuiti dal tempo, arrivando persino a preferire di non aver mai vissuto.Scrittura e memoria Scrivere diventa un modo per affrontare l’inquietudine e per fissare i pensieri più preziosi che nascono spontaneamente. Si cercano parole che restino impresse, capaci quasi di essere lanciate contro l’idea della morte. Nella letteratura, ciò che non viene detto ha un grande peso, suggerendo una saggezza che va oltre le parole limitate. Il ricordo autentico è considerato il bene più vero che si possiede, anche se il passato tende spesso a essere abbellito nella memoria. Esiste il pericolo concreto di dimenticare il motivo profondo per cui si è vissuto, specialmente con il passare degli anni.L’inevitabilità della fine Non esiste alcuna protezione contro la morte. Considerarla una scelta possibile o rendersi disponibili ad essa è una posizione pericolosa. La vita mantiene il suo significato più profondo finché l’anima resta aperta e sensibile (“vulnerabile e ‘grezza’”) di fronte alla minaccia costante di essere annientata. La speranza di potersi illudere sulla sua inevitabilità non può mai essere completamente spenta.Ma su quali basi concrete o argomentazioni rigorose si fondano affermazioni così audaci sull’anima, la metamorfosi e la ‘vita’ delle parole?
Il capitolo presenta una serie di osservazioni e concetti affascinanti, che spaziano da presunte realtà empiriche (popoli che “vivono d’aria”) a profonde riflessioni sulla natura umana, l’anima e il linguaggio. Tuttavia, queste affermazioni, per quanto suggestive, mancano di un chiaro fondamento o di un percorso argomentativo che ne giustifichi la validità. Non viene spiegato come si arrivi a conoscere la natura intrinsecamente metamorfica dell’essere umano, il valore sacro dell’anima o il modo in cui le parole vengano “custodite” e si riversino su chi le ha proferite. Per colmare questa lacuna e comprendere meglio le possibili basi (o la loro assenza) di tali asserzioni, sarebbe utile approfondire discipline come la filosofia della mente, la filosofia del linguaggio e la metafisica. Autori come Platone, per le sue teorie sull’anima e la metempsicosi, o Wittgenstein, per le sue riflessioni sul linguaggio e il suo significato, potrebbero offrire prospettive diverse o fornire il contesto per valutare la solidità di queste affermazioni.7. Pensieri al termine del cammino
L’autobiografia ha il potere di rendere reale e potente tutto ciò che viene raccontato. Una verità, nel momento in cui viene espressa, rischia di perdere la sua essenza se accettata da tutti senza discussione. Una vita lunga, come quella di ottant’anni, non può essere narrata come se si fosse fermata prima del tempo. La struttura e il contenuto di un’autobiografia nascono da convinzioni profonde e radicate. Includere le esperienze e le presenze di molte persone diventa l’unico modo per mostrare la complessità e la ricchezza della realtà di una vita intera.La vecchiaia e la percezione di sé
Con l’avanzare dell’età, la vecchiaia sembra seguire sempre più regole proprie, perdendo la spontaneità e la casualità tipiche di altri periodi. Si arriva a provare un senso di fastidio per ciò che riguarda la propria persona, perché è diventato troppo familiare e noto. Le cose, invece, dovrebbero esistere per se stesse, libere dalle nostre interpretazioni o distorsioni. Ogni persona nuova che incontriamo porta una vitalità inaspettata e rinfrescante. Spesso si tende a riversare tutto di sé sugli altri, per poi spaventarsi della reazione che si provoca.La vecchiaia e la trasformazione interiore
Si sente il bisogno di osservare le forme degli animali per trovare una speranza, cercando i salti improvvisi e non i lenti passaggi intermedi. Le questioni più intime e private sono le sole che acquistano un vero significato. L’uomo, a questo punto della vita, non appare più come un essere eccezionale; è l’animale a esserlo. Ci si sente come se si immigrasse continuamente nello stesso luogo interiore, senza mai riuscire a orientarsi del tutto. Ci si emancipa da se stessi, provando un senso di sollievo, non desiderando più sapere nulla della propria persona.Il confronto con la morte
Si cerca di aumentare la consapevolezza della morte, quasi ingrandendo il pericolo che essa rappresenta. Tuttavia, questo tentativo non rende più forti né aiuta chi si trova in una situazione di rischio; risulta essere inefficace. L’unico risultato che si ottiene è un netto rifiuto. La morte viene maledetta e respinta con forza; accettarla sembrerebbe quasi un atto di auto-annientamento. Le parole usate per descriverla non sembrano mai nuove, ripetono sempre lo stesso concetto senza trovare una vera soluzione. Non si pensa alle ultime volontà o disposizioni, non si vuole concedere questo riconoscimento alla morte. Forse glorificarla, darle importanza, potrebbe portare a una maggiore comprensione di se stessi. La morte viene affrontata e respinta, senza che ci sia mai una vera e propria resa dei conti.Le relazioni e la ricerca di novità
Ogni persona nuova che incontriamo porta una vitalità inaspettata e rinfrescante. I malintesi che possono nascere nelle relazioni sono visti come fecondi e non vanno disprezzati. Spesso si tende a riversare tutto di sé sugli altri, per poi spaventarsi della reazione che si provoca. Esistono due tipi di amici: quelli la cui amicizia è dichiarata e nota a tutti, e quelli occulti, molto rari, che rappresentano una risorsa estrema a cui si ricorre solo in casi eccezionali.Vivere senza modelli e la metamorfosi
Vivere senza seguire modelli prestabiliti è un percorso possibile a ottant’anni, ma richiede la capacità di meravigliarsi e l’abbandono delle vecchie abitudini del passato. La sensibilità verso le fiabe e le storie fantastiche rimane viva, ma le nuove fiabe che si incontrano sembrano già conosciute, offrendo conferme anziché nuove prospettive. Si avverte un timore nei confronti di ciò che è frammentario e incompleto. La ricerca di persone nuove, che non diventino a loro volta dei modelli da seguire, è un aspetto fondamentale di questo modo di vivere. Tutto questo processo richiede una profonda metamorfosi interiore.Se l’aumentare la consapevolezza della morte porta solo al rifiuto, come può darle importanza condurre a una maggiore comprensione di sé?
Il capitolo presenta una contraddizione evidente nel suo approccio al confronto con la morte. Da un lato, si afferma che cercare di aumentare la consapevolezza della morte (“quasi ingrandendo il pericolo”) non rende più forti e porta solo a un “netto rifiuto”. Dall’altro, si suggerisce che “forse glorificarla, darle importanza, potrebbe portare a una maggiore comprensione di se stessi”. Il capitolo non spiega come si possa passare da un tentativo inefficace che genera rifiuto a un approccio che, dandole importanza, potrebbe invece essere fecondo per la conoscenza di sé. Manca un ponte logico o una distinzione chiara tra i due approcci. Per esplorare questa complessa relazione tra la consapevolezza della mortalità e la comprensione di sé, sarebbe utile confrontarsi con le riflessioni di autori come Martin Heidegger, che ha indagato il concetto di “essere per la morte”, o con gli studi psicologici sul lutto e l’accettazione della fine della vita, come quelli condotti da Elisabeth Kübler-Ross.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]