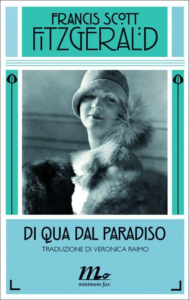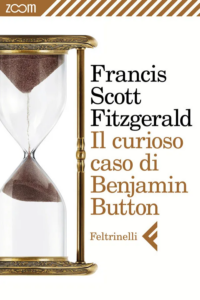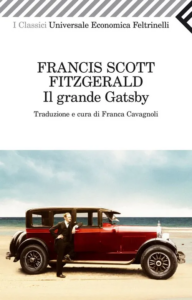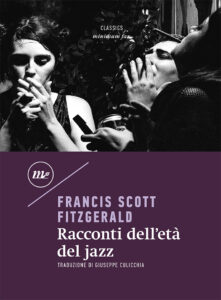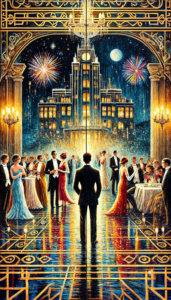1. Anatomia di un Crollo
La vita è un continuo cambiamento, un equilibrio precario tra eventi improvvisi e trasformazioni lente. Essere intelligenti significa affrontare idee contrastanti senza perdere la capacità di agire. Da giovani, si crede di poter controllare la vita con l’impegno e l’intelligenza, soprattutto in una carriera come quella dello scrittore, considerata affascinante e autonoma. I piccoli rimpianti della gioventù sembrano insignificanti di fronte alle difficoltà della vita adulta. Intorno ai trent’anni, però, può arrivare un crollo interiore del tutto inatteso. Non si tratta di un malessere fisico, né di un problema legato all’alcol, ma di una crisi nervosa, che si manifesta con emozioni fortissime. Questo crollo non nasce da un evento traumatico, ma emerge in un momento di calma. All’improvviso, si sente il bisogno di isolarsi, sopraffatti da una stanchezza profonda, cercando rifugio nel sonno e nella creazione di liste inutili. A un breve miglioramento segue una crisi ancora più grave. Ci si rende conto di aver vissuto oltre le proprie possibilità, privando la vita di ogni gioia. Anche le persone care appaiono lontane, private del loro significato. Il mondo esterno diventa insopportabile, provocando fastidio per suoni, immagini e persone. Si sviluppa un rifiuto verso molte categorie sociali, trovando sollievo solo nella compagnia di medici, bambini, anziani e poche donne idealizzate. Questa profonda sofferenza viene identificata come il crollo definitivo. Durante una conversazione, si tenta di minimizzare il proprio stato, paragonandolo a una crepa nel Grand Canyon, un problema esterno. Ma questa visione viene rifiutata, perché il problema è interiore e non può essere risolto dall’energia degli altri. Si accetta un futuro cupo, privo di speranza, come il sale che ha perso il suo sapore, citando un passo del Vangelo che annuncia l’inutilità.2. Fragilità Interiore
L’individuo si sente come un piatto incrinato, inutile e di scarso valore. Le parole di conforto, di solito utili, diventano inutili nel cuore della notte, quando l’angoscia si fa più forte. Questa continua autoanalisi, però, rischia di isolare la persona, allontanandola da possibili soluzioni o aiuti inaspettati.Tornano alla mente due momenti simili di crisi passata. Il primo, all’università di Princeton, quando una malattia, inizialmente scambiata per malaria, si rivelò essere tubercolosi. Questo costrinse la persona ad abbandonare gli studi, ma, col tempo, si trasformò in un’occasione per dedicarsi alla scrittura. Il secondo, dopo la guerra, quando una relazione finì per problemi di denaro. Anche in quel caso, la disperazione portò alla scrittura di un romanzo e a un cambiamento interiore, caratterizzato da una sfiducia nelle persone ricche.Per sedici anni, questa sfiducia e il desiderio di successo economico guidarono le sue azioni, nonostante le delusioni. Non c’è tristezza, ma un fastidio verso le proprie debolezze. La crisi di adesso è simile, ma più forte: ci si sente esposti, vulnerabili, irresponsabili. Si perdono i valori importanti, come la fiducia nel romanzo come forma d’arte, ora messo in discussione dal cinema e da altre forme d’arte collettive.In questo silenzio interiore, nasce il bisogno di pensare a fondo, cosa difficile e insolita. L’autoanalisi mostra che, dal punto di vista intellettuale, si è sempre dipeso da altri: una guida per l’intelligenza, un modello di comportamento, un maestro nell’arte, un esempio nelle relazioni e un punto di riferimento politico. La mancanza di una propria identità e di autostima crea un senso di vuoto, come un bambino sperduto in una casa enorme, senza più desideri. Resta il dubbio se queste riflessioni possano interessare ad altri e si percepisce la mancanza di una figura di riferimento che possa dare sostegno e direzione.4. Lo Stile di Porcellana
Fitzgerald, figura di confine tra la generazione prebellica e quella successiva, mostra una prospettiva ambivalente nella sua scrittura, sofisticata e quasi dissociata. La sua prosa è dinamica e ricca di metafore inattese, paragonabile alla velocità di un cavallo purosangue. Questa capacità di usare metafore incisive, condivisa con altri artisti del suo tempo, serve a rendere più viva la scrittura di tutti i giorni. Per Fitzgerald l’arte è un fine, non un mezzo. Inizialmente, la scrittura era un modo per compensare gli eccessi, ma col tempo è diventata un’esperienza così intensa da superare ogni altra cosa. La qualità della sua opera è sempre alta, anche quando tratta argomenti come lo snobismo, gli ideali superficiali e le aspirazioni giovanili, grazie alla sua dedizione e a uno stile ricercato. Già nel 1925, Fitzgerald e sua moglie Zelda incarnavano un’eleganza delicata, come la porcellana. La famiglia appare come gli ultimi dolci rimasti in un piatto scheggiato. Scrivere bene è come nuotare sott’acqua trattenendo il respiro. L’immagine del “piatto scheggiato” rappresenta una piccola imperfezione che non rovina la bellezza, ma la rende più preziosa. Chi legge attentamente Fitzgerald riesce ad apprezzare il suo ritmo e la sua struttura complessa, distinguendo la vera qualità dalla banalità. Un autore di talento sa mettere nelle parole qualcosa che anticipa il futuro. Se Fitzgerald sembra lontano, è perché guarda avanti.5. Anatomia di un Crollo Iridescente
Nel 1935, Francis Scott Fitzgerald, debole nel corpo e nello spirito, e con problemi di soldi, arriva a tentare il suicidio. La rivista «Esquire» gli propone un contratto per scrivere, e da questa offerta nasce “Il crollo”, una serie di scritti in tre parti che parlano della depressione e aiutano Fitzgerald a liberarsi dai suoi tormenti. Questi scritti sono come un esame profondo della sua mente in crisi, un modo per fare i conti con la sua vita e la sua arte. Fitzgerald, con “Il crollo”, non segue le regole della letteratura, ma crea un modo tutto suo per affrontare i propri demoni. Il suo stile è essenziale, quasi come una poesia, e passa dal raccontare la sua vita al criticare sé stesso, mostrando un grande coraggio nel parlare della sua pigrizia e svogliatezza. La sua sconfitta diventa quasi una forza, un modo per trovare una nuova forma di vittoria. Fitzgerald guarda anche all’Era del Jazz, tra il 1919 e il 1929, come a un tempo di feste continue e di divertimenti senza limiti. Descrive una società americana che pensa solo a spendere e a divertirsi in modo esagerato, dove l’interesse per il sesso diventa presto qualcosa di fastidioso. La fine di questo periodo, con la crisi economica del 1929, sembra lontana, come un ricordo sbiadito. Il legame con la moglie Zelda è il simbolo di quegli anni: un amore forte e pieno di litigi, fatto di grandi eccessi e di tradimenti, che peggiora la sua crisi. Fitzgerald pensa al suo successo arrivato troppo presto, che all’inizio lo aveva reso felice, portandolo a vivere emozioni estreme, ma che poi aveva perso il suo valore dopo scandali e delusioni. Nelle notti in cui non riesce a dormire, Fitzgerald si trova faccia a faccia con i suoi pensieri più bui, e si chiede che senso abbiano la vita e la morte. Si sente come un fantasma, fuori posto in un mondo che ammira solo chi ha successo, anche se per poco tempo. Gli anni successivi, quelli del New Deal, sembrano a Fitzgerald un periodo senza speranza. Fitzgerald si trasferisce a Hollywood, nel cuore del mondo del cinema, dove non si riconosce più nella persona che era stato. Scrive di un personaggio di nome Pat Hobby, che è l’opposto di sé stesso, e si allontana sempre di più dalla vita, come se sapesse già che la sua fine è vicina. Il suo percorso, sia come uomo che come scrittore, si chiude nel “Giardino di Allah”, un posto che rappresenta la dimenticanza e il cambiamento.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]