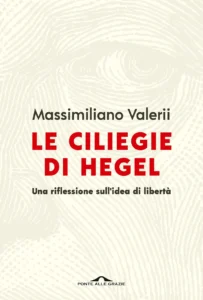1. La fine della storia e il mondo che cambia
Alexandre Kojève e la “Fine della Storia”
Alexandre Kojève, un filosofo che ha lavorato anche come funzionario statale, ha interpretato il pensiero di Hegel mettendo al centro il concetto di “desiderio di riconoscimento”. Secondo Kojève, la storia umana è guidata da questo desiderio e dalla lotta che ne deriva, e trova il suo compimento con la Rivoluzione francese e l’epoca di Napoleone. Questi eventi portano alla nascita di uno “Stato universale e omogeneo”, un sistema politico basato sui principi di libertà e uguaglianza per tutti. In questo Stato ideale, la lotta per il riconoscimento finisce perché a tutti viene garantita sicurezza e dignità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Kojève ha messo in pratica le sue idee lavorando nella diplomazia internazionale e contribuendo a importanti accordi economici come il GATT e la CEE, vedendo in questo impegno la realizzazione concreta della sua filosofia.Il Mondo Cambia: Globalizzazione e Nuovi Equilibri Economici
Gli ultimi trent’anni, iniziati con la caduta del muro di Berlino nel 1989, hanno visto un’accelerazione senza precedenti della globalizzazione. Durante questo periodo, l’economia mondiale è cresciuta in modo significativo: il PIL globale e il volume degli scambi commerciali sono aumentati notevolmente, e la povertà estrema è diminuita in maniera drastica. Molti accordi internazionali hanno favorito il libero scambio tra i paesi. Questo periodo è stato caratterizzato da un importante cambiamento negli equilibri economici globali: le economie emergenti, guidate dalla Cina, hanno registrato una crescita molto rapida, superando i paesi più ricchi in termini di PIL calcolato sulla base del potere d’acquisto. La Cina, in particolare, ha superato gli Stati Uniti già nel 2014. Anche altre nazioni come India, Indonesia e Messico hanno superato economie europee storicamente forti come Germania e Italia. Questo spostamento del centro di gravità economico mondiale sembrava confermare l’idea di una progressiva “universale omogeneizzazione” del mondo.Sfide Attuali: Nazionalismo e Disuguaglianze
Tuttavia, questo scenario di apparente omogeneizzazione e stabilità si trova oggi di fronte a nuove e significative sfide. Si assiste a un chiaro ritorno di tendenze nazionaliste in molte parti del mondo. Parallelamente, si stanno innalzando nuove barriere commerciali tra i paesi, mettendo in discussione i principi del libero scambio che hanno dominato gli ultimi decenni. Un altro fenomeno preoccupante è l’aumento della disuguaglianza economica all’interno dei singoli paesi, un trend che si osserva sia nelle nazioni ricche che in quelle emergenti. L’indice di Gini, uno strumento che misura la distribuzione della ricchezza, è aumentato in paesi chiave come la Cina e gli Stati Uniti a partire dal 1990. Questi sviluppi recenti sollevano seri interrogativi sulla tenuta e sulla stabilità della “fine della storia” come era stata teorizzata da Kojève, suggerendo che il percorso verso un ordine mondiale pienamente stabile e omogeneo è ancora lontano dall’essere completato.Ma la “fine della storia” di Kojève è davvero il metro di giudizio adeguato per analizzare le dinamiche economiche e politiche degli ultimi decenni?
Il capitolo lega in modo piuttosto diretto un concetto filosofico complesso, l’interpretazione hegeliana di Kojève, agli eventi economici e politici post-1989, fino alle sfide attuali. Questa connessione, pur stimolante, rischia di semplificare eccessivamente sia la teoria di Kojève sia le molteplici cause e manifestazioni dei fenomeni come la globalizzazione, il nazionalismo e la disuguaglianza. Ridurre la storia umana alla sola lotta per il riconoscimento e vedere il suo compimento in un ideale (e forse mai pienamente realizzato) “Stato universale e omogeneo” potrebbe non cogliere altre forze motrici storiche e sociali. Per approfondire questa critica e comprendere meglio i limiti di tale approccio, è consigliabile studiare più a fondo il pensiero di Hegel e Kojève, ma anche confrontarsi con altre filosofie della storia e con le analisi economiche e sociologiche che offrono interpretazioni alternative o complementari delle trasformazioni globali e delle loro contraddizioni interne.2. La Paura dell’Altro e il Ritorno dei Muri
La globalizzazione ha avvicinato i paesi e ha aiutato molte persone a uscire dalla povertà nel mondo. Però, ha anche aumentato le differenze economiche dentro ogni paese. In Italia, per esempio, i soldi guadagnati dagli operai sono diminuiti, mentre quelli dei capi sono cresciuti. Anche i giovani oggi guadagnano, spendono e possiedono meno di trent’anni fa, mentre le persone più anziane hanno visto aumentare la loro ricchezza. Queste maggiori differenze economiche fanno giudicare male la globalizzazione in molti paesi, come in Italia e Grecia. Questo porta a volere misure che proteggano l’economia nazionale, come mettere tasse sui prodotti che arrivano da fuori. Nasce un nazionalismo diverso dal passato: non vuole conquistare altri paesi, ma chiudersi dentro i propri confini. La “guerra dei dazi” tra paesi e il fatto che si scambino meno merci nel mondo mostrano che la globalizzazione sta rallentando.Disorientamento Sociale e Crisi d’Identità
I governi democratici che rispettano le libertà faticano a rispondere ai bisogni delle persone. Questo fa spazio all’idea di governi “meno liberi”. La globalizzazione ha causato la chiusura di industrie e la perdita di posti di lavoro in Europa e America, cambiando profondamente le comunità. Aprire i confini e l’arrivo di culture diverse crea confusione. Sembra che l’identità di sempre e il sentirsi parte di un gruppo siano minacciati. Molti sentono di non essere più considerati importanti dalla società. Vedono la globalizzazione come qualcosa che mette in pericolo chi sono.La Politica Sfrutta la Paura
Questo forte impatto sulle persone, che non è stato capito abbastanza, spinge la politica a reazioni nazionaliste. Si dice che la propria nazione debba venire prima di tutto (“America first!”, “Prima gli italiani!”). La crescita di paesi come la Cina fa temere che l’Occidente perda importanza nell’economia e nella politica mondiale. Questo alimenta la paura di non avere più il benessere di prima. Il vero scontro oggi è tra l’idea che conti solo la nazione e l’idea che siamo tutti collegati nel mondo. La globalizzazione e un nazionalismo che sembrava scomparso lottano per dire alle persone chi sono, da sole e insieme agli altri. I leader politici usano l’insoddisfazione e la paura per avere più voti. Promuovono l’idea di proteggere l’economia nazionale e sono contro le diverse culture che vivono insieme. Si cercano colpevoli tra i gruppi di persone meno potenti e tornano idee razziste. Queste reazioni non sono solo un sentimento, ma nascono dal forte desiderio di sentirsi riconosciuti e importanti.L’Impatto della Pandemia
La pandemia di Covid-19 ha fatto sentire ancora di più che stiamo vivendo un periodo nuovo e difficile. Ha mostrato quanto siamo tutti collegati nel mondo. Ma ha anche reso più forti le voglie di chiudersi in sé stessi. L’epidemia è come un esempio: crea separazioni tra chi è “malato” e chi è “sano”. Queste separazioni possono diventare divisioni politiche. Stare lontani dagli altri per non ammalarsi può creare una diffidenza verso chi è diverso che dura nel tempo. Le malattie gravi del passato mostrano come le crisi sanitarie possano cambiare la società. A volte, purtroppo, portano a cercare qualcuno a cui dare la colpa ingiustamente.Il Rischio di Chiusura
Il pericolo è che le società si chiudano sempre di più. Questo confermerebbe le tendenze a favorire solo la propria nazione e a proteggere l’economia interna, che si vedevano già prima che arrivasse la pandemia.Se la globalizzazione ha creato problemi, siamo sicuri che la “paura dell’altro” sia la causa principale del ritorno dei muri, o è solo un sintomo di dinamiche più complesse?
Il capitolo presenta un legame forte tra gli effetti negativi della globalizzazione (disuguaglianza, perdita di lavoro, crisi d’identità) e la reazione nazionalista basata sulla paura. Tuttavia, questa prospettiva potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita su quanto la “paura dell’altro” sia una causa primaria o piuttosto una conseguenza strumentalizzata di crisi economiche e politiche preesistenti o gestite male. Per esplorare queste sfumature, è utile considerare contributi dalla Sociologia politica, dalla Psicologia sociale e dall’Economia critica. Autori come Zygmunt Bauman hanno analizzato la “società liquida” e la paura, mentre Dani Rodrik ha discusso i limiti della globalizzazione e le alternative politiche. Approfondire le dinamiche del populismo con autori come Cas Mudde può aiutare a capire meglio come la paura e l’insoddisfazione vengano mobilitate politicamente.3. La Scossa Hegeliana a Parigi
In Francia, la filosofia di Hegel è poco conosciuta e vista con pregiudizio, spesso considerata l’ideologia di uno stato conservatore. Jean Wahl inizia una riscoperta con un’opera sulla “coscienza infelice”, evidenziando un aspetto più umano di Hegel. Alexandre Koyré prosegue questa nuova lettura, concentrandosi sugli scritti giovanili e il lato esistenziale del pensiero hegeliano, pur mettendo in guardia contro un’eccessiva umanizzazione. Questo contesto di riscoperta parziale e di pregiudizi diffusi preparava il terreno per un’interpretazione più profonda e influente. La visione dominante era lontana dalla complessità che avrebbe poi rivelato un’analisi più approfondita.L’arrivo di Kojève e il contesto parigino
Alexandre Kojève lascia la Russia nel gennaio 1920, poiché la Rivoluzione impedisce ai borghesi di proseguire gli studi universitari. Il suo viaggio attraverso l’Europa è segnato da difficoltà, inclusi arresti e malattia. Studia filosofia, lingue orientali e scienze in Germania e Italia, vivendo un periodo intenso a Berlino. A Parigi, dopo aver perso i beni a causa della crisi del ’29, è costretto a cambiare vita e si inserisce nel panorama culturale. È in questo periodo che segue i corsi di Alexandre Koyré, inserendosi nel dibattito sulla filosofia hegeliana che Koyré e Wahl avevano iniziato a riaccendere. La sua preparazione accademica e le sue esperienze personali lo rendevano particolarmente adatto a proporre una nuova lettura del pensiero hegeliano.Il Seminario e la Nuova Corrente Hegeliana
Con il suo seminario tenuto dal 1933 al 1939, Kojève diventa rapidamente la figura centrale di questa rinascita hegeliana a Parigi. Le sue lezioni non erano semplici spiegazioni, ma un’interpretazione potente e originale che attirava le menti più brillanti dell’epoca. Questo seminario attrae importanti intellettuali francesi, tra cui Raymond Queneau, Georges Bataille, Henry Corbin, Éric Weil e Jacques Lacan. Anche figure come Jean-Paul Sartre vengono profondamente influenzate dalle idee discusse. Attraverso queste discussioni, Kojève rende Hegel un pensatore fondamentale per analizzare la condizione umana contemporanea. Il suo impatto è tale da dare vita a una vera e propria nuova corrente hegeliana che segna profondamente il pensiero francese del XX secolo.Se i dati mostrano che i crimini sono diminuiti, perché il capitolo accetta senza approfondire che si diffonda un senso crescente di insicurezza personale?
Il capitolo evidenzia correttamente una contraddizione significativa: la percezione di insicurezza aumenta nonostante un calo oggettivo della criminalità. Tuttavia, non esplora a fondo le ragioni di questo divario tra realtà e percezione. Per comprendere meglio questo fenomeno, è essenziale indagare i meccanismi della percezione del rischio, il ruolo dei media nella costruzione del discorso pubblico sulla sicurezza, e le teorie sociologiche che legano l’insicurezza non solo al crimine ma anche alla precarietà economica, alla perdita di punti di riferimento sociali e all’incertezza sul futuro. Approfondire autori che hanno trattato temi come la “società del rischio” o la “modernità liquida”, come Ulrich Beck o Zygmunt Bauman, può offrire prospettive cruciali per colmare questa lacuna argomentativa.9. Il desiderio come motore del futuro
La fine della storia non è vista come una scomparsa dell’umanità, ma come un obiettivo morale da raggiungere. Questo obiettivo consiste nel superare la violenza, l’ingiustizia e la sofferenza, ponendo fine a quella che viene chiamata “cattiva storia”. L’umanità aspira profondamente a una vita felice e agisce attivamente per realizzare un mondo in cui libertà, dignità e felicità siano accessibili a tutti. Non si tratta semplicemente di attendere un cambiamento esterno, ma di impegnarsi concretamente per costruire un futuro migliore.La condizione umana e il desiderio
La condizione umana è caratterizzata da un paradosso fondamentale: l’uomo non si definisce per ciò che è nel presente, ma per ciò che ancora non è, proiettandosi costantemente verso il futuro. Questa capacità di negare la realtà attuale, di pensare a ciò che non esiste, è una caratteristica distintiva dell’essere umano. Il desiderio nasce proprio da questa “presenza di un’assenza”, rappresentando la forza interiore che spinge l’individuo e l’umanità intera a muoversi in avanti.Il desiderio come spinta verso la libertà e l’altro
Il desiderio umano va oltre il semplice soddisfacimento dei bisogni fisici; è un superamento della dimensione naturale. È un vuoto interiore che cerca di essere colmato, spesso attraverso il desiderio rivolto verso un’altra persona. Questa dinamica porta alla ricerca di riconoscimento reciproco e costituisce la base per la costruzione di legami sociali e di una comunità. La capacità di desiderare, di immaginare ciò che non è ancora reale, permette all’uomo di superare i limiti della realtà presente e dimostra la sua libertà intrinseca. Nonostante la possibilità che i sogni possano non realizzarsi o portare delusioni, l’essere umano vive in questa tensione creativa tra la realtà attuale e il potenziale futuro, trovando significato e realizzazione nel rapporto con l’altro e nella continua ricerca di nuovi inizi. Questa libertà è profondamente legata anche alla capacità di confrontarsi con l’idea della morte, affermando la vita stessa come negazione di essa.Se il desiderio è la forza che spinge l’umanità verso un futuro migliore, come si spiega la persistenza della ‘cattiva storia’?
Il capitolo pone il desiderio come motore fondamentale del progresso umano e del superamento della “cattiva storia”. Tuttavia, questa prospettiva rischia di trascurare le complesse dinamiche sociali, economiche e politiche che spesso ostacolano la realizzazione di un futuro libero da violenza e ingiustizia, nonostante il desiderio diffuso di tale cambiamento. Per comprendere meglio questa apparente contraddizione, sarebbe utile approfondire le analisi delle strutture di potere e dei conflitti sociali, argomenti trattati da discipline come la sociologia e la scienza politica. Autori come Marx o Foucault, pur da prospettive diverse, offrono strumenti critici per analizzare le forze che modellano la storia al di là delle sole spinte interiori.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]