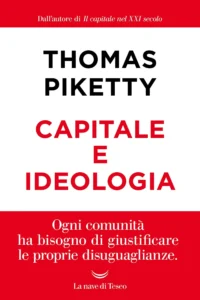1. Disuguaglianza, Capitale e Reddito nel Lungo Periodo
Il reddito nazionale misura i guadagni dei residenti di un paese in un anno, mentre il prodotto interno lordo (PIL) misura i beni e servizi prodotti nel territorio in un anno. Il reddito nazionale si ottiene sottraendo dal PIL l’usura del capitale e aggiungendo i redditi netti dall’estero. A livello mondiale, il reddito e il prodotto coincidono.Il capitale
Il capitale si riferisce agli attivi non umani che possono essere posseduti e scambiati, escludendo il “capitale umano”, come l’istruzione e le competenze professionali. Il patrimonio, sinonimo di capitale, include tutto ciò che può essere scambiato sul mercato, sia privato che pubblico, come immobili, macchinari, infrastrutture, brevetti e altri beni immateriali. Il rapporto capitale/reddito (β) è un indicatore chiave, che si ottiene dividendo lo stock di capitale per il flusso annuo di reddito. La prima legge fondamentale del capitalismo (α = r × β) collega il rapporto capitale/reddito alla quota di reddito da capitale (α) e al tasso di rendimento del capitale (r). Questa legge è fondamentale per comprendere le dinamiche del sistema capitalista.Distribuzione del prodotto e disuguaglianza
La distribuzione mondiale del prodotto è stata a lungo dominata da Europa e America, ma questa tendenza sta cambiando, con una convergenza tra paesi ricchi e poveri. La convergenza tra paesi è guidata principalmente dalla diffusione delle conoscenze, non dalla mobilità del capitale. La disuguaglianza del reddito è più marcata di quella del prodotto, poiché i paesi ricchi tendono a possedere una parte del capitale dei paesi poveri. La disuguaglianza dei patrimoni è sempre stata più elevata di quella dei redditi da lavoro. Nel XIX secolo, la concentrazione patrimoniale era estrema, con il decile superiore, ovvero il 10% più ricco della popolazione, che possedeva la maggior parte della ricchezza. Nel XX secolo, le disuguaglianze patrimoniali si sono ridotte, ma oggi sembrano destinate a risalire.Conflitti e disuguaglianze
Il conflitto tra capitale e lavoro è una costante nella storia, con episodi di violenza che emergono quando la distribuzione della ricchezza è percepita come ingiusta. La divisione del reddito nazionale tra lavoro e capitale è un problema centrale, ma è anche importante considerare le disuguaglianze all’interno di questi due gruppi, ovvero tra i lavoratori e tra i detentori di capitale. La concentrazione della proprietà del capitale è una delle cause principali dei conflitti, poiché i patrimoni sono distribuiti in modo molto più diseguale rispetto ai salari.Il ruolo dell’eredità
L’eredità gioca un ruolo cruciale nella disuguaglianza patrimoniale. Nelle società con bassa crescita e alto rendimento da capitale, i patrimoni ereditati crescono più rapidamente dell’economia, portando a una forte concentrazione della ricchezza. Le imposte sul capitale e i dissesti economici del XX secolo hanno ridotto temporaneamente questa disuguaglianza, ma la tendenza sembra essere quella di un ritorno a una società in cui l’eredità gioca un ruolo sempre più importante. La disuguaglianza di fondo r > g, ovvero il tasso di rendimento del capitale superiore al tasso di crescita economica, è una delle cause principali dell’iperconcentrazione patrimoniale. Questa disuguaglianza è una realtà storica, non una necessità logica, e dipende da fattori economici, sociali e politici. La disuguaglianza r > g è una forza potente che, se non controllata, può portare a una concentrazione patrimoniale estrema, con il rischio di minare i principi di giustizia e democrazia.Se la disuguaglianza r > g è una realtà storica, influenzata da fattori economici, sociali e politici, come possiamo affermare con certezza che essa sia la causa principale dell’iperconcentrazione patrimoniale, e non piuttosto una sua conseguenza o un effetto collaterale di dinamiche più complesse, come il potere politico o l’influenza culturale?
Il capitolo presenta la disuguaglianza r > g come una forza potente e quasi ineluttabile, che porta inevitabilmente a una concentrazione estrema della ricchezza. Tuttavia, questa visione deterministica rischia di semplificare eccessivamente la realtà. Se è vero che il rendimento del capitale ha storicamente superato la crescita economica, è altrettanto vero che le dinamiche di accumulazione e distribuzione della ricchezza sono influenzate da una molteplicità di fattori, tra cui le istituzioni politiche, le norme sociali, le innovazioni tecnologiche e le scelte individuali. Per comprendere appieno le cause dell’iperconcentrazione patrimoniale, è necessario approfondire discipline come la sociologia, la scienza politica e la storia economica, e considerare il ruolo di autori come Max Weber, per l’analisi del rapporto tra capitalismo e potere, o Karl Polanyi, per la critica dell’economia di mercato autoregolata.2. Disuguaglianza Globale e Rendimenti da Capitale
La disuguaglianza non è più considerata solo all’interno dei confini nazionali, ma assume una prospettiva globale, amplificata dai meccanismi della finanza internazionale che favoriscono un’ulteriore concentrazione del capitale. Un fattore chiave è la disuguaglianza dei rendimenti da capitale: i patrimoni più consistenti ottengono rendimenti mediamente più alti, grazie all’accesso a intermediari finanziari più efficienti e alla capacità di assumere maggiori rischi. Questo meccanismo alimenta un circolo vizioso in cui i patrimoni più elevati crescono a un ritmo superiore rispetto alla media, innescando un processo che si autoalimenta e può condurre a una concentrazione estrema della ricchezza. Sebbene la crescita economica possa mitigare questo fenomeno, nel lungo termine, la disuguaglianza dei rendimenti da capitale rappresenta una minaccia più significativa delle disparità tra nazioni.Classifiche di ricchezza e concentrazione patrimoniale
Le classifiche di ricchezza, come quelle stilate da Forbes, evidenziano la crescita esponenziale del numero e del patrimonio dei miliardari a livello globale. Tuttavia, per comprendere appieno le dinamiche in atto, è necessario analizzare la crescita dei patrimoni di una percentuale fissa della popolazione mondiale. Emerge chiaramente che i patrimoni più elevati crescono a un ritmo molto più sostenuto rispetto alla media, e questa divergenza si è accentuata negli ultimi decenni. I rapporti sulla ricchezza, pubblicati da istituti finanziari, confermano una forte concentrazione patrimoniale a livello globale, paragonabile a quella dell’Europa di inizio Novecento. Lo 0,1% più ricco possiede circa il 20% della ricchezza totale, mentre l’1% ne detiene circa il 50%. Sebbene questa concentrazione sia in parte dovuta alle disuguaglianze internazionali, la divergenza è particolarmente marcata al vertice della gerarchia patrimoniale.Patrimoni ereditari, imprenditoriali e rendimento del capitale
Le classifiche di Forbes rivelano che, una volta superata una certa soglia, sia le ricchezze ereditate che quelle imprenditoriali tendono a crescere a ritmi elevati. Il denaro, infatti, tende a generare altro denaro, e la maggior parte del rendimento può essere reinvestita, alimentando ulteriormente la crescita del capitale. Tuttavia, le classifiche tendono a sottostimare le ricchezze ereditate, in quanto i giornalisti faticano a tracciare patrimoni diversificati e complessi. Si osserva inoltre una certa prevenzione ideologica a favore degli imprenditori, ma è fondamentale comprendere che il patrimonio non è esclusivamente una questione di merito. Il rendimento da capitale, infatti, è il risultato di una combinazione di fattori eterogenei, tra cui il lavoro imprenditoriale, la fortuna e, in alcuni casi, anche attività illecite.Rendimenti universitari, fondi sovrani e dinamiche globali
L’analisi del rendimento delle dotazioni universitarie americane evidenzia una correlazione diretta tra il volume della dotazione e i rendimenti ottenuti. Le università più ricche, grazie alle economie di scala nella gestione dei portafogli, riescono a ottenere rendimenti più elevati, avvalendosi di strategie di investimento più sofisticate. L’inflazione, pur non riducendo il rendimento medio del capitale, lo ridistribuisce in modo disomogeneo, favorendo i patrimoni più consistenti. Anche i fondi sovrani, in particolare quelli dei paesi produttori di petrolio, stanno crescendo rapidamente, ma le loro strategie di investimento e i loro rendimenti sono spesso avvolti nell’opacità. La dinamica della distribuzione mondiale del capitale è il risultato di un complesso intreccio di fattori economici, politici e militari.Divergenza oligarchica e posizione patrimoniale dei paesi ricchi
Più che il timore di una conquista del mondo da parte della Cina o dei fondi petroliferi, la minaccia più concreta è rappresentata dalla divergenza oligarchica, un processo in cui i paesi ricchi rischiano di diventare proprietà dei loro stessi miliardari. La paura di una conquista cinese appare infondata, in quanto i paesi ricchi sono molto più ricchi di quanto si pensi. La posizione patrimoniale dei paesi ricchi rispetto al resto del mondo è, in realtà, positiva, ma viene dissimulata dall’occultamento di attività finanziarie nei paradisi fiscali. La disuguaglianza dei rendimenti da capitale, combinata con la disuguaglianza r > g, rischia di innescare una spirale di disuguaglianza fuori controllo a livello globale.Se la disuguaglianza dei rendimenti da capitale è una minaccia così significativa, perché il capitolo si concentra principalmente sulle classifiche di ricchezza e sui patrimoni individuali, piuttosto che analizzare le strutture economiche e le politiche fiscali che permettono tale concentrazione di ricchezza?
Il capitolo, pur evidenziando la crescente disuguaglianza globale e il ruolo chiave dei rendimenti da capitale, si sofferma prevalentemente sulla manifestazione del problema, ovvero la concentrazione della ricchezza in un numero ristretto di individui, senza però analizzare a fondo le cause strutturali e sistemiche che la generano. Per comprendere appieno il fenomeno, sarebbe opportuno approfondire le discipline dell’economia politica, della sociologia della disuguaglianza e della finanza pubblica. In particolare, sarebbe utile analizzare le teorie sulla tassazione progressiva, la regolamentazione dei mercati finanziari e il ruolo delle istituzioni internazionali. Autori come Joseph Stiglitz, Branko Milanovic e Gabriel Zucman offrono spunti interessanti in tal senso. Inoltre, un’analisi comparata delle politiche fiscali adottate in diversi paesi potrebbe fornire un quadro più completo delle possibili soluzioni per contrastare la divergenza oligarchica.Capitolo 3: Tassare il Capitale per Regolare il Capitalismo
Per controllare il capitalismo globale del XXI secolo, è necessario un nuovo strumento: un’imposta mondiale progressiva sul capitale, accompagnata da trasparenza finanziaria internazionale. Questa imposta non sostituirebbe le risorse fiscali esistenti, ma servirebbe a regolare il capitalismo, prevenendo la crescita illimitata delle disuguaglianze e gestendo le crisi finanziarie. L’imposta ideale sarebbe annuale e progressiva, applicata al valore netto degli attivi di ogni individuo, con tassi che aumentano in base alla ricchezza.Un’utopia utile
L’imposta sul capitale, seppur difficile da realizzare a breve termine, è un’utopia utile. In mancanza di essa, potrebbero prevalere politiche protezionistiche e controlli sui capitali, creando tensioni tra i paesi. L’imposta sul capitale, invece, protegge l’apertura economica e la globalizzazione, distribuendo i benefici in modo equo. L’implementazione può avvenire gradualmente, iniziando a livello regionale e sfruttando i sistemi di comunicazione automatica delle informazioni bancarie.Trasparenza finanziaria
La trasparenza finanziaria è fondamentale. Un’imposta, anche minima, aiuterebbe a raccogliere informazioni affidabili sulla distribuzione dei patrimoni, consentendo un dibattito democratico sulle sfide globali. Inoltre, migliorerebbe la regolamentazione finanziaria, permettendo alle organizzazioni internazionali di conoscere la distribuzione degli attivi, soprattutto quelli nei paradisi fiscali. L’imposta sul capitale funzionerebbe come un catasto finanziario mondiale, rafforzando le definizioni e le regole di valorizzazione degli attivi.Banche centrali e imposta sul capitale
Le banche centrali, pur avendo il potere di creare liquidità, non creano ricchezza, ma la redistribuiscono. La loro funzione principale è garantire la stabilità del sistema finanziario, ma non possono guidare l’economia. L’imposta sul capitale, invece, è uno strumento più efficace per ridurre il debito pubblico e le disuguaglianze, e può essere applicata in modo progressivo. L’inflazione, sebbene possa ridurre il valore reale del debito, è uno strumento meno preciso e può avere effetti collaterali indesiderati. L’imposta sul capitale si rivela uno strumento essenziale per regolare il capitalismo, promuovere la trasparenza finanziaria e garantire una distribuzione più equa della ricchezza.Se le banche centrali, pur avendo il potere di creare liquidità, non creano ricchezza ma la redistribuiscono, come può un’imposta sul capitale, che di fatto è anch’essa una forma di redistribuzione, essere uno strumento più efficace per ridurre il debito pubblico e le disuguaglianze?
Il capitolo presenta l’imposta sul capitale come una panacea per i mali del capitalismo, ma non spiega in modo convincente come questa imposta possa essere più efficace di altri strumenti, come la politica monetaria delle banche centrali, nel ridurre il debito pubblico e le disuguaglianze. Inoltre, l’affermazione che le banche centrali non creano ricchezza ma la redistribuiscono è una semplificazione eccessiva che non tiene conto del ruolo della politica monetaria nella stimolazione della crescita economica. Per approfondire l’argomento, sarebbe utile esplorare le teorie economiche di keynesiani e monetaristi, e analizzare il dibattito tra gli economisti sulla relazione tra debito pubblico, disuguaglianza e crescita economica. Si potrebbe inoltre approfondire il pensiero di economisti come Joseph Stiglitz o Paul Krugman, per comprendere meglio le diverse prospettive sul ruolo delle banche centrali e sulla gestione del debito pubblico.4. Trasformazioni del Capitale e Disuguaglianze Globali
Il capitale assume forme diverse nel corso del tempo, pur mantenendo un ruolo centrale nelle dinamiche economiche. In Europa, il rapporto tra capitale e reddito nazionale è rimasto sostanzialmente stabile per secoli, subendo un crollo nel XX secolo a causa di guerre mondiali e crisi economiche, per poi ritornare ai livelli prebellici. Questo rapporto, che esprime il valore del capitale di una nazione rispetto al suo reddito annuale, risulta più elevato in Europa rispetto all’America, riflettendo differenze storiche e demografiche.La formula β = s/g
Il rapporto capitale/reddito (β) è strettamente legato al tasso di risparmio (s) e al tasso di crescita (g) di un paese, come espresso dalla formula β = s/g. Un paese con un alto tasso di risparmio e una bassa crescita tende ad accumulare più capitale nel tempo. Questo aiuta a comprendere perché l’Europa, caratterizzata da una crescita demografica più contenuta, presenti un rapporto capitale/reddito più elevato rispetto all’America. Il processo di accumulazione del capitale è un fenomeno di lungo periodo, e le variazioni di prezzo degli attivi, pur potendo influenzare il rapporto nel breve termine, non ne alterano la tendenza di fondo, confermando la validità della legge β = s/g nel lungo periodo.Il ritorno del capitale privato
Dopo il 1970, nei paesi ricchi si è osservato un ritorno del capitale privato. Questo fenomeno è dovuto a diversi fattori, tra cui il rallentamento della crescita economica, il mantenimento di un elevato tasso di risparmio, la privatizzazione di beni pubblici e il riallineamento dei prezzi degli attivi. Il debito pubblico, che nel XIX secolo ha rappresentato uno strumento di accumulazione del capitale privato, ha assunto un ruolo diverso nel XX secolo, subendo gli effetti erosivi dell’inflazione. Negli Stati Uniti, il capitale ha mostrato un andamento più stabile, con un rapporto capitale/reddito inferiore rispetto all’Europa, riflettendo una diversa struttura sociale e un minore peso del passato.Schiavitù e capitale
La schiavitù ha avuto un ruolo significativo nella storia del capitale americano, in particolare negli Stati del Sud, dove il valore degli schiavi era molto elevato. Nelle società schiaviste, il valore del capitale umano può superare quello delle altre forme di capitale. A livello globale, il rapporto capitale/reddito potrebbe ritornare ai livelli della Belle Époque, spinto dal rallentamento della crescita economica. Il valore dei terreni vergini, sebbene difficile da stimare con precisione, sembra avere un impatto limitato sul rapporto capitale/reddito, ma potrebbe assumere una maggiore rilevanza in futuro.Se il rapporto capitale/reddito è così strettamente legato al tasso di risparmio e al tasso di crescita, come si concilia questa visione meccanicistica con l’impatto, potenzialmente dirompente, di fattori sociali, politici e tecnologici, come le disuguaglianze crescenti, le tensioni geopolitiche o l’ascesa dell’intelligenza artificiale, che non sembrano essere presi in considerazione nella formula β = s/g?
Il capitolo, pur offrendo una panoramica interessante sulle trasformazioni del capitale, sembra ridurre la complessità delle dinamiche economiche a una formula, β = s/g, che, per quanto utile come strumento di analisi di lungo periodo, rischia di semplificare eccessivamente la realtà. Viene da chiedersi: non si rischia di trascurare l’impatto di eventi imprevisti o di cambiamenti strutturali profondi che potrebbero alterare radicalmente il rapporto tra capitale e reddito? Per colmare questa lacuna, sarebbe opportuno approfondire discipline come la sociologia economica, la geopolitica e la storia delle tecnologie, per comprendere meglio come questi fattori interagiscono con le dinamiche del capitale. In particolare, sarebbe utile approfondire autori come Joseph Stiglitz per le disuguaglianze, o Shoshana Zuboff per l’impatto delle nuove tecnologie.5. La Dinamica della Disuguaglianza tra Capitale e Lavoro
La formula α = r × β definisce la quota di reddito da capitale (α) come il prodotto tra il rendimento del capitale (r) e il rapporto capitale/reddito (β). Questa relazione è essenziale per analizzare la ripartizione del reddito nazionale tra capitale e lavoro. Il rapporto capitale/reddito è a sua volta influenzato da variabili come il tasso di risparmio e la crescita economica, che cambiano nel tempo e variano a seconda delle nazioni.Andamento Storico della Quota di Capitale
In nazioni come il Regno Unito e la Francia, la quota di capitale ha storicamente disegnato una curva a U. Era elevata nel XVIII e XIX secolo, si è ridotta a metà del XX secolo, per poi crescere nuovamente tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI. Il rendimento del capitale tende a variare in modo inversamente proporzionale alla quantità di capitale accumulato, anche se questa correlazione non è sempre lineare. Il rendimento medio del capitale, che si ottiene sommando tutti i redditi da capitale e dividendo il totale per il capitale complessivo, cela differenze significative sia tra individui che tra diverse tipologie di investimento.Produttività Marginale ed Elasticità di Sostituzione
La produttività marginale del capitale indica il valore aggiunto generato da un’unità addizionale di capitale e tende a diminuire all’aumentare dello stock di capitale. L’elasticità di sostituzione tra capitale e lavoro esprime la facilità con cui è possibile sostituire lavoro con capitale o viceversa. Un’elasticità superiore a uno indica che la quota di capitale nel reddito nazionale cresce all’aumentare del rapporto capitale/reddito. Le economie moderne mostrano una notevole capacità di sostituire lavoro con capitale, a differenza delle economie agricole tradizionali.Limiti delle Analisi e Disuguaglianze
Le analisi sono complicate dalla difficoltà di stimare i redditi dei lavoratori autonomi, dove reddito da lavoro e da capitale si confondono. Nonostante questo limite, emerge chiaramente che la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi da capitale è sempre superiore a quella dei redditi da lavoro. Il rendimento del capitale, pur mantenendosi relativamente stabile nel lungo periodo intorno al 4-5%, può fluttuare in base a periodi e condizioni economiche specifiche.Ruolo della Crescita e della Tecnologia
Contrariamente alla previsione di Marx di un calo del saggio di profitto dovuto all’accumulazione di capitale, la crescita della produttività e della popolazione ha finora scongiurato tale scenario, senza però risolvere il problema delle disuguaglianze. Un rallentamento della crescita economica e demografica potrebbe favorire un ritorno della preponderanza del capitale, aumentando la sua quota nel reddito nazionale. La crescita del capitale umano, pur significativa, non ha diminuito l’importanza del capitale fisico e finanziario. Il modello di Cobb-Douglas, che assume una ripartizione stabile tra capitale e lavoro, non riesce a spiegare le variazioni osservate nel corso della storia. La tecnologia, pur avendo storicamente favorito il lavoro umano, non ha diminuito l’importanza del capitale. Pertanto, non si può contare sulla tecnologia per instaurare un ordine sociale più equo. La storia della ripartizione tra capitale e lavoro è intricata e vede l’interazione di dinamiche di breve e medio termine con tendenze di lungo periodo.Se la tecnologia, pur avendo storicamente favorito il lavoro umano, non ha diminuito l’importanza del capitale, e non si può quindi contare su di essa per instaurare un ordine sociale più equo, su quali leve, concretamente, si potrebbe agire per mitigare le disuguaglianze?
Il capitolo, pur delineando con precisione la dinamica della disuguaglianza tra capitale e lavoro e le sue implicazioni storiche ed economiche, si conclude con una nota di pessimismo riguardo al ruolo della tecnologia come equalizzatore sociale, senza però offrire alternative concrete. Affermare che “non si può contare sulla tecnologia per instaurare un ordine sociale più equo” lascia il lettore con un senso di impotenza e sollecita una domanda cruciale: quali sono, allora, gli strumenti per affrontare e mitigare le disuguaglianze? Per approfondire la questione, sarebbe opportuno esplorare discipline come la sociologia economica, la politica economica e la filosofia politica, che si interrogano proprio su come le società possano organizzarsi per promuovere una maggiore equità. Autori come John Rawls, Amartya Sen e Anthony Atkinson hanno offerto contributi significativi in questo campo, proponendo modelli teorici e soluzioni pratiche per ridurre le disuguaglianze. Inoltre, un’analisi delle politiche di welfare e redistribuzione adottate in diversi paesi potrebbe fornire spunti interessanti su come intervenire concretamente per bilanciare la ripartizione del reddito tra capitale e lavoro.6. Disuguaglianza, Competenze e Istituzioni
La disuguaglianza dei redditi da lavoro nasce da un’interazione complessa tra competenze individuali, progresso tecnologico, istituzioni e norme sociali. Secondo la teoria economica prevalente, i salari riflettono la produttività di un individuo, influenzata dalle sue qualifiche e dalla domanda di mercato per quelle specifiche competenze. In questo contesto, il divario salariale si amplierebbe quando l’offerta di competenze non riesce a tenere il passo con le esigenze dettate dal progresso tecnologico. L’istruzione assume quindi un ruolo fondamentale: un sistema educativo che non si adatta alle nuove necessità tecnologiche può contribuire a un aumento delle disuguaglianze salariali.Il ruolo delle istituzioni e delle norme sociali
Questa teoria, tuttavia, non è sufficiente a spiegare l’enorme crescita dei compensi dei cosiddetti “super-manager” e l’aumento delle disuguaglianze salariali osservato in alcuni paesi, in particolare negli Stati Uniti. L’incremento dei redditi più alti non è distribuito uniformemente tra tutti i lavoratori qualificati, ma si concentra in una piccolissima percentuale di individui. Inoltre, questo fenomeno si manifesta in alcuni paesi e non in altri, suggerendo che le istituzioni e le norme sociali giochino un ruolo determinante. Il mercato del lavoro non è un’entità astratta, che opera secondo leggi immutabili, ma piuttosto una costruzione sociale, con regole e compromessi specifici che possono variare nel tempo e nello spazio.Il mercato del lavoro come costruzione sociale
Il salario minimo, ad esempio, ha un impatto significativo sulla disuguaglianza salariale: un salario minimo più alto tende a ridurre il divario retributivo. Le norme sociali e le percezioni di giustizia influenzano le regole del mercato del lavoro, e queste variano da paese a paese. La difficoltà di misurare con precisione la produttività di ogni lavoratore porta a sistemi di retribuzione basati su griglie salariali e contratti stabili. Questi ultimi sono importanti, sia per la condivisione dei rischi tra impresa e lavoratore, sia per incentivare gli investimenti in formazione specifica da parte dei lavoratori.Il caso dei super-manager
L’aumento dei compensi dei super-manager negli Stati Uniti è legato a una maggiore tolleranza sociale verso i compensi elevati, mentre in Europa e in Giappone le norme sociali sono diverse e tendono a porre un freno alle retribuzioni più alte. Va inoltre considerato che le retribuzioni dei dirigenti sono spesso fissate da altri dirigenti, e non sempre riflettono la produttività individuale. La tendenza a premiare la fortuna, piuttosto che la performance, è un esempio di come le norme sociali influenzino le retribuzioni. Le politiche fiscali, in particolare il livello di tassazione sui redditi più alti, possono agire come freno o incentivo per i compensi più elevati. La disuguaglianza dei redditi da lavoro è il risultato di una complessa interazione tra competenze, tecnologia, istituzioni e norme sociali.Se il mercato del lavoro è una “costruzione sociale” influenzata da norme e percezioni di giustizia, come possiamo giustificare l’enorme divario retributivo tra i “super-manager” e il lavoratore medio, soprattutto considerando che la produttività individuale è difficile da misurare e che le retribuzioni dei dirigenti sono spesso fissate da altri dirigenti?
Il capitolo riconosce l’influenza delle norme sociali e delle istituzioni sulla disuguaglianza salariale, evidenziando il caso dei “super-manager” come un’anomalia rispetto alla teoria economica classica. Tuttavia, non approfondisce a sufficienza i meccanismi specifici che permettono a queste norme di perpetuare e amplificare tali disuguaglianze. Per comprendere meglio questo fenomeno, sarebbe utile approfondire discipline come la sociologia delle organizzazioni, la psicologia sociale e l’economia comportamentale. Autori come Pierre Bourdieu, con il suo concetto di “capitale sociale”, o Daniel Kahneman, con i suoi studi sui bias cognitivi, potrebbero offrire spunti interessanti per analizzare come le dinamiche di potere, le reti relazionali e i processi decisionali influenzino la formazione delle retribuzioni ai vertici aziendali. Inoltre, un’analisi più approfondita delle teorie sulla governance aziendale e sul ruolo degli stakeholder, oltre al ruolo dei consigli di amministrazione, potrebbe aiutare a capire come si formano e si legittimano le decisioni sulle retribuzioni dei dirigenti.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]