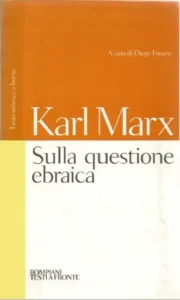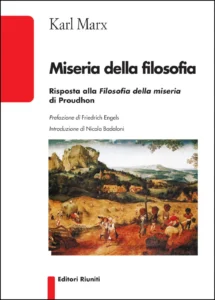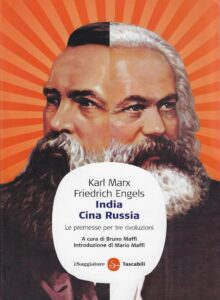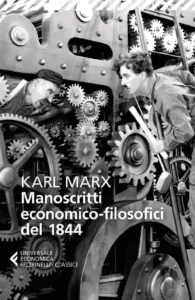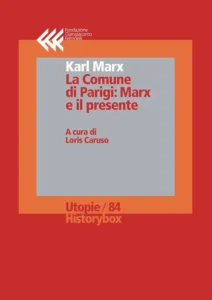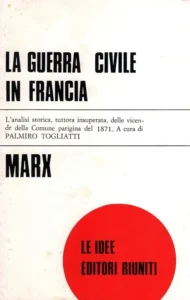1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il Capitale” di Karl Marx è un viaggio incredibile dentro il funzionamento del capitalismo. Inizia spiegando cos’è una ‘merce’, non solo utile ma carica di ‘valore’ grazie al ‘lavoro’ umano. Poi arriva il ‘denaro’, che da semplice mezzo di scambio diventa il motore del ‘capitale’. Il punto cruciale è come il capitale si accresce, non scambiando, ma estraendo ‘plusvalore’ dalla ‘forza-lavoro’ degli ‘operai’. Il libro analizza questo processo nella produzione, dalla ‘manifattura’ al ‘sistema di fabbrica’, spesso ambientato nell’Inghilterra del tempo, descrivendo la lotta per la giornata lavorativa e le condizioni difficili. Mostra come l”accumulazione’ del capitale generi ricchezza da un lato e ‘sovrappopolazione’ e miseria dall’altro, toccando anche la situazione in Irlanda. Esplora le origini violente del sistema, l”accumulazione originaria’, e poi le forme che il plusvalore assume: ‘profitto’ e ‘rendita fondiaria’, e il ruolo del ‘credito’ che, pur essenziale, può portare a ‘crisi’. È un’analisi profonda che lega insieme merce, denaro, capitale, lavoro, profitto e rendita, svelando i meccanismi e le contraddizioni interne del sistema.Riassunto Breve
La ricchezza nelle società dove si produce per il mercato appare come un insieme enorme di merci, e la merce singola è l’elemento base. Ogni merce ha un’utilità che soddisfa bisogni, questa è il suo valore d’uso, legato alle sue caratteristiche fisiche. Ma una merce ha anche valore perché contiene lavoro umano. La quantità di questo valore si misura con il tempo di lavoro socialmente necessario per produrla, cioè il tempo medio richiesto con le tecniche e l’intensità normali. Il lavoro nella merce ha due lati: è lavoro utile che crea valori d’uso ed è lavoro astratto che crea valore. Il valore si manifesta nello scambio con altre merci. La forma più semplice di valore è quando una merce esprime il suo valore in un’altra, che fa da equivalente. Questa forma si evolve fino alla forma denaro, dove una merce specifica, come l’oro, diventa l’equivalente universale. Il denaro rende il valore di scambio la forma visibile del valore. Il carattere strano della merce, il suo feticismo, nasce dal fatto che i rapporti tra le persone che producono appaiono come rapporti tra le cose. Il lavoro privato diventa sociale solo quando le merci vengono scambiate, e il valore, che viene dal lavoro, sembra una proprietà delle cose stesse.Il processo di scambio richiede che le persone si riconoscano come proprietari delle merci. Nello scambio, le merci devono prima mostrare il loro valore e poi la loro utilità. Ogni proprietario vuole scambiare la propria merce per un’altra che gli serve. Lo scambio è un atto individuale ma anche sociale, perché ogni merce si confronta con tutte le altre. Questo porta alla nascita del denaro come equivalente generale. Il denaro, come merce speciale, incarna il valore di scambio e supera il baratto. Il denaro misura il valore delle merci in prezzi. Il prezzo è una forma ideale ma dipende dalla realtà del denaro. Il denaro è anche mezzo di circolazione, mediando lo scambio Merce-Denaro-Merce (M-D-M), dove vendere e comprare sono fasi opposte ma legate. La circolazione crea dipendenza tra i produttori, e il denaro, pur nascendo dallo scambio, sembra muoversi da solo.Il capitale inizia dalla circolazione delle merci. Il denaro è la prima forma del capitale. Denaro come denaro (M-D-M, fine è il consumo) e denaro come capitale (D-M-D’, fine è l’aumento del valore) si distinguono per il loro percorso. Nel ciclo D-M-D’, il denaro viene anticipato per tornare aumentato (D’). Questo aumento è il plusvalore, che trasforma il denaro in capitale. Il plusvalore non nasce dallo scambio, ma dalla produzione. La merce chiave è la “forza-lavoro”, la capacità di lavorare. Il suo valore è il costo dei mezzi di sussistenza per il lavoratore. Il capitalista compra la forza-lavoro e la usa nella produzione. L’operaio usa i mezzi di produzione (capitale costante, che trasferisce valore) per creare merci. Il lavoro dell’operaio crea nuovo valore, incluso il plusvalore. La parte del capitale investita in forza-lavoro è capitale variabile, l’unica che crea nuovo valore.Il plusvalore è l’eccedenza del valore del prodotto sui costi. Il capitale si divide in costante (mezzi di produzione) e variabile (forza lavoro). Il plusvalore viene dal capitale variabile. Il saggio di plusvalore (plusvalore/capitale variabile) mostra quanto è sfruttata la forza lavoro. Il lavoro necessario è il tempo per produrre il valore della forza lavoro; il pluslavoro è il tempo extra che crea plusvalore per il capitalista. Il capitale cerca di allungare la giornata lavorativa per aumentare il pluslavoro. La storia capitalistica è segnata dalla lotta per limitare la giornata lavorativa.La massa del plusvalore dipende dal saggio di plusvalore e dal capitale variabile impiegato (numero di operai). Aumentare il numero di operai o il grado di sfruttamento aumenta la massa di plusvalore. Il capitale variabile è l’unica fonte di nuovo valore e plusvalore. Il capitale è dominio sul lavoro, costringendo la classe operaia a produrre lavoro non pagato. L’obiettivo del capitale è accumulare plusvalore sfruttando la forza lavoro.La produzione capitalistica inizia quando un capitalista impiega molti operai insieme (cooperazione). La cooperazione aumenta la forza produttiva collettiva, che appare come forza del capitale. La manifattura è una forma avanzata di cooperazione basata sulla divisione del lavoro, che aumenta la produttività ma rende l’operaio specializzato e dipendente. Le capacità intellettuali si separano dall’operaio e si concentrano nel capitale.La macchina nella grande industria non riduce la fatica, ma aumenta il plusvalore. La macchina utensile è il cuore del sistema di fabbrica. L’operaio diventa un’appendice della macchina. La macchina aumenta la produttività ma prolunga e intensifica il lavoro. Il capitale usa le macchine per sfruttare più forza lavoro, inclusa quella di donne e bambini, riducendo il valore complessivo della forza lavoro. La resistenza operaia è contro l’uso capitalistico delle macchine. La legislazione sulle fabbriche cerca di limitare lo sfruttamento, ma il capitale cerca sempre di estendere il dominio.La regolamentazione delle miniere è difficile per gli interessi convergenti di proprietari terrieri e capitalisti. Le inchieste rivelano condizioni terribili, lavoro minorile e femminile sfruttato, giurie parziali e ispezioni inefficaci. Le leggi sono insufficienti. La tendenza è estendere la legislazione di fabbrica a tutti i settori, inclusa l’agricoltura, che viene rivoluzionata dal capitale, sostituendo i contadini con salariati. Questo sistema, pur aumentando la produttività, rovina la forza lavoro e la terra, minando le basi della ricchezza.Il valore della forza lavoro è dato dai mezzi di sussistenza necessari. Prezzo della forza lavoro e plusvalore dipendono da durata, intensità e produttività del lavoro. Se la produttività aumenta, il valore della forza lavoro diminuisce e il plusvalore aumenta. L’intensità variabile cambia il valore prodotto. La durata variabile cambia il plusvalore. Le formule economiche classiche nascondono lo sfruttamento, facendo sembrare che tutto il lavoro sia pagato. Il salario, pagato per la forza lavoro, cancella la distinzione tra lavoro pagato e non pagato, nascondendo lo sfruttamento.Il salario si presenta come salario a tempo o a cottimo. Il salario a tempo si lega a leggi salariali. Il prezzo del lavoro è il valore giornaliero diviso per le ore. Il salario giornaliero può aumentare anche se il prezzo del lavoro diminuisce (allungando la giornata). Il salario a cottimo sembra basarsi sul prodotto, intensifica il controllo e può abbassare i salari medi. Le differenze salariali tra nazioni dipendono da costo della vita, produttività e intensità. Paesi più sviluppati hanno salari nominali più alti, ma non necessariamente reali o prezzi del lavoro più bassi.Il capitale inizia trasformando denaro in mezzi di produzione e forza lavoro (mercato), poi produce merci con plusvalore, e infine vende le merci per tornare denaro, ma aumentato. Questo è il ciclo del capitale (D-M-P-M’-D’). L’accumulazione dipende dalla vendita e dalla riconversione in capitale. Il plusvalore si divide in profitto, interesse, rendita, ma l’accumulazione è sempre plusvalore capitalizzato. La riproduzione semplice trasforma ogni capitale in plusvalore accumulato nel tempo, materializzazione di lavoro altrui non pagato. La produzione capitalistica riproduce la separazione tra lavoro e proprietà. L’operaio produce capitale che lo sfrutta ulteriormente.L’accumulazione capitalistica cambia la composizione del capitale, aumentando la parte costante rispetto alla variabile. Questo crea una sovrapopolazione operaia relativa, un esercito industriale di riserva, essenziale per il capitale. Questa legge porta a un peggioramento delle condizioni operaie nonostante l’aumento della ricchezza.Le condizioni abitative dei lavoratori sono pessime, con sovraffollamento e degrado. La demolizione di case rurali peggiora la situazione. Sistemi come le “gangs” agricole sfruttano manodopera a basso costo. In Irlanda, la popolazione diminuisce ma la rendita aumenta, spingendo i rurali in città. Questo scenario è legato all’accumulazione originaria, basata sull’espropriazione dei produttori dai loro mezzi, creando capitalisti e salariati con violenza e leggi coercitive.L’accumulazione originaria espropria i produttori diretti, distruggendo la proprietà basata sul lavoro personale e creando la proprietà capitalistica basata sullo sfruttamento. Sistema fiscale, debito pubblico, protezionismo e colonialismo sono strumenti di questa espropriazione. La grande industria nasce con lo sfruttamento brutale. La produzione capitalistica concentra i mezzi di produzione, ma genera anche le condizioni per la sua fine. La proprietà capitalistica, che nega la proprietà individuale, sarà negata dalla proprietà sociale, basata sulla cooperazione. L’espropriazione di molti da parte di pochi cede il passo all’espropriazione di pochi espropriatori da parte della massa.Il ciclo del capitale industriale ha tre fasi: denaro in merce (acquisto forza lavoro e mezzi), produzione (creazione merci con plusvalore), merce in denaro (vendita). Il fine è la valorizzazione. Queste fasi sono forme del capitale industriale nel suo movimento continuo. Il ciclo in forma denaro (D-M-P-M’-D’) mostra come la produzione sia legata alla circolazione.Il capitale denaro completa il ciclo per la parte variabile (salario). Il capitalista anticipa denaro. Il plusvalore si trasforma in reddito o si reinveste. Il ciclo del capitale produttivo (P…M’-D’-M…P) è il rinnovo del capitale produttivo. Il ciclo del capitale merce (M’-D’-M…P…M’) inizia con il capitale già valorizzato.Il ciclo del capitale è unità di produzione e circolazione, con scopo la valorizzazione. Le interruzioni nel ciclo individuale esistono, ma la continuità è del capitale sociale totale. Il movimento richiede tempo: tempo di produzione e tempo di circolazione. Il tempo di circolazione non crea valore ma è necessario. Ci sono costi di circolazione (puri e di conservazione) che non creano valore sociale ma sono necessari al sistema.Il capitale investito ruota continuamente. La rotazione è il tempo tra l’anticipo e il ritorno del capitale. Si distingue capitale fisso (macchinari, edifici, trasferisce valore gradualmente) e circolante (materie prime, forza lavoro, trasferisce valore completamente). Il capitale fisso ruota lentamente, il circolante rapidamente. La rotazione totale è la media ponderata. La rotazione del circolante può far superare il valore totale ruotato in un anno il capitale investito. Il ciclo pluriennale del capitale fisso contribuisce alle crisi.La distinzione tra capitale fisso e circolante si basa sul capitale produttivo. Quesnay la vede in agricoltura. Smith la generalizza ma la confonde con le forme di circolazione (merce, denaro). Ricardo la usa per eccezioni al valore e la confonde con costante/variabile. Il periodo di lavoro, durata dei processi produttivi, incide sulla rotazione e sul capitale circolante necessario. Periodi più lunghi rallentano la rotazione.Il tempo di produzione include il tempo di lavoro e processi naturali. Il tempo di circolazione è per vendere e reinvestire. Entrambi influenzano la rotazione e il capitale anticipato. Variazioni nei tempi o nei prezzi creano eccedenze o tensioni monetarie.Il saggio annuo di plusvalore dipende dalla velocità di rotazione del capitale variabile. Una rotazione rapida aumenta il saggio annuo. La rotazione influenza realizzazione e accumulazione del plusvalore. La durata del periodo di rotazione incide sul capitale denaro necessario e sul saggio annuo.Il valore di una merce è capitale costante, variabile e plusvalore. Alcune teorie trascurano il capitale costante. La riproduzione sociale si divide in produzione di mezzi di produzione e mezzi di consumo. La riproduzione semplice richiede scambi tra queste sezioni. Il denaro media gli scambi. Le crisi avvengono per squilibri tra le sezioni o consumo insufficiente. Il valore costante si presenta come mezzi di produzione, il valore nuovo come mezzi di consumo. La teoria di Smith che riduce tutto a reddito è sbagliata. La riproduzione del capitale fisso richiede accumulo di denaro.Il valore di una merce è c+v+p. Il prezzo di costo (c+v) è la spesa del capitalista, che nasconde che il plusvalore non gli costa nulla. Il profitto è la forma trasformata del plusvalore, che ne nasconde l’origine. Il saggio di profitto (p/capitale totale) è inferiore al saggio di plusvalore (p/v). Il saggio di profitto dipende da c, v e p. Variazioni in c o nel saggio di plusvalore cambiano il saggio di profitto.Il saggio di profitto varia con capitale costante e saggio di plusvalore. La rotazione rapida aumenta il profitto. L’economia nel capitale costante è importante ma può peggiorare le condizioni operaie. Le oscillazioni dei prezzi delle materie prime influenzano il profitto. Il capitalismo trascura l’agricoltura razionale per rispondere alle fluttuazioni.Le retribuzioni operaie sono a livelli di sussistenza. In crisi, i lavoratori sono usati in opere pubbliche a basso costo, a beneficio dei capitalisti. Le autorità borghesi controllano gli operai. I fabbricanti ostacolano l’emigrazione per mantenere bassa la forza lavoro. Questo crea un doppio profitto per la borghesia.Il saggio di profitto tende a diminuire con lo sviluppo capitalistico per l’aumento del capitale costante rispetto al variabile. La massa del profitto può aumentare perché il capitale totale cresce. La concorrenza livella i saggi. Cause contrastanti (aumento sfruttamento, riduzione costi c, sovrappopolazione, commercio estero) rallentano la caduta. La caduta tendenziale del profitto è una contraddizione del capitalismo.Il capitale commerciale (commercio merci e denaro) è specializzazione del capitale industriale. Non produce valore, il suo profitto è parte del plusvalore prodotto altrove. La sua rotazione dipende dalla produzione e dal consumo. Accelera la circolazione. Storicamente precede l’industriale, ma poi si subordina.Il capitale produttivo di interesse è denaro che genera profitto prestandolo. L’interesse è parte del profitto totale, pagato al capitalista monetario. Il saggio di interesse è determinato dalla concorrenza. Questa forma (D-D’) è la più alienata, il denaro sembra generare denaro da solo, nascondendo lo sfruttamento. È l’apice del feticismo del capitale.Il credito è essenziale per il capitalismo, uniforma i saggi di profitto, riduce i costi di circolazione, accelera il ciclo. Favorisce le società per azioni, dove il capitale diventa sociale e i capitalisti attivi diventano gestori. Il credito amplifica sovrapproduzione e speculazione, spingendo la riproduzione ai limiti. Accelera le crisi e la dissoluzione del sistema.Il capitale bancario include depositi (capitale preso in prestito). Il sistema trasforma ogni reddito in interesse di un capitale illusorio. Debito pubblico e azioni sono capitale fittizio. L’accumulazione di capitale denaro non sempre riflette l’accumulazione reale. Nelle crisi, c’è capitale denaro inattivo e capitale industriale fermo. Le crisi emergono per la limitatezza del consumo delle masse rispetto alla capacità produttiva. La crisi monetaria è sintomo di squilibri produttivi.La legge bancaria inglese del 1844 cercò di prevenire crisi legando emissione di banconote all’oro. Ma la sua rigidità esacerbò le crisi, impedendo alla banca di aumentare la liquidità necessaria. La legge fu sospesa in crisi per allentare la pressione. Dimostrò che la rigidità era un fattore di instabilità.La rendita fondiaria differenziale è sovraprofitto dalla produttività variabile dei terreni (fertilità, investimenti). La proprietà privata dà al proprietario il monopolio e gli permette di appropriarsi della rendita. Questo avviene anche comprimendo i salari agricoli. La rendita non è naturale ma sociale, parte del plusvalore.Nei terreni fertili, investimenti aggiuntivi generano sovraprofitto che diventa rendita. La rendita scompare quando il prezzo medio di produzione si allinea al prezzo generale. La rendita differenziale viene dalla diversa fertilità. La rendita assoluta viene dalla proprietà monopolistica che eleva i prezzi agricoli. Storicamente, la rendita passa da lavoro, a prodotti, a denaro. La rendita in denaro segna il passaggio al capitalismo agrario.La formula trinitaria (capitale-profitto, terra-rendita, lavoro-salario) distorce la realtà. Suggerisce che ricchezza e reddito vengano da tre fonti separate. Invece, capitale e terra sono rapporti sociali o risorse naturali, non creatori di valore. Il valore viene dal lavoro. La formula nasconde lo sfruttamento e fa apparire le categorie capitalistiche naturali. L’economia superficiale si ferma all’apparenza. La concorrenza rafforza questa mistificazione.Salari, profitto e rendita sembrano costituire il valore delle merci e regolano i prezzi. Questa visione ignora che il valore non dipende dalle fluttuazioni immediate ma dalle medie di lungo periodo. Per il capitalista, conta ottenere profitto o coprire i costi (salario, interesse, rendita). La scomposizione del valore in queste forme è una pratica capitalistica che si estende anche dove non sono presenti, rafforzando l’idea che i rapporti capitalistici siano universali. I rapporti di distribuzione sono espressione dei rapporti di produzione capitalistici e scompariranno con essi.Riassunto Lungo
1. L’essenza ambivalente della merce
La ricchezza nel sistema capitalista si presenta come un’enorme quantità di oggetti, chiamati merci. Ogni merce è la forma più semplice di questa ricchezza. Prima di tutto, una merce è qualcosa di esterno che serve a soddisfare i bisogni delle persone. Questi bisogni possono essere di vario tipo. Quando una cosa è utile, si dice che ha un valore d’uso. Questa qualità dipende dalle caratteristiche fisiche della merce stessa.Il valore della merce
Una merce ha valore solo perché in essa è contenuto lavoro umano, ma non un lavoro specifico, bensì lavoro umano generico, astratto. La quantità di questo valore si misura in base al tempo necessario, in media, per produrre quella merce. Questo tempo deve essere calcolato in condizioni normali di produzione, con persone che hanno una capacità e un impegno medi. Quindi, il valore di una merce è dato dal tempo di lavoro necessario per fabbricarla.La doppia natura del lavoro
Il lavoro che si trova nelle merci ha due aspetti diversi. Da un lato, è lavoro utile, cioè un lavoro concreto che produce oggetti utili, i valori d’uso. Dall’altro lato, è lavoro umano astratto, cioè lavoro generico che crea valore. Questa doppia natura del lavoro si riflette nel modo in cui si presenta il valore della merce, che si manifesta quando la merce viene scambiata con altre merci.La forma del valore e il denaro
La forma più semplice in cui si presenta il valore è quella relativa. In questa forma, una merce mostra il suo valore mettendolo in relazione con un’altra merce, che funge da equivalente. Questa forma di valore cambia e si sviluppa passando attraverso diverse fasi. Si parte dalla forma semplice, poi si arriva a una forma più completa e generale, fino a raggiungere la forma denaro. La forma denaro è l’ultima tappa di questo processo. In questa forma, l’oro diventa l’equivalente universale, cioè la merce che rappresenta il valore di tutte le altre. Così, il valore di scambio diventa il modo in cui il valore si manifesta concretamente.Il feticismo della merce
La merce appare misteriosa, quasi magica. Questo “feticismo” della merce nasce dal fatto che i rapporti tra le persone che producono le merci sembrano trasformarsi in rapporti tra oggetti. È come se le relazioni sociali tra i produttori si nascondessero dietro lo scambio di merci. Questo scambio tipico del sistema di produzione delle merci, dove il lavoro del singolo produttore diventa lavoro socialmente utile solo attraverso lo scambio con gli altri. In questo sistema, il valore, che in realtà è creato dal lavoro umano, sembra essere una caratteristica naturale delle merci stesse. Solo capendo che il lavoro è di natura sociale, si può svelare questo “segreto” che si nasconde dietro la merce.Ma è davvero il “lavoro umano astratto” l’unica fonte del valore di una merce, come suggerisce il capitolo?
Il capitolo presenta una visione specifica del valore, derivante da una particolare scuola di pensiero economico. Tuttavia, questa prospettiva non è universalmente accettata. Per avere un quadro più completo, sarebbe utile esplorare altre teorie del valore, come quelle proposte dall’economia neoclassica, che si concentrano maggiormente sull’utilità e sulla scarsità come determinanti del valore. Approfondire autori come Smith, Ricardo e Marx è essenziale per comprendere le diverse sfumature e i dibattiti ancora aperti sulla natura del valore economico.2. La Metamorfosi delle Merci
Lo scambio e la proprietà privata
Perché le merci possano essere scambiate, è fondamentale che ci siano persone che agiscono come proprietari privati. Queste persone devono riconoscersi reciprocamente questo ruolo. Questo rapporto di riconoscimento avviene attraverso i contratti, che sono la forma legale di questo legame economico. Quando avviene lo scambio, le persone non si presentano semplicemente come individui, ma come rappresentanti delle merci che possiedono.Valore d’uso e valore di scambio
Prima di poter essere scambiate, le merci devono diventare sia valori, sia valori d’uso. Chi possiede una merce vuole darla via per ottenerne un’altra che gli serve. Questo scambio è un atto personale, perché risponde a un bisogno individuale. Però, lo scambio è anche un fatto sociale generale, perché ogni merce viene confrontata con tutte le altre merci disponibili sul mercato. Questa contraddizione si risolve quando compare una merce speciale: il denaro, che diventa l’equivalente universale di tutte le altre merci.L’origine del denaro
All’inizio, come denaro si usavano i metalli preziosi, come l’oro e l’argento. Questi metalli erano apprezzati per le loro caratteristiche naturali. Col tempo, il denaro è diventato una merce particolare con una funzione sociale specifica. La forma denaro è un riflesso dei rapporti tra tutte le merci. Il denaro non ha un valore suo proprio, ma lo prende dal lavoro umano che èMaterializzato nelle merci. Quindi, il denaro non è solo un simbolo, ma è una merce vera e propria che rappresenta il valore di scambio. Grazie al denaro, si superano i limiti del baratto e si sviluppa la differenza tra valore d’uso e valore di scambio delle merci.Il denaro come misura e mezzo di scambio
Il denaro serve a misurare il valore delle merci e permette di esprimere questo valore in prezzi. I prezzi sono idealmente espressi in quantità d’oro. Anche se il prezzo è una forma astratta, dipende dalla realtà concreta del denaro. Per questo, il prezzo può anche non corrispondere esattamente al valore reale della merce. Il denaro funziona anche come mezzo di scambio, facilitando il passaggio Merce-Denaro-Merce (M-D-M). In questo processo, la vendita (M-D) e l’acquisto (D-M) sono due momenti opposti ma che si completano a vicenda. La circolazione delle merci crea un legame di dipendenza tra chi le produce. Il denaro, anche se nasce dallo scambio delle merci, sembra diventare il motore autonomo di questo scambio. La quantità di denaro che serve per far circolare le merci dipende dalla somma dei prezzi di tutte le merci scambiate e dalla velocità con cui il denaro stesso circola. Inoltre, il denaro può essere sostituito da simboli di valore, come la carta moneta. Anche in forma simbolica, il denaro continua a svolgere la sua funzione sociale.Se il denaro nasce dallo scambio di merci, come mai sembra acquisire una forza autonoma che guida lo scambio stesso, quasi fosse un motore indipendente dalla volontà umana?
Il capitolo descrive efficacemente come il denaro emerga dalle dinamiche dello scambio di merci, ma non indaga a fondo la potenziale inversione di questo rapporto. Se il denaro è originato dallo scambio, come si spiega la sua capacità di influenzare e persino determinare le dinamiche dello scambio stesso, al punto da apparire come una forza esterna e autonoma? Per rispondere a questa domanda cruciale, è utile approfondire le teorie economiche che analizzano il denaro non solo come mezzo di scambio, ma anche come strumento di potere e controllo sociale. Autori come Michel Foucault e Pierre Bourdieu offrono strumenti concettuali utili per decostruire la presunta autonomia del denaro e comprenderne le implicazioni politiche e sociali.3. La Genesi del Capitale
La base di partenza del capitale è lo scambio di merci. Il denaro, che è il risultato finale di questo scambio, è la forma iniziale in cui il capitale si presenta. È importante distinguere tra denaro inteso semplicemente come denaro e denaro inteso come capitale, perché questi due tipi di denaro hanno percorsi di scambio diversi. Lo scambio semplice di merci, che si può schematizzare come Merce-Denaro-Merce (M-D-M), ha come scopo finale il consumo di beni utili. Al contrario, lo scambio di denaro come capitale, schematizzato come Denaro-Merce-Denaro (D-M-D), ha l’obiettivo di aumentare il valore del denaro stesso.La Circolazione del Denaro come Capitale
Nel modello D-M-D, si parte da una somma di denaro che viene investita per ottenere alla fine una somma maggiore. Questo aumento di valore, chiamato plusvalore, è ciò che trasforma il denaro in capitale. La formula completa D-M-D’ mette in evidenza come il denaro iniziale (D) cresca fino a diventare una somma più grande (D’), grazie al passaggio intermedio attraverso la merce (M). In questo tipo di scambio, l’accumulo di denaro diventa lo scopo principale, creando un ciclo continuo di crescita del valore.L’Origine del Plusvalore
È fondamentale capire che il plusvalore non nasce dallo scambio di merci in sé. Infatti, se si scambiano merci di valore equivalente, non si crea valore aggiuntivo. Il plusvalore si genera in una fase diversa, quella della produzione, che avviene al di fuori del semplice scambio. Per capire come si crea il plusvalore, bisogna concentrarsi su una merce particolare: la “forza-lavoro”.La Forza-Lavoro come Merce Speciale
La forza-lavoro rappresenta l’insieme delle capacità fisiche e intellettuali di una persona, utilizzate nel lavoro. Il valore della forza-lavoro è determinato dal tempo necessario per produrla, cioè dal valore dei beni di prima necessità che servono al lavoratore per vivere e poter lavorare. Il capitalista compra la forza-lavoro e la utilizza nel processo produttivo.Il Processo di Produzione e la Creazione di Valore
Durante il processo produttivo, il lavoratore, sotto la direzione del capitalista, usa gli strumenti di produzione per creare merci. Il lavoro dell’operaio crea valore, aggiungendo valore ai mezzi di produzione già esistenti. Una parte del denaro investito si trasforma in strumenti di produzione, che costituiscono il capitale costante. Questo capitale costante trasferisce il suo valore al prodotto finito senza però aumentarlo. L’altra parte del denaro investito serve per pagare la forza-lavoro, ed è chiamata capitale variabile. Il capitale variabile è l’unico che crea nuovo valore, incluso il plusvalore. La differenza fondamentale tra capitale costante e capitale variabile sta quindi nel loro ruolo diverso nella creazione di nuovo valore.Ma è davvero così diffusa questa “formula trinitaria”, o si tratta di un espediente retorico per semplificare un discorso più complesso?
Il capitolo critica la “formula trinitaria” come una rappresentazione ingannevole, ma non chiarisce se questa formula sia effettivamente un modello di pensiero dominante nell’economia contemporanea, o se piuttosto rappresenti una semplificazione utile a introdurre una critica più radicale. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire la storia del pensiero economico, studiando autori come Marx, che ha analizzato criticamente le categorie economiche classiche, e confrontarsi con le diverse scuole di pensiero economico per capire quanto questa “formula” sia ancora rilevante o influente.36. Le Forme Distributive e la Realtà Produttiva
L’apparenza del valore nel sistema capitalistico
Nel sistema capitalistico, si ripete continuamente un ciclo di rapporti economici in cui cause e conseguenze si influenzano a vicenda. Salari, profitto e rendita sembrano essere gli elementi che formano il valore delle merci. Questa idea è rafforzata dal fatto che questi elementi si ritrovano sempre nei contratti economici. Tuttavia, questa visione non spiega veramente come cambia il valore. Il valore non dipende dai cambiamenti immediati dei prezzi di mercato, ma piuttosto da medie di lungo periodo di salario, profitto e rendita.La percezione distorta del valore aggiunto
Nella realtà del capitalismo, sembra che il valore aggiunto nella produzione derivi da salario, profitto e rendita. Questa impressione si estende anche alla parte fissa del capitale. Ma se si guarda più a fondo, questa idea rischia di diventare un ragionamento che non porta a nulla di nuovo. Sembrerebbe che il valore delle merci sia creato dal valore delle merci stesse. Invece, per chi investe il capitale, capire il valore in sé non è la cosa più importante. Ciò che conta è la possibilità di guadagnare più del normale o di coprire le spese per produrre, che comprendono salario, interesse e rendita.Salario, interesse e rendita come regolatori del prezzo
Salario, interesse e rendita appaiono come fattori che controllano il prezzo, influenzando la capacità di chi investe di fare profitto. Quando i capitalisti competono tra loro, sia in un paese che tra paesi diversi, considerano queste grandezze come fisse per calcolare quanto guadagneranno dalle merci. Per questo motivo, si finisce per pensare che salario, interesse e rendita creino e regolino il prezzo.L’interpretazione capitalistica del reddito
Dividere il valore in salario, profitto e rendita è diventata una pratica comune nel capitalismo. Questa pratica è usata anche in situazioni dove queste forme di guadagno non esistevano all’inizio. Si tende a interpretare ogni tipo di guadagno attraverso questa visione capitalistica. Questo rafforza l’idea che i rapporti capitalistici siano normali e validi per tutti.La vera natura dei rapporti di distribuzione
Nonostante l’apparenza, i rapporti di distribuzione sono in realtà un modo in cui si manifestano i rapporti di produzione tipici del capitalismo. La distribuzione capitalistica, basata su salario, profitto e rendita, non è qualcosa di naturale, ma una forma che si è creata nella storia. Essa riflette il modo specifico in cui la produzione è organizzata nella società capitalistica. Questa forma di distribuzione scomparirà quando il sistema capitalista sarà superato. Quindi, per criticare veramente l’economia borghese, bisogna analizzare anche i rapporti di produzione. Non bisogna limitarsi a pensare che solo i rapporti di distribuzione siano soggetti ai cambiamenti della storia.Se salario, interesse e rendita sono solo forme distributive del valore già prodotto, da dove deriva realmente il valore nel sistema capitalistico, e perché il capitolo sembra fermarsi all’apparenza senza svelare la vera natura della produzione?
Il capitolo descrive come il sistema capitalistico presenti salario, interesse e rendita come costituenti del valore, ma poi afferma che questa è solo un’apparenza. Se questi elementi sono meri distributori di valore preesistente, allora il capitolo dovrebbe chiarire in modo più esplicito quale sia l’origine di questo valore e come la produzione capitalistica lo generi. Per rispondere a questa domanda cruciale, sarebbe utile approfondire le teorie economiche che si concentrano sulla produzione e sulla creazione del valore, come quelle di autori che hanno studiato a fondo i meccanismi del capitalismo e le sue contraddizioni interne.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]