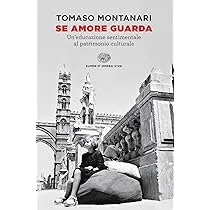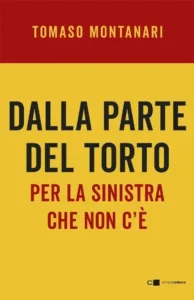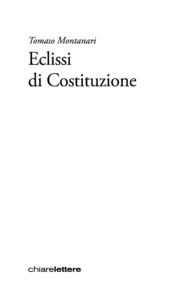1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“I vinti. Il corpo nella storia dell’arte” di Tomaso Montanari è un libro che ti fa guardare la storia dell’arte in un modo diverso. Non parla solo di stili o tecniche, ma mette al centro il corpo umano, specialmente quello fragile, sconfitto, quello che di solito non è l’eroe. Montanari ci porta in un viaggio che parte dall’arte medievale, con Giotto e Dante che mostrano il peso fisico delle persone, passa per l’arte rinascimentale dove artisti come Masaccio e Donatello dipingono corpi veri, pieni di vita e fatica. Vediamo Michelangelo che scolpisce corpi potenti ma prigionieri, e Caravaggio che usa il corpo per parlare di potere e violenza. Il libro esplora come la rappresentazione artistica, da Piero della Francesca a Crespi, trovi bellezza e dignità anche negli ultimi, negli schiavi come quelli scolpiti da Tacca o nei poveri. Fino ad arrivare al “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo, dove i corpi degli oppressi marciano nella luce. È un percorso che ti fa capire come la storia dell’arte, attraverso la vulnerabilità e la dignità del corpo, racconti la storia umana.Riassunto Breve
L’arte mette al centro il corpo umano, mostrandone il peso e la concretezza. Giotto raffigura la rinuncia di san Francesco come un atto fisico e pubblico, con il corpo nudo esposto in piazza, punto di partenza della sua spiritualità e inizio per la storia dell’arte occidentale. Anche Dante descrive lo svenimento con l’immagine di un corpo che cade pesantemente, come morto. Giovanni Pisano, nella scultura per la tomba di Margherita di Brabante, mostra angeli che faticano a sollevare il corpo, sottolineando il suo legame con la terra anche nell’ascesa spirituale. Le storie delle persone sono storie dei loro corpi, con la loro materialità e il loro peso nel mondo. Il Rinascimento vede un ritorno del corpo nell’arte, che si incarna e riflette la realtà umana, la sua debolezza e fragilità. Masaccio porta il vivo e il naturale nella pittura, usando lo spazio reale e la credibilità umana per mostrare la storia sacra nella carne, vicina agli uomini. Le sue scene si svolgono nelle strade, con protagonisti corpi sconfitti, malati, disgraziati, dipinti con grande maestria, invertendo la gerarchia tradizionale e concentrandosi sui poveri e sulla comunità, come nella “Madonna Povera”. Il corpo diventa anche il luogo del miracolo. Piero della Francesca dipinge la Madonna del Parto, un corpo che accoglie un altro corpo, legando il divino alla maternità umana nella sua pienezza. Donatello raffigura la resurrezione di Cristo con un corpo stanco e fragile, appena uscito dalla tomba, mostrando la fatica del morire e risorgere, rendendo l’evento divino vicino all’esperienza umana della fatica e della sofferenza. Entrambi gli artisti rendono visibile e comprensibile l’evento divino attraverso la carne e l’esperienza fisica. Michelangelo Buonarroti si concentra unicamente sul corpo umano, rappresentandone tragedia, maestà, fragilità e forza. Le sculture dei Prigioni mostrano corpi che si contorcono, esprimendo stati d’animo e la condizione umana, la prigionia del corpo ma anche la sua potenziale liberazione, legata alla promessa cristiana della resurrezione della carne. In contrasto, Correggio presenta un “corpo danzante”. Nel suo Noli me Tangere, il corpo risorto di Gesù è diverso, libero dalla sofferenza, quasi impensabile per gli occhi. Il riconoscimento avviene attraverso la relazione umana, chiamando per nome, condividendo il cibo, prendendosi cura del corpo, gesti che permettono di riconoscere la comune umanità. L’idea di resurrezione si lega a una forma di danza, immagine di vita e liberazione. Il Seicento esplora il rapporto tra corpi e potere e lo sguardo negato. Il ritrovamento del corpo di Santa Cecilia genera attenzione sulla vista, sulla necessità di vedere i corpi. La statua di Stefano Maderno rappresenta corpi vulnerabili, come vittime di guerra o migranti, costringendo chi guarda a riconoscersi testimone. Caravaggio, nelle sue opere finali, esplora il rapporto tra corpi e potere, evidenziando l’importanza di vedere i corpi. Dipinti come il seppellimento di Santa Lucia mostrano corpi colpiti dal potere e dalla politica, schiacciati dallo spazio, suggerendo solitudine e tormento. Queste opere affrontano la difficoltà di guardare i corpi vulnerabili e l’impatto del potere su di essi. La Decollazione di San Giovanni Battista di Caravaggio raffigura la violenza omicida del potere sul corpo, il controllo della vita e la punizione capitale. L’ambiente è squallido e opprimente, riflettendo la banalità del male. È una rappresentazione immersa nelle tenebre, senza speranza, mostrando la fine di chi si oppone al potere, pagando con il corpo. La firma nel sangue unisce arte e violenza, ma la pittura è l’unica speranza. L’arte rivela l’umanità e la bellezza anche in figure marginali. Il monumento dei Quattro Mori a Livorno, con i ritratti scultorei di schiavi reali, riconosce la loro umanità e bellezza. Nel Settecento, Giuseppe Maria Crespi dipinge scene di vita quotidiana semplice, dando dignità ai corpi degli ultimi e all’ambiente circostante con uno sguardo che porta in superficie l’umanità e la bellezza semplice. Il dipinto “Il Quarto Stato” è un’icona politica e sociale che unisce elementi classici e tecnica divisionista per creare una luce che simboleggia il futuro e mette in risalto i corpi degli oppressi e sfruttati, mostrando la loro umanità e dignità nella lotta. Il gruppo centrale rappresenta diverse età, suggerendo una liberazione che riguarda la dignità umana in ogni fase. L’opera rovescia la prospettiva storica, ponendo i corpi delle vittime nella luce, mentre gli oppressori restano nel buio. La marcia, la lotta e la luce del quadro interpellano il presente, stimolando riflessione sulla condizione attuale e sulla possibilità di cambiamento collettivo.Riassunto Lungo
1. Il peso dei corpi nell’arte
L’arte e la cultura di questo periodo mettono al centro la figura umana e la sua presenza fisica. Non si guarda solo all’anima o allo spirito, ma al corpo concreto, con le sue fragilità e la sua forza. Questa attenzione al corpo segna un cambiamento importante nel modo di rappresentare l’esperienza delle persone. Le storie individuali e spirituali si manifestano attraverso la fisicità, rendendo il corpo un elemento fondamentale per capire le opere d’arte. L’arte di questo tempo può essere letta proprio attraverso la rappresentazione dei corpi, anche quando questi appaiono vinti o sofferenti.Il corpo nudo di San Francesco
Nell’affresco di Giotto che mostra la rinuncia di San Francesco, l’atto è presentato come un evento fisico e visibile a tutti. Francesco si toglie i suoi vestiti ricchi, rimanendo nudo in mezzo alla piazza. Questo corpo esposto, fragile nella sua nudità, diventa il punto di partenza della sua vita spirituale. La scena dipinta da Giotto sottolinea come la storia di Francesco non sia fatta solo di scelte spirituali, ma anche di gesti concreti che coinvolgono il corpo. Il suo corpo nudo, mostrato in pubblico, simboleggia una sconfitta agli occhi del mondo ma rappresenta un trionfo interiore e un nuovo inizio.Il peso del corpo che cade
Anche nella letteratura, si ritrova questa attenzione alla realtà fisica del corpo. Quando Dante descrive uno svenimento, usa l’immagine forte del corpo che cade pesantemente, come se fosse un corpo senza vita. Questo dettaglio mette in evidenza il peso concreto e la materialità del corpo nelle esperienze umane più intense. La descrizione non si ferma alla perdita di coscienza, ma insiste sulla forza di gravità che trascina il corpo a terra. Questa immagine comunica in modo efficace quanto il corpo sia una presenza ineludibile, con la sua massa e il suo peso, anche nei momenti di passaggio o debolezza.La fatica degli angeli
Un’idea simile si ritrova nella scultura di Giovanni Pisano per la tomba di Margherita di Brabante. Anche se l’opera rappresenta l’anima che viene portata in cielo, Pisano sceglie di scolpire tre corpi ben definiti. Gli angeli che sollevano Margherita non sono figure leggere e senza peso; al contrario, sono rappresentati vestiti come persone e mostrano chiaramente la fatica nel sostenere il corpo. Questa immagine potente suggerisce che, nonostante l’ascesa spirituale, il corpo mantiene un suo peso che lo lega in qualche modo alla terra. La scultura di Pisano evidenzia come la materialità del corpo sia una realtà con cui fare i conti, anche nel contesto di un viaggio ultraterreno.Ma quale periodo è esattamente questo, e siamo certi che l’attenzione al corpo sia una novità così radicale?
Il capitolo si riferisce a un generico “questo periodo” senza definirlo con precisione, creando un’ambiguità sul contesto storico specifico. L’affermazione che l’attenzione al corpo “segna un cambiamento importante” suggerisce una rottura col passato, ma non viene fornito il necessario confronto con l’arte e la cultura dei periodi precedenti per giustificare tale radicalità. L’arte classica, ad esempio, aveva già posto il corpo umano al centro. Per chiarire questa lacuna e valutare la reale portata del cambiamento, sarebbe utile approfondire la storia dell’arte medievale e rinascimentale, mettendola in relazione con l’arte classica. Autori come Panofsky o Gombrich possono fornire strumenti critici per analizzare la periodizzazione e l’evoluzione dei temi figurativi.2. La Verità nella Carne
Nel Rinascimento, l’arte si concentra nuovamente sul corpo, riflettendo la realtà umana con le sue debolezze e fragilità. Masaccio è fondamentale in questo cambiamento, introducendo il senso del vivo e del naturale nella pittura. Questo nuovo approccio è evidente nella cappella Brancacci, realizzata tra il 1424 e il 1427, dove le storie sacre prendono vita e si avvicinano all’esperienza umana. L’arte inizia a riflettere la realtà umana, mostrando la sua debolezza e fragilità in modo nuovo. Qui, la storia sacra si incarna, diventando vicina e comprensibile per gli uomini.Masaccio e la realtà quotidiana
Masaccio prende spunto dallo spazio reale di Brunelleschi e dalla profonda umanità delle figure di Donatello. Applica queste innovazioni alla rappresentazione della vita di tutti i giorni, quella più umile. Le sue scene spesso si svolgono nelle strade di Firenze, mostrando persone comuni e i poveri. I veri protagonisti diventano i corpi segnati dalla fatica, i malati, i disgraziati. È su queste figure che Masaccio concentra la sua attenzione.Una nuova gerarchia nell’arte
È significativo il modo in cui Masaccio lavora: dipinge le figure degli umili e dei sofferenti con grande maestria, riservando a sé la loro esecuzione. Al contrario, affida la pittura delle figure dei santi ai suoi aiutanti. Questo approccio inverte la gerarchia tradizionale dell’arte sacra, spostando l’attenzione principale sull’umanità più fragile e meno privilegiata. Un esempio concreto di questo nuovo focus è la rappresentazione di una ‘Madonna Povera’, che incarna l’importanza data ai poveri e all’intera comunità.Ma siamo davvero certi che Masaccio riservasse a sé solo i corpi segnati dalla fatica, lasciando i santi agli aiutanti, in una così netta inversione di gerarchia?
Il capitolo propone un’interpretazione suggestiva del metodo di Masaccio, legandola a una precisa volontà di rovesciare le priorità artistiche tradizionali a favore degli umili. Tuttavia, l’attribuzione delle mani all’interno di un affresco rinascimentale e le dinamiche esatte delle botteghe sono questioni complesse e spesso dibattute tra gli storici dell’arte. Affermare con tale sicurezza che l’affidamento dei santi agli aiutanti fosse una scelta deliberata per svalutarli rispetto agli umili, piuttosto che una divisione del lavoro legata a ruoli, tempi o specificità tecniche, richiede un confronto con le diverse letture critiche e le fonti storiche disponibili. Per approfondire questo aspetto controverso, è consigliabile esplorare gli studi sulla tecnica pittorica di Masaccio e sulle pratiche delle botteghe rinascimentali, consultando autori che si sono dedicati alla storia dell’arte del Quattrocento e alle problematiche attributive.3. Il Miracolo nel Corpo
Piero della Francesca dipinge la Madonna del Parto, un affresco che mette al centro la figura di Maria incinta. Questa immagine mostra un corpo che accoglie un altro corpo, rappresentando la maternità umana in tutta la sua concretezza e pienezza, con i segni visibili e tangibili dello stato. L’opera di Piero della Francesca riesce a legare in modo potente il divino all’aspetto più fisico e terreno, rendendo l’esperienza della maternità un concetto universale e profondamente umano. Questa rappresentazione così corporea e terrena della figura sacra si distingue dalle tendenze successive della Chiesa, che tenderà a evitare immagini troppo legate alla fisicità, preferendo concentrarsi sulla figura del Cristo risorto in una forma più eterea.Il Corpo Fragile e la Resurrezione
Donatello affronta il tema della resurrezione di Cristo con una visione differente, visibile nei suoi lavori in bronzo. Qui, Gesù non appare come un vincitore trionfante e forte, ma emerge dalla tomba in un modo che comunica fatica e vulnerabilità. È raffigurato appena uscito dal sepolcro, ancora parzialmente coperto dalle bende, con un aspetto stanco e fragile. Questo corpo mostra chiaramente il peso e la sofferenza affrontati nel morire e nel risorgere, un corpo che ha superato una prova immensa. La stanchezza e la fragilità che Donatello infonde nella figura di Cristo rendono l’evento della resurrezione più vicino all’esperienza umana fatta di fatica, dolore e sofferenza. In queste opere, i soldati posti a guardia della tomba sono spesso raffigurati mentre dormono, ignari del miracolo che si sta compiendo, sottolineando la natura quasi silenziosa e intima di questa resurrezione corporea.La Fisicità come Ponte verso il Divino
Sia Piero della Francesca che Donatello, pur con approcci e soggetti diversi, scelgono di usare il corpo umano come strumento principale per mostrare il miracolo. Entrambi gli artisti rendono visibile e comprensibile l’evento divino non attraverso simboli astratti, ma tramite la carne, i segni fisici e l’esperienza corporea. Collegano così il sacro alla vita quotidiana e alla condizione umana, mostrando che il miracolo si manifesta e si rende accessibile proprio attraverso la realtà fisica e sensibile del corpo.Ma davvero un monumento che celebra il potere del Granduca sui suoi nemici catturati può essere letto principalmente come un riconoscimento della dignità degli schiavi?
Il capitolo propone un’interpretazione suggestiva dell’arte come veicolo di dignità per gli “ultimi”, ma l’esempio dei Quattro Mori presenta una potenziale lacuna argomentativa. Affermare che l’arte “riconosce e mette in luce la dignità umana degli schiavi” basandosi sulla qualità scultorea delle figure potrebbe trascurare il contesto storico e lo scopo primario del monumento, che era celebrare il potere e le vittorie del Granduca Ferdinando I. La “bellezza” delle figure potrebbe essere più legata alle convenzioni artistiche dell’epoca e all’abilità dello scultore nel rappresentare il corpo umano, piuttosto che a un intento esplicito di conferire dignità ai soggetti raffigurati come schiavi in quel preciso contesto celebrativo. Per approfondire questa tensione tra interpretazione artistica e contesto storico-sociale, sarebbe utile esplorare la storia sociale dell’arte e l’iconografia, considerando autori che hanno analizzato come le rappresentazioni artistiche riflettano e al contempo influenzino le percezioni sociali, senza dimenticare di studiare a fondo il periodo storico specifico e le dinamiche della schiavitù mediterranea.8. La Marcia nella Luce
Il dipinto “Il Quarto Stato” si presenta come un’immagine potente, riconosciuta come un’icona sia politica che sociale. La sua forza visiva deriva da una composizione che unisce sapientemente elementi classici con la tecnica divisionista, un accostamento che genera un effetto di grande luminosità sull’intera scena. Questa luce non è un semplice dettaglio tecnico, ma assume un profondo significato simbolico: rappresenta la speranza nel futuro e illumina con forza i corpi delle persone oppresse e sfruttate. Le figure che avanzano nella tela appaiono vividamente illuminate, un dettaglio che sottolinea la loro profonda umanità e la loro intrinseca dignità, anche nel difficile contesto della lotta che stanno affrontando.Origine e Contesto Storico
Al centro del dipinto, un gruppo di persone di diverse età cattura l’attenzione, suggerendo che la liberazione e il riconoscimento della dignità umana non siano limitati a una sola classe sociale o fase della vita, ma riguardino l’intera condizione umana. L’opera stessa nasce come una risposta diretta e sentita a eventi drammatici: la violenta repressione avvenuta a Milano nel 1898, dove operai che manifestavano pacificamente furono brutalmente uccisi. La decisione successiva del re di onorare con un’onorificenza il generale responsabile di quella repressione crea un contrasto stridente e voluto nel quadro. Questo contrasto è reso visibile dal pittore che relega gli oppressori nell’ombra, mentre le vittime e i manifestanti avanzano coraggiosamente nella luce, rappresentando un vero e proprio rovesciamento storico, focalizzato sulla presenza fisica e sul valore dei corpi.Storia e Rilevanza Attuale
La storia del dipinto continua nel 1920, quando fu acquisito dal Comune di Milano grazie a una straordinaria raccolta fondi che vide la partecipazione attiva di molte persone, inclusi i cittadini più poveri. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, l’opera trovò una collocazione significativa nella sala consiliare del Comune, dove rimase esposta fino al 1980. Ancora oggi, temi centrali come la marcia, la lotta per i diritti e la luce che illumina il cammino interpellano direttamente il presente. Il quadro stimola una riflessione profonda sulla condizione sociale attuale e mantiene viva la possibilità di immaginare e realizzare un cambiamento collettivo.Ma questa ‘marcia nella luce’ è davvero un ‘rovesciamento storico’ o solo una potente aspirazione simbolica?
Il capitolo presenta l’opera come un “vero e proprio rovesciamento storico”, ma questa affermazione meriterebbe maggiore approfondimento. Non è del tutto chiaro come il dipinto, pur nella sua potenza simbolica, costituisca di per sé un “rovesciamento” degli eventi storici, piuttosto che una reazione o una rappresentazione di un desiderio di cambiamento. Per comprendere meglio le diverse letture critiche e storiche dell’opera, sarebbe utile esplorare la storiografia sull’arte sociale e sul realismo, oltre agli studi specifici sull’autore. Approfondire il contesto storico preciso degli eventi del 1898 e le loro conseguenze politiche e sociali, leggendo autori che hanno trattato la storia sociale italiana del XIX secolo, può fornire ulteriori strumenti per valutare la portata dell’opera.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]