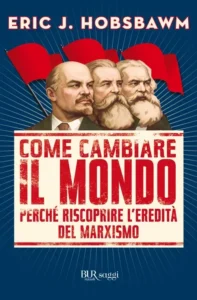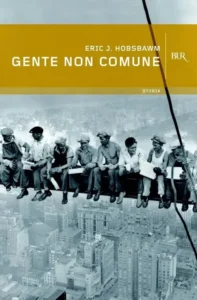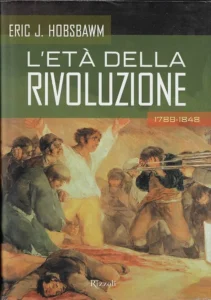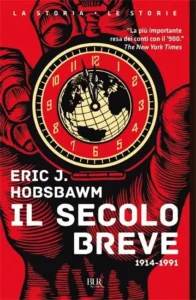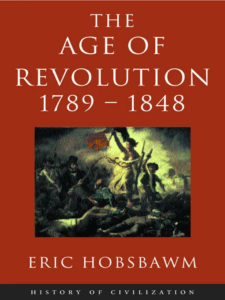1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“I rivoluzionari” di Eric Hobsbawm è un viaggio pazzesco nel cuore delle idee e dei movimenti che hanno cercato di cambiare il mondo, partendo dall’onda d’urto della Rivoluzione Bolscevica che ha dato vita ai Partiti Comunisti in Occidente. Il libro scava nel paradosso del comunismo occidentale, nato per la rivoluzione ma costretto a vivere in società non rivoluzionarie, guardando alle diverse traiettorie del comunismo in paesi come l’Italia, con il suo Partito Comunista Italiano (PCI) forte, o la Germania, dove il KPD è fallito, e analizzando il rapporto complicato tra i partiti e gli intellettuali. Non si ferma al Marxismo e al Leninismo, ma esplora anche l’Anarchismo, confrontandolo con il Bolscevismo e vedendo i suoi limiti, per esempio nella Guerra Civile Spagnola, e l’influenza del Marxismo sul Movimento Operaio Inglese, anche quando ha preso strade più riformiste. Hobsbawm ci porta a riflettere sulle diverse interpretazioni del Marxismo, sul revisionismo socialista, su figure come Korsch e Althusser, ma anche sulla natura del potere, della violenza, e sull’imprevedibilità delle rivoluzioni, come dimostra il Maggio 1968 in Francia. È un libro che ti fa capire come le rivoluzioni non nascano dal nulla, ma da dinamiche politiche e sociali complesse, e come figure come gli intellettuali abbiano giocato un ruolo chiave, senza dimenticare la forza persistente del Nazionalismo nell’era moderna.Riassunto Breve
L’origine dei partiti comunisti in Occidente è strettamente legata al crollo della Seconda Internazionale e alla Rivoluzione Bolscevica, che ha fornito un modello e ispirazione. Questi partiti, nati dalla combinazione di movimenti locali e dall’attrattiva della Rivoluzione d’Ottobre, hanno incontrato difficoltà perché le condizioni rivoluzionarie mancavano nei paesi occidentali. La fedeltà a Mosca creava tensioni con le realtà politiche nazionali. Alcuni partiti, come quello inglese, sono rimasti marginali, mentre altri, come quello francese, sono diventati di massa ma hanno affrontato il paradosso di essere rivoluzionari in società non rivoluzionarie.Gli intellettuali occidentali si sono avvicinati al marxismo più tardi rispetto alla Russia, spinti da eventi come la Prima Guerra Mondiale e la crisi del ’29. Il rapporto tra intellettuali e partiti comunisti è stato complesso, segnato dalla rigidità dogmatica dei partiti che limitava la libertà di pensiero, ma anche da adesioni motivate da cause come l’antifascismo. Il Partito Comunista Italiano è un esempio di successo nel dopoguerra, grazie alla Resistenza e a una leadership forte, a differenza del Partito Comunista Tedesco che non è riuscito ad affermarsi.Accanto al bolscevismo, l’anarchismo condivideva l’obiettivo di una società senza stato, ma rifiutava ogni forma di potere centralizzato, puntando sulla spontaneità. Nonostante un ideale comune, le differenze strategiche hanno portato a un dialogo fallito e al declino dell’anarchismo come forza politica organizzata su larga scala, come mostrato nella guerra civile spagnola, anche se le sue idee sulla spontaneità e la critica all’autoritarismo mantengono una certa rilevanza.Il marxismo ha avuto un’influenza profonda sul movimento operaio inglese, anche se questo ha scelto una via riformista, concentrandosi sul miglioramento delle condizioni all’interno del capitalismo, in parte a causa del miglioramento della vita dovuto all’espansione capitalistica. L’analisi marxista è rimasta uno strumento per capire lo sfruttamento e le crisi. Il concetto leninista di “aristocrazia operaia” spiegava come una parte dei lavoratori potesse essere integrata nel sistema. Il marxismo stesso ha visto diverse interpretazioni e tentativi di rinnovamento nel tempo, con dibattiti su dogmatismo, revisionismo e l’applicazione delle sue teorie in contesti diversi. Pensatori come Korsch hanno criticato le letture troppo rigide, evidenziando la necessità di una critica costante.L’analisi della politica reale mostra che i colpi di stato, azioni militari spesso conservatrici, riescono grazie alla passività dello stato e della popolazione. L’esercito e la burocrazia operano con logiche proprie, e solo movimenti politici attivi possono contrastare tali manovre. Le visioni idealizzate della rivoluzione trascurano le dinamiche sociali ed economiche concrete. La violenza è un concetto complesso e spesso frainteso; le società moderne faticano a discernere tra diverse forme di violenza e a controllarla, con la violenza incontrollata che rappresenta il pericolo maggiore.Le rivoluzioni non seguono schemi fissi e non sono causate da fattori superficiali come la liberalizzazione sessuale o la ribellione culturale. Anche la struttura urbana ha un ruolo complesso e mutevole. Eventi come il Maggio 1968 in Francia mostrano l’imprevedibilità delle rivoluzioni, che possono scoppiare anche in società stabili, ma il loro successo dipende da una complessa interazione di fattori politici e sociali, non da predisposizioni culturali o urbane.Il rivoluzionario moderno è spesso l’intellettuale, spinto dalla percezione che le proprie aspirazioni non possano realizzarsi senza un cambiamento radicale. Questa spinta nasce dalla convinzione che le vie normali siano bloccate e dalla speranza in un’azione decisiva. Le ondate rivoluzionarie legate agli intellettuali riflettono periodi di crisi e trasformazione. Parallelamente, il nazionalismo si afferma come fenomeno politico centrale, una costruzione storica recente dove la lealtà alla nazione prevale, funzionale a creare un corpo nazionale unito all’interno dello stato territoriale moderno.Riassunto Lungo
1. Il Paradosso del Comunismo Occidentale
Le Origini del Comunismo Occidentale
La nascita dei partiti comunisti nel Novecento è legata alla fine della Seconda Internazionale e alla Rivoluzione Bolscevica. La Rivoluzione Russa ha rappresentato un modello di successo e una fonte di ispirazione, spingendo alla creazione di partiti comunisti in tutto il mondo. Questi partiti si sono proposti come la principale forza rivoluzionaria. Nati dall’unione di movimenti nazionali di sinistra e dall’influenza della Rivoluzione d’Ottobre, hanno però incontrato delle difficoltà, specialmente nelle nazioni occidentali dove le condizioni per una rivoluzione non esistevano.La Fedeltà a Mosca e le Contraddizioni Interne
L’entusiasmo iniziale e l’apparente successo del modello Leninista hanno generato una forte fedeltà verso Mosca e il Comintern da parte dei nuovi partiti comunisti. Questa fedeltà ha creato delle complicazioni, perché i partiti comunisti locali dovevano bilanciare le direttive internazionali con le esigenze politiche dei loro paesi. Questo ha spesso causato tensioni interne. Per esempio, il Partito Comunista Inglese, nonostante l’impegno dei suoi membri, non ha mai avuto un grande peso politico. Al contrario, il Partito Comunista Francese è diventato un movimento di massa, ma si è trovato di fronte a una contraddizione fondamentale: essere un partito rivoluzionario in una società che non era pronta alla rivoluzione.Il Paradosso e le Strategie del Comintern
Questo paradosso ha segnato la storia dei partiti comunisti occidentali. Questi partiti, pur essendo dedicati all’internazionalismo e alla rivoluzione, operavano in contesti dove la rivoluzione non era imminente. Il Comintern ha cercato di risolvere questo problema con strategie come quella del Fronte Popolare, con l’obiettivo di unire gli ideali rivoluzionari con azioni politiche concrete in situazioni non rivoluzionarie. La storia dei partiti comunisti occidentali mostra quindi un intreccio complesso di impegno, adattamento e problemi irrisolti. Questa storia evidenzia la sfida costante per i movimenti rivoluzionari quando la rivoluzione non è vicina.Ma è lecito ridurre la complessa storia dei partiti comunisti occidentali a un unico “paradosso”, o tale semplificazione ci impedisce di comprendere le specifiche dinamiche che hanno plasmato ciascun partito nel proprio contesto nazionale?
Il capitolo offre una sintesi utile, ma la nozione di un “paradosso” onnicomprensivo potrebbe oscurare le sfumature cruciali. Per rispondere a questa domanda, è essenziale esplorare le differenze nazionali, studiando le singole storie dei partiti comunisti occidentali. Approfondimenti di storia comparata e studi sui singoli contesti nazionali, con autori specializzati in storia politica comparata, sarebbero illuminanti.2. Le Traiettorie del Comunismo in Occidente
L’Interesse degli Intellettuali per il Comunismo in Occidente
In Occidente, l’interesse degli intellettuali per il comunismo si sviluppa più tardi rispetto alla Russia, dove questo legame esisteva già ai tempi di Marx. Prima della Prima Guerra Mondiale, era raro trovare intellettuali marxisti in Europa occidentale. La società borghese, nonostante i suoi difetti, sembrava funzionare. La situazione cambia con la Prima Guerra Mondiale e la crisi del 1929. Questi eventi portano gli intellettuali ad avvicinarsi al marxismo, soprattutto nella versione di Lenin. In Occidente, la storia degli intellettuali marxisti è legata a quella dei partiti comunisti, che derivano dalla socialdemocrazia e sono i principali rappresentanti del pensiero marxista.Il Difficile Rapporto tra Intellettuali e Partiti Comunisti
Il rapporto tra intellettuali e partiti comunisti non è sempre facile e lineare. In Francia e in Italia, dove i partiti comunisti diventano importanti forze politiche, l’elettorato comunista rimane abbastanza stabile, anche se l’adesione degli intellettuali cambia nel tempo. I partiti comunisti, seguendo il modello sovietico, sono molto rigidi e dogmatici. Questo crea problemi con gli intellettuali, perché limita la libertà di pensiero e impone un modo di pensare ufficiale che cambia spesso. Nonostante queste difficoltà, molti intellettuali, soprattutto negli anni ’30, scelgono di sostenere il comunismo. Lo fanno perché credono in un obiettivo più grande, come la lotta al fascismo, che per loro giustifica l’appoggio al progetto sovietico, anche se questo ha dei lati negativi.Il Successo del PCI e il Fallimento del KPD
Il Partito Comunista Italiano (PCI) è un esempio di successo nel comunismo occidentale, soprattutto se confrontato con la debolezza iniziale durante il fascismo e con il fallimento del Partito Comunista Tedesco (KPD). Dopo un periodo difficile, il PCI diventa il partito più importante della sinistra italiana nel dopoguerra. Questo successo è dovuto alla Resistenza e a una leadership unita. Al contrario, il KPD, che era stato un partito di massa durante la Repubblica di Weimar, non riesce a mantenere la sua forza dopo la guerra e scompare nella Germania Ovest. Il fallimento del KPD ha diverse cause: una strategia politica poco efficace in contesti non rivoluzionari, una leadership instabile e una difficoltà a creare radici profonde tra i lavoratori tedeschi. Il PCI, invece, ha saputo usare l’opposizione alla guerra e creare un ampio fronte antifascista, diventando così la forza principale della sinistra in Italia.È davvero sufficiente attribuire il successo del PCI e il fallimento del KPD unicamente a fattori interni ai partiti e all’adesione o meno alla Resistenza, trascurando le profonde differenze contestuali che hanno plasmato la storia italiana e tedesca?
Il capitolo sembra concentrarsi eccessivamente sulle dinamiche interne dei partiti comunisti e su eventi macrostorici come la Resistenza, rischiando di semplificare eccessivamente un fenomeno complesso. Per comprendere appieno le traiettorie divergenti del PCI e del KPD, è fondamentale considerare le specificità dei contesti nazionali in cui operavano. Approfondire la storia comparata e la sociologia politica, studiando autori come Barrington Moore Jr., potrebbe fornire strumenti analitici più raffinati per cogliere le sfumature di questi percorsi storici.3. Anarchismo e Bolscevismo: Un Dialogo Fallito nella Rivoluzione
Differenze tra Bolscevismo e Anarchismo
Bolscevismo e anarchismo puntano allo stesso obiettivo finale: una società comunista senza classi e senza Stato. Però, hanno idee molto diverse su come raggiungere questo scopo durante la rivoluzione. I bolscevichi, seguendo le idee di Lenin, pensano che sia necessario un periodo di transizione con uno Stato forte guidato dagli operai (la dittatura del proletariato). Questo Stato servirebbe per guidare la rivoluzione e fermare chi è contrario. Gli anarchici, invece, rifiutano qualsiasi forma di Stato e di potere centralizzato. Per loro, la cosa più importante è l’azione spontanea delle persone e decisioni prese a livello locale, non da un centro di potere.Declino dell’Anarchismo dopo la Rivoluzione Russa
Questa differenza di idee ha creato un rapporto complicato tra bolscevichi e anarchici. All’inizio, i bolscevichi consideravano gli anarchici come rivoluzionari che sbagliavano, ma che potevano essere alleati contro i socialdemocratici e il capitalismo. Tuttavia, l’anarchismo si è dimostrato poco organizzato e poco efficace nelle strategie, e per questo motivo è diventato sempre meno importante dopo la Rivoluzione Russa. L’anarchismo è rimasto forte solo in alcuni posti specifici, come la Spagna.La Guerra Civile Spagnola e i Limiti dell’Anarchismo
La guerra civile spagnola ha fatto vedere chiaramente i punti deboli dell’anarchismo come forza politica capace di cambiare le cose su larga scala. Anche se all’inizio gli anarchici avevano molta energia rivoluzionaria e un forte seguito tra i lavoratori spagnoli, non sono riusciti a combattere una guerra moderna né a costruire un sistema politico stabile. La loro idea di puntare tutto sulla spontaneità e di rifiutare un’organizzazione centrale si è dimostrata sbagliata di fronte ai problemi concreti della rivoluzione e di chi voleva fermarla.Rinnovato Interesse per l’Anarchismo
Nonostante l’anarchismo non sia riuscito ad affermarsi come movimento di massa nella storia, oggi c’è un nuovo interesse per le sue idee. Questo succede soprattutto perché il comunismo tradizionale è in crisi e si cercano nuove vie per cambiare la società. Anche se l’anarchismo rimane un pensiero minoritario, offre spunti importanti sulla forza dei movimenti spontanei e sulla critica all’autoritarismo. Questi aspetti sono importanti per capire come funzionano le rivoluzioni oggi.Se si nega il ruolo di fattori culturali e sociali “superficiali” nel causare rivoluzioni, non si rischia di trascurare proprio quelle dinamiche profonde che preparano il terreno per i cambiamenti radicali?
Il capitolo sembra liquidare con troppa facilità l’influenza dei cambiamenti culturali e sociali, quasi fossero irrilevanti “fattori superficiali”. Tuttavia, è proprio l’accumularsi di tensioni sociali, spesso legate a trasformazioni culturali profonde, che può creare un terreno fertile per le rivoluzioni. Negare questa connessione significa forse limitarsi a osservare solo la punta dell’iceberg, perdendo di vista le correnti sotterranee che ne minano la stabilità. Per comprendere meglio questa dinamica, sarebbe utile approfondire gli studi di sociologia culturale e di storia delle mentalità, esplorando autori come Pierre Bourdieu o Michel Foucault, che hanno analizzato il potere trasformativo delle dinamiche culturali e sociali.9. Rivoluzione e Identità nell’Era Moderna
Il Rivoluzionario Moderno
Oggi, la figura tipica del rivoluzionario si identifica con l’intellettuale. Questa categoria professionale si distingue non tanto per il tipo di lavoro mentale svolto, ma soprattutto per la sua specifica posizione nella società. La spinta rivoluzionaria nasce quando gli intellettuali percepiscono che le loro aspirazioni fondamentali non possono essere realizzate senza un cambiamento profondo della società. Questo sentimento si basa sulla convinzione che i modi comuni per migliorare la propria situazione siano bloccati. Allo stesso tempo, c’è la speranza che un’azione forte possa cambiare radicalmente l’ordine esistente.Le Onde Rivoluzionarie nella Storia
Nella storia, ci sono state diverse ondate rivoluzionarie che hanno coinvolto gli intellettuali. Pensiamo, ad esempio, a quelle tra le due guerre mondiali e negli anni ’60. Queste ondate riflettono periodi di crisi e grandi cambiamenti sociali. Tuttavia, le cause e il contesto di queste ondate cambiano nel tempo. In passato, la povertà economica era una delle principali cause delle rivoluzioni. Oggi, nei paesi industrializzati, la critica si concentra di più sui problemi interni delle società capitalistiche ricche.Il Nazionalismo nell’Era Moderna
Accanto a queste dinamiche rivoluzionarie, il nazionalismo si afferma come un fenomeno politico centrale del nostro tempo. Il nazionalismo è una creazione storica recente, in cui la fedeltà alla propria nazione diventa più importante di ogni altro legame. Lo stato-nazione è l’espressione politica di questa identità collettiva. Questa identità nazionale viene spesso costruita attraverso simboli e storie che richiamano un passato idealizzato. L’identità nazionale è utile allo stato moderno perché crea un senso di unità e fornisce la motivazione necessaria per il suo funzionamento. Anche se il nazionalismo si trasforma nel tempo, mantiene la sua funzione di unire un popolo all’interno di uno stato, in un contesto di continui cambiamenti sociali e politici.Ma è sempre l’intellettuale la figura cardine della rivoluzione, o questa visione rischia di essere eccessivamente autoreferenziale, limitandosi a considerare solo una parte della società?
Il capitolo sembra identificare in modo quasi esclusivo la spinta rivoluzionaria con la frustrazione degli intellettuali, trascurando il ruolo di altre categorie sociali e le diverse forme che la rivoluzione può assumere. Per comprendere appieno le dinamiche rivoluzionarie, sarebbe utile esplorare in modo più approfondito le teorie sociologiche sulle classi sociali e il mutamento sociale, magari approfondendo autori come Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca, che hanno analizzato le élite e le dinamiche del potere in modo critico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]