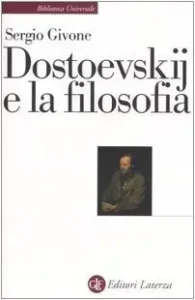Contenuti del libro
Informazioni
“I presocratici. Ritorno alle origini” di Sergio Givone ti porta in un viaggio affascinante alle radici del pensiero occidentale, nell’antica Grecia, tra città come Mileto ed Elea. Non è solo una storia di filosofi come Anassimandro, Parmenide o i Sofisti, ma un’immersione nel loro modo unico di vedere il mondo. Scoprirai come cercavano l’archè, il principio di tutto, spesso legando il destino dell’anima al grande progetto del cosmo, un’idea che ritroviamo persino in antichi testi orfici. Il libro esplora il passaggio cruciale dal mythos al logos, mostrando come questi pensatori non abbandonassero i miti, ma li interpretassero con la ragione per svelare la verità sull’essere e sull’esistenza. Vedrai il debito dell’esistenza secondo Anassimandro, l’eterno essere di Parmenide rivelato da una Dea, e come i Sofisti abbiano spostato l’attenzione sulla persuasione umana. È un percorso che mostra la profondità e la rilevanza ancora oggi di queste origini della filosofia greca, un vero ritorno a domande fondamentali sulla realtà, la conoscenza e il nostro posto nell’universo.Riassunto Breve
Il pensiero antico, come rivelato da testi come il papiro di Derveni, lega strettamente l’ordine del cosmo e il destino dell’anima individuale. Una visione orfica identifica Zeus come principio e fine di tutto, governando la creazione e portando armonia. Questa prospettiva unisce cosmologia, escatologia e soteriologia, vedendo mondo e anima interconnessi. Questo approccio si distingue da quello di Aristotele, che separa nettamente fisica, etica e metafisica, cercando il principio nell’essere stesso piuttosto che nel mito. I primi filosofi greci, i presocratici, pur usando il logos per cercare il principio delle cose, mantengono spesso un legame tra questo principio cosmico e la vita umana o il destino dell’anima. Anassimandro vede l’infinito come origine e fine, con l’esistenza come un debito da pagare con la morte, un processo necessario governato dalla giustizia. L’essere è ciò che deve essere, non solo per necessità, ma perché i viventi cercano di riscattare l’ingiustizia della loro separazione dall’infinito. Parmenide identifica il logos con la struttura stessa dell’essere, eterno e identico a sé, vincolato dalla necessità e rivelato dalla verità stessa, vista come una dea. Pensare è lo stesso che essere; l’essere è primario e luminoso. La verità si manifesta nel logos, e anche l’esperienza dei mortali, inclusa l’errore, è raccolta nell’essere. Eraclito, pur concentrandosi sul divenire, parla di un fuoco semprevivente come principio eterno che unisce gli opposti. Il passaggio dal mito al logos nel pensiero greco è un processo complesso, non sempre una rottura netta. Alcuni lo vedono come un autosviluppo del logos all’interno del mito, altri come un lavoro del logos sul mito che libera la libertà, altri ancora come una progressione lineare. Il cosmo dei primi pensatori è spesso visto come perfetto e divino, diverso dall’universo fisico della scienza moderna. La natura (physis) è una sorgente da cui si è parte, non un oggetto esterno. I sofisti, come Protagora e Gorgia, rappresentano un cambiamento significativo. Non cercano un disvelamento assoluto del vero. Protagora afferma che l’uomo è misura di tutte le cose, spostando la verità sul piano relativo e antropomorfico. Gorgia spinge questa idea all’estremo, sostenendo che nulla esiste o non è conoscibile/comunicabile. In questo contesto, la verità oggettiva scompare o si dissolve nelle opinioni, e ciò che conta è la capacità di convincere, la persuasione (peithò). La verità non è un oggetto da possedere, ma un’esperienza che si manifesta nell’assenza o contraddizione, trovando forza nella capacità di suscitare convincimento. Figure come Anassimandro, Pitagora, Senofane, Eraclito, Parmenide, Empedocle, Democrito, Protagora e Gorgia segnano tappe diverse in questa esplorazione del principio cosmico, della natura della realtà e del destino umano, confrontandosi con concetti come Moira, Dike, Necessità, Verità e Persuasione.Riassunto Lungo
1. Il Principio Cosmico e il Destino dell’Anima
Il papiro di Derveni, scoperto in una tomba antica, svela una visione del mondo dove il destino dell’anima è profondamente legato al disegno dell’universo. Questo testo, di origine orfica, contiene un inno a Zeus che lo identifica come l’origine e la meta di ogni essere. Zeus guida la creazione, portando ordine dal caos iniziale e permettendo a ogni cosa di raggiungere la sua piena realizzazione. Tutti gli esseri si uniscono a lui, riconoscendo la sua legge e la sua natura divina. Questo processo creativo, fatto di azioni potenti, costruisce un mondo ordinato e armonioso. Questa idea unisce lo studio del cosmo (la cosmologia) con la visione del destino ultimo (l’escatologia) e la dottrina della salvezza (la soteriologia). Il destino dell’universo e quello della singola anima sono visti come profondamente connessi tra loro.Un confronto con Aristotele
Questa visione si distingue nettamente dal pensiero di Aristotele. Per Aristotele, la fisica, che si occupa del cosmo, è separata dall’etica, che riguarda l’anima, e dalla metafisica. La metafisica, secondo lui, è la scienza dell’essere in sé. Il principio fondamentale (archè) si trova nell’essere stesso, non nel mito o nelle figure divine. Inoltre, Aristotele considera il mito di scarsa importanza per l’indagine filosofica. Questa separazione tra i diversi ambiti del sapere è un punto fondamentale che lo differenzia da altre correnti di pensiero.I primi filosofi e il legame con il mito
Anche i primi filosofi greci, chiamati presocratici, cercavano il principio delle cose usando la ragione (logos). Tuttavia, spesso mantenevano un forte legame tra questo principio cosmico e la vita umana o il destino dell’anima. Anassimandro, per esempio, vedeva l’infinito come l’origine e la fine di tutto, con l’esistenza che sembra un debito da pagare con la morte. Parmenide identificava il logos con la struttura stessa dell’essere e del pensiero, trovando nella verità un ordine che dava un posto all’individuo. Pitagora legava il logos alla matematica, vista come una scienza sacra e spirituale. Il pensiero di quest’epoca usava il logos per interpretare il mito, non per abbandonarlo. Il mito era considerato il custode del segreto del principio e offriva un parallelismo tra l’anima individuale e l’anima del mondo. Questa connessione tra la visione del cosmo e le idee sulla salvezza è essenziale per capire questi pensatori, che indagavano il mistero della vita e della morte partendo dall’inizio per comprendere la fine.Una tradizione che continua
Questa linea di pensiero, che unisce la ricerca del principio cosmico alla comprensione del destino umano attraverso l’interpretazione del mito, ha continuato a influenzare la filosofia. Secoli dopo, filosofi come Plotino hanno ripreso questa idea. Plotino vedeva la filosofia come un modo per interpretare il mito e come un percorso dell’anima verso l’Uno, ponendosi in contrasto con la metafisica di stampo aristotelico. Anche Eraclito, prima di Plotino, legava la filosofia alla divinazione e all’interpretazione del mito. Questa tradizione rappresenta una parte significativa del pensiero filosofico greco antico.Ma è davvero una singola “tradizione” quella che il capitolo descrive, o si tratta di correnti di pensiero ben distinte, accomunate solo dal contrasto con Aristotele?
Il capitolo raggruppa sotto un’unica etichetta figure e movimenti che coprono secoli di storia del pensiero, dall’Orfismo arcaico ai Presocratici, fino al Neoplatonismo di Plotino. Le differenze dottrinali tra questi pensatori, sia sulla natura del principio cosmico che sul destino dell’anima, sono notevoli. Definirli una singola “tradizione” rischia di appiattire le specificità e le evoluzioni interne. Per comprendere meglio queste distinzioni e valutare la reale continuità (o discontinuità) tra queste correnti, è utile approfondire la storia della filosofia antica studiando specificamente i Presocratici, l’Orfismo e il Neoplatonismo. La lettura di autori che hanno analizzato in dettaglio questi periodi può fornire il contesto necessario.2. Navigando tra Mito e Logos
Dalle profondità del mondo antico emergono frammenti che testimoniano la sua storia. Esplorare queste origini del pensiero è un viaggio, simile a una navigazione. Questo percorso richiede sia di andare verso i testi antichi per comprenderli, sia di sostare presso di essi per riflettere. Non è un semplice ritorno al passato, ma un movimento continuo che integra il viaggio di andata e quello di ritorno, per capire come il pensiero si è formato.Tornare alle Origini del Pensiero: il Caso di Parmenide
L’idea di un “ritorno a Parmenide” è stata proposta come un modo per rifondare la metafisica. Per Gustavo Bontadini, questo ritorno significa riportare il pensiero al principio fondamentale di identità e non contraddizione. Confrontandosi con il pensiero cristiano e la modernità, Bontadini mira a costruire una metafisica basata sulla libertà. Emanuele Severino, invece, vede nel ritorno a Parmenide la ricerca di una verità stabile e definitiva. Tuttavia, per Severino, lo stesso principio d’identità contiene un’ambiguità che spinge il pensiero ad andare oltre, verso ciò che è eterno.
Il Passaggio Cruciale: Dal Mito alla Ragione
Un movimento fondamentale nella storia del pensiero occidentale è il passaggio dal mito al logos, ovvero dalla narrazione tradizionale alla ragione. Wilhelm Nestle descrive questo come uno sviluppo della ragione che nasce dal mito stesso, all’interno dello stesso contesto culturale. Secondo Nestle, razionalità e narrazione mitica possono coesistere. Hans Blumenberg interpreta questo passaggio come un atto di autoaffermazione del logos. La ragione lavora sul mito, liberando l’uomo e il pensiero, in un processo che demitizza il mondo per poi dargli nuovi significati. Jean-Pierre Vernant, invece, vede questo come una progressione più lineare, dove la ragione prende il sopravvento e il mito diventa secondario.
La nascita del pensiero razionale in Occidente, secondo Vernant, ha caratteristiche precise. Si distingue dalla religione, proponendo l’idea di un ordine cosmico basato su una legge interna al mondo (nomos) e non sulla volontà divina. Inoltre, introduce una concezione geometrica dello spazio.
Cosmo e Natura: Visioni a Confronto
È importante notare che il cosmo dei primi pensatori greci, come Talete o Pitagora, era visto come perfetto e divino. Era l’oggetto della cosmologia, lo studio dell’ordine universale, molto diverso dall’universo fisico e imperfetto studiato dalla scienza moderna. Allo stesso modo, la natura (physis) per gli antichi non era un oggetto esterno da studiare e manipolare. Era piuttosto una sorgente vitale di cui l’uomo si sentiva parte integrante, in contrasto con la visione moderna che la considera un oggetto di analisi scientifica e intervento.
Aristotele collegò strettamente la physis, la natura, all’ousia, l’essenza delle cose. Definì così la filosofia come studio dell’essere. Questo porta naturalmente a chiedersi se esista un’altra forma di filosofia, una che indaghi ciò che si trova “al di sopra dell’essere”, come hanno cercato di fare filosofi come Platone e i Neoplatonici.
Ma è davvero un “ritorno a Parmenide” la via maestra per rifondare la metafisica, o non è piuttosto un salto nel passato che ignora secoli di pensiero?
Il capitolo introduce l’idea di un “ritorno a Parmenide” come fondamento per la metafisica, ma non chiarisce sufficientemente perché proprio questo pensatore antico dovrebbe offrire le basi per una disciplina moderna, né affronta a fondo le sfide poste da un simile recupero. Per comprendere meglio la questione, sarebbe utile approfondire direttamente i frammenti di Parmenide, studiare le diverse interpretazioni che ne sono state date nel corso della storia della filosofia e confrontarsi con le opere dei pensatori che propongono questo ritorno, come Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino, per valutarne la giustificazione e la fattibilità.3. Il Debito dell’Esistenza
Secondo Anassimandro, tutto ciò che esiste, come uomini, animali e cose, nasce dall’infinito e alla fine ritorna in esso. Durante la loro esistenza, queste cose che esistono (“gli essenti”) pagano una sorta di debito e subiscono le conseguenze di un’ingiustizia, seguendo le regole del tempo stabilite dall’ordine cosmico. Per Anassimandro, la vita di queste cose è un dato di fatto semplice e temporaneo: esse semplicemente esistono per un periodo limitato, ma prima non c’erano e poi non ci saranno più, riassorbite nell’infinito da cui provengono. A differenza di altri pensatori come Talete o Anassimene, che consideravano i principi (acqua, aria) come cause attive con aspetti sia fisici che divini, Anassimandro vede l’infinito (“l’apeiron”) come un semplice stato di cose fondamentale, non una causa sostanziale che agisce in modo tradizionale.L’Infinito e le Cose che Esistono
L’infinito, l’apeiron, non è l’essere nel senso tradizionale, ma piuttosto il non-essere, una condizione illimitata e indefinita. Le cose che esistono, gli essenti, non sono l’infinito; al contrario, sono ciò che l’infinito non è. La loro stessa esistenza è definita proprio per il fatto che si differenziano nettamente dall’infinito, quasi come se fossero determinate per contrasto o per “negazione” di esso. Mentre l’essere è definito e limitato, l’apeiron è per sua natura privo di limiti e definizioni. Questo le rende finite e temporanee, destinate a ritornare nella condizione illimitata da cui sono emerse.
Nascere e Morire: Un Debito da Pagare
Il fatto che le cose nascano e poi si dissolvano è visto come un modo per pagare quello che devono al non-essere, alla condizione infinita da cui provengono. Devono restituire all’infinito da cui si sono staccate ciò che gli è stato tolto con la loro stessa esistenza limitata. Questa restituzione non è casuale né arbitraria, ma avviene per una sorta di necessità profonda, voluta da una giustizia cosmica che regola l’equilibrio universale. In questa visione, nascere, emergendo dall’infinito, è quasi una colpa o un errore iniziale, un distacco che deve essere riparato, o “espiato”, con il ritorno finale nell’infinito attraverso la morte. È un ciclo inevitabile imposto dalla natura stessa delle cose.
La Forza della Necessità e della Giustizia
Questa necessità non è solo una legge fisica che regola i fenomeni naturali, ma sembra derivare da un principio più alto, qualcosa che va oltre il mondo visibile, quasi un comando o un decreto che viene direttamente dall’infinito stesso. Le cose esistono perché devono esistere, ma non solo in senso obbligatorio o meccanico; i viventi sembrano sentire un bisogno intrinseco di essere, di manifestarsi. Cercano in qualche modo di rimediare all’ingiustizia della loro condizione separata dall’infinito, provando a tornare in armonia con la totalità da cui si sono allontanati. Questo allontanamento iniziale dall’infinito è visto come un atto di forza o di ostilità, una sorta di violenza o inimicizia originaria, un debito pesante che gli esseri mortali ripagano inevitabilmente con la loro morte.
Risonanze in Filosofie Successive
Anche in filosofi venuti dopo, come Democrito, che spiegava il mondo con il movimento casuale degli atomi (il “caso”, tychein), e Lucrezio, che vedeva l’universo come un insieme di particelle in un vortice senza un vero scopo o fondamento, si ritrova un’idea simile a quella di Anassimandro. Persiste l’idea che l’esistenza stessa, pur spiegata in modi diversi e senza ricorrere a divinità, sembra avere una sorta di “difetto” o una mancanza di una ragione ultima profonda che le cose devono semplicemente accettare e sopportare. Anche quando si cerca di spiegare il mondo in modo scientifico e razionale, senza ricorrere ai miti tradizionali (una “cosmologia demitizzata”), sembra che riemergano concetti che ricordano le storie antiche e l’idea che qualcosa debba essere “pagato” o “riparato” a causa dell’esistenza stessa. Questa persistenza suggerisce che l’idea di un’esistenza temporanea e imperfetta, legata a un qualche tipo di debito o mancanza, sia un tema ricorrente nel pensiero antico. Queste filosofie, pur distanti nel tempo e nel metodo, sembrano condividere la sensazione di una condizione esistenziale che richiede una forma di accettazione o “espiazione” implicita.
Davvero la storia del pensiero antico si riduce a una sfilata di ‘figure centrali’ isolate?
Il capitolo elenca figure importanti ma non spiega adeguatamente i legami intellettuali, i dibattiti o le reazioni che le hanno connesse. La presunta ‘evoluzione’ non è dimostrata, appare più come una galleria di ritratti isolati. Per comprendere la dinamica del pensiero antico, è cruciale studiare non solo le singole posizioni, ma anche come queste interagivano. Approfondire la storia della filosofia antica, magari leggendo autori come Giovanni Reale o W.K.C. Guthrie, può offrire la prospettiva necessaria per cogliere le reali connessioni e le rotture tra questi pensatori.6. Figure, Forze e Destino nel Pensiero Antico
Il pensiero antico si concentra su figure fondamentali e concetti che definiscono la comprensione del cosmo e dell’esistenza umana. Al centro di questa indagine si trovano i filosofi presocratici, pensatori come Anassimandro, Parmenide, Eraclito, Democrito, Empedocle, Senofane, Pitagora, Talete e Anassimene. Questi filosofi si interrogano sull’origine del mondo, sulla natura della realtà e sul continuo cambiamento che la caratterizza, ponendo le basi per la riflessione filosofica occidentale.I Sofisti e il Focus sull’Uomo
Accanto ai presocratici, emergono figure come i Sofisti, rappresentati da Gorgia e Protagora. Questi pensatori segnano un cambiamento di prospettiva, spostando l’attenzione dalla natura del cosmo alla sfera umana. La loro indagine si concentra sulla retorica come strumento di persuasione, sulla conoscenza umana con i suoi limiti e le sue possibilità, e sulla morale come insieme di convenzioni sociali piuttosto che principi assoluti. Questo passaggio segna un momento cruciale nello sviluppo del pensiero, ponendo le premesse per le successive riflessioni sull’etica e la politica.Forze Primordiali e Principi Cosmici
Il pensiero antico non si limita alla filosofia razionale, ma include anche figure mitologiche e concetti che rappresentano forze primordiali o principi che governano l’universo e le relazioni umane. Figure come Zeus, la divinità suprema, si affiancano a concetti potenti come Moira, che incarna il destino ineluttabile, e Dike, che rappresenta la giustizia cosmica. Altri principi fondamentali includono la Necessità, intesa come la struttura immutabile del reale, Polemos, il conflitto inteso come motore del cambiamento, Eros, la forza dell’amore e dell’unione, Amicizia e Discordia, che regolano le interazioni tra gli esseri e gli elementi.Concetti Astratti e Temi Ricorrenti
All’interno di questo quadro emergono concetti astratti che sono oggetto di dibattito e interpretazione nelle diverse scuole filosofiche. La Verità, la Persuasione e la Saggezza sono esplorate in relazione alla possibilità di conoscere il reale e di comunicare efficacemente. Il confronto tra Giorno e Notte, o Sole e Notte, suggerisce temi legati alla percezione della realtà, alla conoscenza e ai cicli fondamentali che scandiscono l’esistenza cosmica e umana, riflettendo la dualità presente in molti sistemi di pensiero antichi.L’Eredità del Pensiero Antico
Le idee sviluppate dai primi pensatori e le forze concettuali identificate nel mondo antico non si esauriscono con la loro epoca. Pensatori successivi come Platone, Aristotele e Plotino riprendono, criticano e rielaborano questi temi fondamentali, integrandoli nei loro sistemi filosofici complessi. La presenza di riferimenti a filosofi moderni e contemporanei indica come l’influenza di queste idee antiche si estenda fino ai giorni nostri, venendo continuamente reinterpretata attraverso nuove prospettive e dibattiti, dimostrando la persistenza di questioni legate al destino, alla struttura del reale e alla comprensione del cosmo.Il capitolo elenca varie figure e concetti, ma come si relazionano tra loro il pensiero razionale dei filosofi e le forze mitologiche come Moira o Zeus? Non è forse una giustapposizione priva di reale coerenza?
Il capitolo presenta diversi aspetti del pensiero antico, accostando filosofi razionali a figure mitologiche e concetti astratti. Tuttavia, non esplora a sufficienza come questi elementi interagissero, quali tensioni esistessero tra di essi o come fossero percepiti nel loro contesto storico e culturale. Questa mancanza di analisi approfondita può lasciare il lettore con una visione frammentata anziché coerente. Per approfondire la complessa relazione tra mito, religione e filosofia nel mondo antico, è utile studiare i testi originali dei filosofi presocratici e confrontarli con le opere letterarie e religiose dell’epoca. Autori come Vernant o Snell hanno analizzato in modo critico questo passaggio e la persistenza del pensiero mitico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]