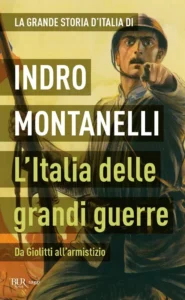1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“I conti con me stesso” di Indro Montanelli ti porta in un viaggio incredibile attraverso l’Italia che cambia, dagli anni ’50 fino alla fine dei ’70. Non è solo storia politica, anche se la politica italiana, con i suoi casini, le crisi di governo, la Democrazia Cristiana, il PCI, il centro-sinistra e il dramma degli anni di piombo e del terrorismo, compreso il rapimento di Aldo Moro, è super centrale. Montanelli, da giornalista pazzesco qual era, ti fa vedere tutto da dentro, raccontando la società italiana che si modernizza, le proteste studentesche, i costumi che cambiano. C’è un sacco di spazio per il mondo del giornalismo, la lotta per la libertà di stampa, le battaglie del Corriere della Sera per restare indipendente. Si parla di Roma, ovviamente, ma anche di Venezia come simbolo di un paese che fa fatica. È come leggere un diario che ti svela i retroscena, i personaggi chiave, le speranze e le delusioni di un’epoca turbolenta, vista con gli occhi critici e un po’ disincantati di uno che c’era in mezzo.Riassunto Breve
Tra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni Settanta, l’Italia attraversa un periodo di profondi cambiamenti e forte instabilità. La politica è segnata da continue tensioni: il Partito Socialista si allontana dai comunisti, la Democrazia Cristiana affronta dibattiti interni e governi deboli e di breve durata si succedono. Si cerca un’apertura a sinistra che porta alla formazione di governi di centro-sinistra, ma la situazione politica rimane fragile. Parallelamente, la società cambia, con nuove spinte modernizzatrici che si scontrano con resistenze conservatrici, come si vede nei dibattiti sulla sessualità o nel rifiuto del matrimonio riparatore. Emergono le prime proteste studentesche, che chiedono riforme universitarie e contestano le gerarchie, radicalizzandosi rapidamente. Il mondo culturale e giornalistico non è immune da queste dinamiche, con competizioni interne e manovre per il controllo. Dalla fine degli anni Sessanta, l’instabilità aumenta: occupazioni, scioperi e scontri diventano frequenti. Si formano gruppi che pensano alla lotta armata e il terrorismo colpisce duramente il paese, con attentati come quello di Piazza Fontana e l’emergere delle Brigate Rosse. Nonostante il caos, vengono approvate leggi importanti che modernizzano la società, come quelle sul divorzio e sul referendum. In questo clima di tensione, si cerca un accordo politico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, il cosiddetto “compromesso storico”, che però incontra forti opposizioni interne, soprattutto nella DC, e viene ostacolato dal terrorismo, culminato nel rapimento e nell’uccisione di Aldo Moro, figura chiave di questo progetto. La situazione economica e la gestione delle grandi aziende statali diventano terreno di scontro politico. Anche il mondo del giornalismo vive una crisi profonda: giornali importanti come il Corriere della Sera affrontano difficoltà economiche e lotte per mantenere l’indipendenza editoriale, minacciata da interessi economici e politici. Si verificano pressioni e tentativi di censura, e la battaglia per un’informazione libera diventa centrale, come dimostra il caso degli articoli su Venezia che denunciano speculazioni. La percezione generale è di un paese in difficoltà, con una classe politica spesso concentrata su interessi di parte e una democrazia che annaspa tra violenza politica, crisi economica e sfide sociali.Riassunto Lungo
1. Svolte politiche e ritratti italiani
Tra la fine del 1957 e l’inizio del 1958, la politica italiana vive momenti di grande cambiamento. Questi sviluppi sono influenzati anche da eventi che accadono fuori dall’Italia. Un esempio importante è la rivoluzione avvenuta in Ungheria nel 1956, che ha effetti soprattutto sui partiti di sinistra. All’interno del Partito Comunista Italiano (PCI), alcuni intellettuali esprimono critiche verso la linea ufficiale del partito, e alcuni decidono di abbandonarlo.Cambiamenti nei partiti
Anche il Partito Socialista Italiano (PSI), guidato da Pietro Nenni, prende le distanze dal PCI. Come segno di questo allontanamento, Nenni restituisce un premio che aveva ricevuto dall’Unione Sovietica. Propone di rompere l’alleanza con i comunisti e di cercare l’unità tra le diverse correnti socialiste. Questa proposta viene accolta con favore da alcuni membri del partito, ma incontra anche resistenze e dibattiti interni.Instabilità di governo e decisioni internazionali
In questo periodo, anche la Democrazia Cristiana (DC) affronta discussioni interne e periodi di crisi che portano a governi di breve durata. Il segretario del partito, Fanfani, propone di aprire il dialogo con i partiti di sinistra, ma questa idea trova forte opposizione all’interno della DC stessa. Si succedono così governi poco stabili, come quello guidato da Adone Zoli, formato solo da ministri della DC. Questo governo ottiene la fiducia in Parlamento anche grazie ai voti del Movimento Sociale Italiano (MSI) e rimane in carica fino al 1958. Parallelamente agli eventi politici interni, l’Italia partecipa attivamente sulla scena internazionale. Nel 1957, l’Italia firma i trattati che danno vita alla Comunità Economica Europea (CEE) e all’Euratom, passi fondamentali per l’integrazione europea. Inoltre, l’Italia accetta di ospitare sul proprio territorio missili nucleari della NATO. Questa decisione è presa anche in risposta al lancio dello Sputnik da parte dell’Unione Sovietica, un evento che segna una fase importante della Guerra Fredda.Riflessioni sulla società italiana
Accanto a questi importanti sviluppi politici e internazionali, emergono osservazioni critiche sulla società italiana del tempo. Chi osserva la vita sociale nota una tendenza alla complicità piuttosto che alla solidarietà tra le persone. Le figure pubbliche e i comportamenti diffusi nella società vengono visti con un certo disincanto e scetticismo. La cultura e i modi di vivere degli italiani sono descritti con uno sguardo critico, mettendo in luce difetti e contraddizioni presenti nel paese.Ma le “riflessioni sulla società italiana” sono davvero solo un corollario o il capitolo omette di indagare il nesso causale con le svolte politiche che descrive?
Il capitolo offre un quadro dettagliato dei mutamenti politici e internazionali di fine anni ’50, ma la sezione dedicata alla società italiana appare quasi come un’appendice, una semplice constatazione di un clima di “complicità” e “disincanto”. Manca un’analisi che colleghi esplicitamente questo stato d’animo sociale alle turbolenze politiche, alle crisi di governo, o all’impatto di decisioni cruciali come l’adesione ai trattati europei o l’installazione dei missili NATO. Per comprendere appieno quel periodo, sarebbe fondamentale esplorare come la società vivesse e reagisse a tali eventi. Approfondire la storia sociale e culturale del dopoguerra italiano, magari leggendo autori come Pasolini o Ginsborg, potrebbe offrire gli strumenti per colmare questa lacuna e capire il legame tra le dinamiche politiche e il sentire comune.2. Un Paese in Transizione tra Vecchio e Nuovo
L’Italia del 1966 vive un periodo di profondi cambiamenti che toccano la politica, la società e la religione. La guida del paese si sposta verso il centro-sinistra, con la Democrazia Cristiana che governa insieme al PSI, mentre un socialdemocratico ricopre la carica di presidente. Anche la Chiesa cattolica si apre al nuovo con il Concilio Vaticano II, un evento che segna una svolta importante, simboleggiata anche dall’abolizione dell’Indice dei libri proibiti.Sfide alle Tradizioni
Questi anni vedono emergere segnali forti di rottura con le convenzioni sociali e morali del passato. Inchieste sulla sessualità giovanile, come quella del giornale studentesco «La Zanzara», o casi giudiziari come la condanna per oscenità della scrittrice Milena Milani, mostrano le tensioni tra le spinte verso la modernità e le reazioni conservative, soprattutto da parte della magistratura. La vicenda di Franca Viola, che rifiuta con coraggio il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita, è un esempio lampante di come le norme sociali tradizionali vengano messe in discussione e sfidate apertamente.Il Fermento Studentesco
In questo clima di trasformazione, nascono le prime significative proteste studentesche. Queste manifestazioni sono alimentate dalla crescita economica che porta più giovani all’università e da un generale senso di insofferenza verso le gerarchie e le istituzioni percepite come superate. Le richieste iniziali si concentrano sull’autogoverno delle università e sulla necessità di riformare i programmi di studio, ma il movimento acquisisce rapidamente una dimensione più ampia e rivoluzionaria, trovando nel frattempo nuovi bersagli esterni, come la guerra in Vietnam.Il Mondo della Cultura e dell’Informazione
Anche nel campo culturale e giornalistico si osservano dinamiche complesse, segnate da ambizione e giochi di potere. La successione di figure influenti crea competizione e le relazioni professionali sono spesso condizionate da favori, ingratitudine e manovre per ottenere il controllo dei giornali. La promozione dei libri diventa un’attività intensa, con gli autori che partecipano attivamente per assicurarsi il successo delle loro opere. Questo scenario rivela un sistema dove persino i premi letterari non sono immuni da influenze esterne.Eventi e Dialoghi Rivelatori
Eventi drammatici come l’alluvione di Firenze mettono in luce aspetti profondi del carattere italiano, mostrando l’orgoglio e l’autosufficienza della popolazione locale nell’affrontare la calamità, un atteggiamento che contrasta con l’attesa di commozione o assistenza dall’esterno. Le conversazioni tra personaggi pubblici offrono ulteriori spunti di riflessione sulla situazione del paese. Si analizzano temi economici, come la competizione industriale americana e le strategie italiane per espandersi sui mercati esteri, e si riflette sulla natura del potere e delle figure politiche. Emerge anche una visione critica del fascismo, descritto non come una tragedia ma come una farsa, basata su aneddoti personali. Vengono toccate anche questioni interne alla Chiesa e la lotta contro la mafia.Descrivere una serie di eventi basta a spiegare la ‘transizione’ di un paese?
Il capitolo elenca in modo efficace una serie di fenomeni che caratterizzano l’Italia del 1966: cambiamenti politici, aperture religiose, sfide sociali, fermento studentesco, dinamiche culturali. Tuttavia, la semplice giustapposizione di questi elementi non chiarisce necessariamente come essi interagiscano tra loro o quale sia il motore profondo della ‘transizione’ descritta. Per comprendere meglio un periodo di cambiamento così complesso, è fondamentale analizzare le cause sottostanti, le interconnessioni tra i diversi ambiti della vita nazionale e le interpretazioni storiografiche che hanno cercato di dare un senso unitario a questi processi. Approfondire la storiografia dell’Italia repubblicana, magari leggendo autori come Paul Ginsborg o Guido Crainz, può offrire gli strumenti per andare oltre la cronaca e addentrarsi nell’analisi delle forze che plasmano una società in evoluzione.3. Turbine Politico e Voci Private
Dopo il 1968, l’Italia visse un periodo di grande agitazione, diverso dalla Francia dove la situazione si stabilizzò più rapidamente. Le scuole e le università furono occupate, ci furono scontri frequenti, scioperi e manifestazioni in tutto il paese. In questo clima di tensione, iniziarono a formarsi gruppi che discutevano l’uso della lotta armata. La situazione divenne drammatica con attentati, come quello di Piazza Fontana nel dicembre 1969, che provocò sedici morti e aumentò il senso di insicurezza generale.Governi Fragili e Tensioni Regionali
Questa instabilità politica portò a profonde divisioni, visibili ad esempio nella scissione del partito socialista. I governi che si succedettero erano deboli e rimanevano in carica per breve tempo, spesso impegnati in riforme che venivano attuate in modo affrettato. Un esempio fu l’istituzione delle Regioni nel 1970; questa riforma era prevista dalla Costituzione ma era stata a lungo ritardata dalla Democrazia Cristiana. La sua attuazione generò ulteriori disordini, spesso legati a interessi locali e a fenomeni di clientelismo, come accadde con i moti di Reggio Calabria e L’Aquila, che misero in luce le tensioni territoriali esistenti.Riforme e Modernizzazione della Società
Nonostante il caos politico e sociale, la società italiana continuò a modernizzarsi e a cambiare profondamente. Furono approvate leggi di grande importanza che segnarono un progresso civile. Tra queste, la legge sul referendum abrogativo e quella sul divorzio permisero ai cittadini di esprimersi su temi cruciali e modificarono la struttura familiare e sociale. La Corte Costituzionale diede l’autorizzazione all’uso della pillola anticoncezionale, riconoscendo una maggiore libertà individuale. Vennero anche introdotte riforme fiscali significative, come l’introduzione dell’IVA e la creazione dell’anagrafe tributaria, che cercarono di rendere il sistema fiscale più equo e trasparente.L’Ombra del Terrorismo e la Vita Quotidiana
In questo contesto turbolento, emergevano nuove figure e termini nel dibattito politico. Il fenomeno del terrorismo divenne sempre più presente; inizialmente attribuito principalmente all’estrema destra, vide poi l’apparizione di gruppi organizzati come le Brigate Rosse, che intensificarono la strategia della lotta armata. In mezzo a questi grandi eventi pubblici, le vite delle persone continuavano, fatte di vicende personali e scambi culturali. Morti di figure note, incontri con intellettuali, artisti e politici si mescolavano a riflessioni private sulla vita, la morte e il ruolo del giornalista. Si discuteva di letteratura, arte, politica e della vita di tutti i giorni, mostrando un’Italia complessa dove la turbolenza della sfera pubblica conviveva con le esperienze individuali e le dinamiche sociali e culturali più intime.Il capitolo non rischia di ridurre la complessità del terrorismo a un mero scontro politico?
Il capitolo lega strettamente il fenomeno terroristico, in particolare l’omicidio Moro, al tentativo di bloccare il compromesso storico. Sebbene questo sia un movente dichiarato da alcuni gruppi, ridurre la complessità degli “Anni di Piombo” a un mero scontro politico rischia di ignorare le radici sociali, ideologiche e culturali profonde che alimentarono il terrorismo, sia di sinistra che di destra. Per cogliere la reale portata di quel periodo, è indispensabile studiare la storia sociale e politica italiana del dopoguerra, le diverse matrici ideologiche e le possibili influenze esterne. Approfondire le opere di storici come Alessandro Silj o Richard Drake può fornire il contesto mancante.7. Manovre Politiche e la Battaglia del Giornale
La situazione politica è segnata da una forte tensione interna alla Democrazia Cristiana. La discussione ruota attorno alla possibilità di un’apertura verso il Partito Comunista Italiano. Un articolo pubblicato su un giornale critica apertamente il Presidente Leone, accusandolo di non voler sciogliere le Camere a causa di presunti ricatti da parte dei comunisti. Questa critica scatena reazioni significative all’interno del partito.L’opposizione interna e il ruolo del giornale
All’interno della DC emerge un gruppo di parlamentari, soprannominato “i Cento”, che si oppone con forza all’idea che il PCI entri a far parte della maggioranza di governo. Questo gruppo trova un importante punto di riferimento e sostegno nel giornale, che diventa la voce della resistenza interna contro questa possibile alleanza. La direzione della DC, pur dichiarandosi contraria a una maggioranza che includa il PCI, adotta una posizione che nei fatti consente una certa collaborazione. Questo avviene attraverso la creazione di un comitato incaricato di controllare l’operato del governo. Questa situazione porta gli oppositori dell’accordo a valutare diverse strategie, inclusa la possibilità di una scissione dal partito per cercare un’alleanza con i partiti laici, in particolare con i liberali.Le sfide economiche del giornale
Parallelamente alle vicende politiche, il giornale si trova ad affrontare serie difficoltà economiche. Perde infatti l’appoggio finanziario di Montedison, un sostegno importante. Questa perdita rende urgente la ricerca di nuove fonti di finanziamento e di pubblicità. Vengono avviati contatti con diverse realtà finanziarie e industriali di rilievo, tra cui la Fiat e la Sipra. Si esplorano anche possibili legami con figure influenti come Gelli, nel tentativo di assicurare la sopravvivenza economica della pubblicazione.L’impatto del rapimento e della morte di Aldo Moro
Il rapimento e la successiva morte di Aldo Moro stravolgono completamente il quadro politico. Il giornale assume una posizione molto decisa e netta: si dichiara fermamente contrario a qualsiasi forma di trattativa con le Brigate Rosse. La figura di Moro viene considerata, dal punto di vista politico, ormai finita. La sua morte, pur suscitando un sentimento di pietà, viene interpretata come un evento che i sostenitori della sua linea politica potrebbero cercare di sfruttare a proprio vantaggio. Questa tragedia influenza profondamente gli equilibri interni alla Democrazia Cristiana, spingendo i vari schieramenti a riposizionarsi e a cercare nuove alleanze nel tentativo di consolidare o modificare i rapporti di forza.Elezioni e prospettive future
I risultati delle elezioni amministrative parziali che si tengono in questo periodo mostrano cambiamenti significativi nel panorama politico. La Democrazia Cristiana registra un rafforzamento della sua posizione, mentre il Partito Comunista Italiano subisce un calo notevole nei consensi. I socialisti, invece, vedono aumentare il proprio peso elettorale. Sul fronte economico del giornale, un importante accordo pubblicitario raggiunto con Sipra garantisce una base finanziaria solida per il futuro immediato. Nonostante questi sviluppi, la lotta politica interna alla DC prosegue senza sosta, con diverse ipotesi di alleanze e di leadership che continuano a confrontarsi per definire la direzione futura del partito e del paese.Come si può analizzare la “battaglia del giornale” se non si chiarisce quale giornale fosse, e chi lo manovrava?
Il capitolo, pur descrivendo il giornale come un attore centrale nelle manovre politiche e nel sostegno all’opposizione interna alla DC, omette di specificare quale fosse questa pubblicazione. Questa lacuna contestuale rende difficile valutare appieno la sua influenza, la sua linea editoriale e il peso delle sue difficoltà economiche o della sua posizione sul caso Moro. Per colmare questa mancanza e comprendere il ruolo della stampa nella politica italiana di quegli anni, è fondamentale approfondire la storia del giornalismo e i suoi legami con il potere economico e politico. Utili per questo scopo possono essere gli studi di storici come Giorgio Galli o Paul Ginsborg.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]