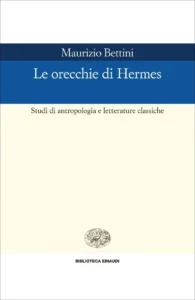1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
è un libro che ti prende e ti fa pensare un sacco su questa fissa che abbiamo oggi per l’identità, che sia quella nazionale, culturale o regionale. Bettini scava a fondo e ti mostra che questa “suridentitaria” è un po’ un’ossessione pericolosa, legata a una voglia assurda di “purezza” e a una paura matta dell'”alterità”, cioè di chi è diverso da noi. Ti spiega che la parola stessa “identità” ha origini religiose e che spesso la difendiamo come se fosse una cosa sacra da non “contaminare”. Questo porta a vedere chi è “fuori posto”, come gli immigrati o i Rom, con “schifo” e a usare stereotipi, alimentando paure tipo la “Grande Sostituzione”. Il libro ti fa capire che l’identità non è una cosa solida o pura, ma un’ombra che trattiamo come fosse una roccia, e che chiudersi in confini rigidi per paura dello straniero è contro la natura stessa del cambiamento, che nasce invece dalla mescolanza e dall’accettare il “disordine”. È un invito a guardare oltre il “furore identitario” e a capire che la vera ricchezza sta nell’incontro, non nella purezza.Riassunto Breve
La discussione culturale di oggi si concentra molto sull’identità, che si manifesta in forme diverse come quella nazionale o culturale. Questa attenzione eccessiva, definita “suridentitaria”, preoccupa perché l’affermazione identitaria ha spesso portato a violenze. Nonostante le critiche, il dibattito continua, a volte trascurando altre questioni. La parola “identità” deriva dal latino “identitas”, usata dai teologi cristiani per indicare la “stessità” divina, non un concetto filosofico sull’individuo. Insieme a “identitas”, crearono “alteritas”, l’opposto. L’identità si definisce in contrasto con l'”Altro”, e l’incontro con l’alterità porta all'”alterazione”. Il linguaggio lega alterazione e “adulterio”, che significa unione con un “altro”, storicamente visto come perdita di purezza. Questo suggerisce che la paura dell’alterità è legata a un desiderio di “purezza”. Quando un elemento “altro” entra nella sfera identitaria, come un cibo diverso, si reagisce rivendicando la purezza culturale. La difesa dell’identità è legata all’ideale implicito della sua purezza, vista come un confine da proteggere dalla contaminazione dell’Altro.L’identità si lega alla purezza, e il contatto con l’altro produce alterazione e adulterazione. Purezza e contaminazione rimandano alla sacralità. Parole latine come *purus* e *contaminare* hanno origini religiose. *Purus* è la purezza rituale, *contaminare* è toccare il sacro con mani profane. Identità, purezza e sacralità formano una catena che si vede in eventi storici come la pulizia etnica o movimenti nazionalisti religiosi. L’immigrazione crea difficoltà, ma le società si sviluppano con la mescolanza. L’Italia ha una tradizione di accoglienza. La rappresentazione dell’immigrazione come attacco è una deformazione. Il rifiuto degli immigrati non dipende solo da problemi sociali, ma da un sentimento di “schifo”, di ripulsa verso l’impuro. L’immigrazione è percepita come inquinamento della purezza originaria. L’identità richiede pulizia, e l’immigrazione è vista come profanazione perché tocca l’identità sacra con impurità. La fondazione di Roma, basata sull’accoglienza e la mescolanza, contraddice l’idea di un’identità chiusa.L’identità viene presentata come sacra, un baluardo. Questa sacralizzazione si vede in comportamenti politici che usano simboli religiosi per dare autorità, trasformando la fede in uno strumento di conflitto identitario. L’idea di un’identità sacra suggerisce che funzioni come una religione, una “religione dell’identità” esclusiva, simile ai monoteismi, che divide in “noi” e “loro”. Questa struttura binaria porta a contrapporsi all'”altro”. L’identità è contro il relativismo. Tuttavia, l’identità non cerca di convertire, ma ha bisogno che le identità “altre” esistano per definirsi per contrasto. Questo la rende simile a un politeismo: un monoteismo esclusivo che esige l’esistenza di altre identità, ma senza curiosità per esse. Questa visione porta a categorizzare gli altri con stereotipi, definendoli per ciò che si ritiene manchi loro. Questo impedisce di vedere le differenze individuali e riduce le persone a prototipi, potendo sfociare nel razzismo. La visione identitaria oscura la realtà, imprigionando in un perimetro ristretto e illusorio, trasformando i confini in muri.L’identità, sia nazionale che culturale, non ha parametri oggettivi di purezza, a differenza delle sostanze fisiche. Preoccuparsi della sua purezza è assurdo. Parlare di purezza o radici usa metafore che le danno una solidità che non ha, facendola sembrare un oggetto concreto. Questa strategia rende l’identità impalpabile ma con consistenza irreale, facendola rientrare nell’ordine della natura o della storia. Etichettare elementi culturali come “identitari” crea blocchi esclusivi che generano opposizione. La “crisi di identità” nasce per descrivere il conflitto delle minoranze, ma oggi sono le maggioranze a sentirsi minacciate dalle minoranze. È necessario mantenere distanza tra il concetto astratto di identità e i fenomeni culturali concreti per evitare che la convivenza si rovesci in conflitti.Il fastidio verso gli immigrati, a volte “schifo”, nasce dalla percezione di “sporcizia” o “impurità”, non da contatto fisico, ma da un’idea di disordine. Lo sporco è ciò che è “fuori posto” rispetto alle categorie culturali. Eliminare lo sporco ripristina l’ordine. Questa logica spiega il rigetto verso chi è percepito “fuori posto”, come immigrati o persone LGBTQ+. Per chi ha visioni sovraniste, lo “schifo” porta a “fare ordine” e stabilire “confini” sacri. Chiudere le frontiere elimina lo “sporco”. Il rimpatrio “rimette a posto” l’intruso, ristabilendo l’ordine nel paese di arrivo e idealmente in quello di origine. L’idea di “aiutarli a casa loro” si inserisce qui. Il caso dei Rom evidenzia questa dinamica: percepiti come stranieri e “fuori posto” anche se cittadini, con alta ostilità e tentativi di schedatura che richiamano persecuzioni storiche. Miti e teorie superate li stigmatizzano. La loro storia di vita ai margini e di attraversamento dei confini contraddice l’ossessione per la delimitazione di chi cerca di “mettere ordine”.L’Italia riceve molti più turisti che immigrati residenti, ma i turisti non suscitano la stessa repulsione. La differenza sta in come sono visti: i turisti sono visitatori di passaggio (*peregrini*), gli immigrati residenti permanenti (*incolae*) che frequentano gli stessi luoghi. La ragione principale della diversa reazione è la gerarchia sociale. I turisti sono visti come pari o superiori, associati a benessere. Gli immigrati sono percepiti come subordinati, dipendenti. Questa percezione di inferiorità li rende “fuori posto” e fonte di “contaminazione” per l’identità nazionale. Questa paura è un “panico identitario”, reazione esagerata verso gruppi visti come minaccia culturale, spesso alimentata dai media. Esempi storici mostrano paura della contaminazione verso gruppi marginali o di basso status. Un caso di cronaca dimostra come l’attribuzione di un reato cambi la reazione pubblica a seconda dello status sociale. Manifestazioni estreme includono la teoria della “Grande Sostituzione”, che sostiene un complotto per rimpiazzare popolazioni europee con immigrati, distorcendo fatti per creare paura.Teorie come la “Grande Sostituzione” si diffondono come dicerie, amplificate da figure pubbliche e social media. La loro forza deriva dalla difficoltà di comprendere fenomeni complessi come le migrazioni. È più semplice individuare una causa unica o “colpevoli” con intenzioni chiare. Questo modo di pensare è influenzato dalla cultura contemporanea, piena di storie con schemi (crisi, responsabile, svelamento) applicati a eventi reali per renderli “raccontabili” e comprensibili tramite il complotto. La percezione di immigrati e Rom come “pericolosi” alimenta il panico identitario. Questa paura è simile a come in altre culture i gruppi marginali sono visti come fonti di danno per la loro posizione ambigua e la paura legata alla loro crescita. La consapevolezza della loro presenza necessaria, unita a condizioni inferiori, li rende figure ambivalenti. Questo porta a stereotipare queste minoranze come intrinsecamente problematiche o “arrabbiate”, attribuendo loro comportamenti negativi visti come parte della loro natura, definendoli una spontanea fonte di pericolo.I temi culturali dominanti si manifestano sui corpi. L’abbigliamento rifletteva valori, oggi tende all’informalità. Sotto gli abiti, i tatuaggi sono diffusi. Storicamente marchi negativi o segni di appartenenza, oggi sono strumenti di identità, esteriorizzano il sé e la memoria, rendendo visibili elementi personali. Questo si inserisce nella tendenza a manipolare il corpo, spostando l’attenzione sull’esteriore come luogo dell’identità. I tatuaggi funzionano anche come confine, intensificano la pelle, creando separazione. Le immagini intense possono attrarre o respingere, marcando distanza. Questa funzione di confine corporeo riflette il tema culturale del confine nella società attuale, legato al desiderio di separazione. L’accettazione del “disordine” è fondamentale per il cambiamento culturale e per accogliere elementi “fuori posto” come gli immigrati. Il disordine ha potenza maggiore dell’ordine stabilito, contiene possibilità di nuove combinazioni. La storia mostra che il cambiamento avviene per fasi di disordine. Accogliere gli immigrati richiede accettare il disordine iniziale per arrivare a convivenza e nuove configurazioni. La paura del disordine si contrappone alla comprensione che è condizione per il nuovo.Un’entità è sacra quando è superiore all’esperienza umana normale, tenuta separata. Solo persone specifiche possono gestirla. Esistono due tipi di sacralità: soprannaturale (religioni rivelate) e laica (bandiera, patria), quest’ultima spesso metaforica. Il sacro è ambivalente: aspira a essere riconosciuto intrinsecamente, ma spesso richiede imposizione o forza. Senza coercizione, è sacro solo per chi lo considera tale. Il rispetto per il sacro può portare a comportamenti che superano leggi e costumi, sia positivi (martirio) che negativi (guerre di religione). Il sacro è complesso e rischioso da gestire.Riassunto Lungo
1. L’identità e il desiderio di purezza
L’identità oggi e le sue preoccupazioni
Oggi si parla moltissimo di identità. Questa può essere l’identità di una nazione, di una regione o di un gruppo culturale. A volte, questa attenzione sull’identità diventa eccessiva, quasi esagerata. Questo modo di vedere le cose non si adatta bene alla complessità del mondo di oggi e crea preoccupazione. Nella storia, infatti, quando si è insistito troppo sull’identità di un gruppo, spesso ci sono state violenze. Anche se molte critiche dicono che questa idea di identità è debole e pericolosa, se ne continua a parlare molto. Questo dibattito, però, a volte ci fa dimenticare altri problemi importanti del nostro tempo.L’origine della parola ‘identità’
La parola “identità” viene dal latino “identitas”. Questo termine non è nato nella filosofia antica per parlare delle persone o delle culture. Sono stati i teologi cristiani nel quarto secolo a inventarlo. Lo usavano per dire che Dio era “sempre lo stesso”, per indicare la sua “stessità”. Questo ci fa capire che all’inizio la parola aveva un legame forte con il mondo del sacro, non con l’idea di chi siamo noi come persone o come gruppo sociale.L’incontro con l”Altro’: l’alterità
Insieme a “identitas”, i teologi hanno creato anche la parola “alteritas”. Questa è l’idea opposta e viene dal latino “alter”, che significa “altro”. L’identità, quindi, si capisce solo mettendola a confronto con l’alterità, cioè con ciò che è “altro”. Oggi, l'”Altro” può essere rappresentato da culture diverse, popoli lontani o usanze che non sono le nostre. Quando la nostra identità incontra l’alterità, la nostra identità stessa cambia, si “altera”.Alterazione, purezza e la paura della mescolanza
Il linguaggio ci mostra un legame profondo tra l’idea di “alterazione” e la parola “adulterio”. Quest’ultima deriva da “ad” e “alter”, e significa unirsi a un “altro” (in questo caso, una persona diversa dal proprio partner). Nella storia, l’adulterio era visto come una perdita di purezza, come una “contaminazione”. Questo ci fa pensare che la paura di ciò che è “altro” e la paura di mescolarsi siano legate a un forte desiderio di mantenere una specie di “purezza”.Un esempio concreto: il tortellino
Quando qualcosa percepito come “altro” entra nel nostro mondo, nella nostra identità, questo desiderio di purezza diventa evidente. Pensiamo all’esempio di un tortellino. Se si propone di cambiare il ripieno tradizionale di maiale con il pollo per includere chi non mangia maiale, scatta subito una reazione. Questa reazione difende la “purezza” dell’identità culturale legata a quella ricetta. Questo esempio fa capire che difendere l’identità, in qualsiasi forma, è sempre collegato all’idea, spesso non detta, di volerla mantenere “pura”. L’identità viene vista come un confine da proteggere per non far entrare l'”Altro”, la cui presenza è sentita come una minaccia o una “contaminazione”.Davvero l’etimologia di un termine teologico del IV secolo basta a spiegare le complesse e spesso violente dinamiche identitarie del mondo contemporaneo?
Il capitolo offre un interessante spunto etimologico, collegando l’origine della parola “identità” a un contesto teologico antico. Tuttavia, basare l’analisi delle problematiche identitarie attuali quasi esclusivamente su questa radice linguistica sembra un salto logico non del tutto giustificato. Il capitolo non chiarisce come il concetto di identità, nato per descrivere la “stessità” divina, si sia trasformato nel corso dei secoli fino ad assumere il significato sociale, culturale e politico che ha oggi, né esplora i molteplici fattori storici, sociali e psicologici che hanno plasmato questa evoluzione. Per colmare questa lacuna, sarebbe fondamentale approfondire la storia del pensiero politico e sociale, la sociologia dell’identità e la psicologia dello sviluppo. Autori come Michel Foucault, Pierre Bourdieu o Charles Taylor offrono prospettive più articolate su come l’identità si costruisce e si negozia nel contesto sociale e storico, andando oltre la pur affascinante radice etimologica.2. Identità, Purezza e Sporcizia
Esiste un legame profondo tra l’idea di identità e la nozione di purezza. Quando un’identità entra in contatto con ciò che è diverso da sé, si teme che possa subire un’alterazione o addirittura un’adulterazione. Questo ambito della purezza e del suo opposto, la contaminazione, richiama concetti legati alla sfera del sacro. Le parole che usiamo per descrivere questi stati, come le parole latine purus e contaminare, hanno origini strettamente connesse a pratiche religiose e rituali. Purus non indicava solo pulizia fisica, ma soprattutto purezza rituale, uno stato necessario per gli oggetti destinati al culto o per chi si accostava al sacro.Le Radici del Concetto: Purezza e Sacralità Contaminare, d’altra parte, significava originariamente toccare qualcosa di sacro con mani non purificate o profane, rendendolo insozzato o impuro. Questo mostra come, fin dalle epoche antiche, l’identità, la purezza e la sacralità fossero percepite come elementi strettamente collegati, quasi a formare una catena inscindibile. L’idea che l’identità debba rimanere pura per conservare la sua essenza sacra è un concetto potente che ha influenzato profondamente il pensiero umano. Questa connessione suggerisce che ogni “tocco” dall’esterno, da ciò che è “altro”, può essere visto non solo come un’alterazione, ma come una vera e propria profanazione. La purezza dell’identità diventa così un valore da difendere a ogni costo, spesso con implicazioni che vanno oltre la semplice appartenenza culturale o sociale.Identità, Altrove e Rifiuto Questa catena concettuale tra identità, purezza e sacralità si manifesta in modo potente in vari eventi storici e fenomeni sociali. Possiamo vederla all’opera nella difesa accanita di un’identità nazionale, a volte accompagnata da azioni estreme come la pulizia etnica, o nei movimenti nazionalisti che fondono l’appartenenza identitaria con un fondamentalismo religioso. L’immigrazione, in particolare, solleva spesso difficoltà significative nella convivenza e nell’integrazione tra persone di origini diverse. Tuttavia, è importante riconoscere che le società umane si sono storicamente sviluppate e arricchite proprio attraverso la mescolanza e lo scambio, non attraverso il mantenimento di una purezza assoluta. Nonostante l’Italia possieda una lunga tradizione di accoglienza e si fondi su principi democratici che promuovono l’inclusione, la rappresentazione mediatica e politica dell’immigrazione tende spesso a dipingerla come una minaccia, un incubo o persino un attacco nemico, deformando la realtà.La Paura della Contaminazione
Il rifiuto che alcune persone provano verso gli immigrati non deriva unicamente da problemi socio-economici o culturali oggettivi, ma è spesso alimentato da un sentimento profondo e viscerale di “schifo”. Questo sentimento è una repulsione istintiva verso ciò che viene percepito come sporco, impuro o contaminante. L’immigrazione, in questa prospettiva emotiva, viene vista come un inquinamento che minaccia la purezza originaria dell’identità collettiva. Se l’identità è percepita come qualcosa di sacro che richiede “pulizia” per mantenersi intatta, allora il contatto con l’immigrato, visto come portatore di impurità o diversità “sporcante”, diventa una vera e propria profanazione. Toccare con ciò che è impuro (l’immigrato) qualcosa che è ritenuto sacro (l’identità della comunità) genera questa forte reazione di ripulsa.Un Modello Diverso: L’Accoglienza Originaria di Roma Un esempio storico che contraddice l’idea di un’identità chiusa e pura che rifiuta l’altro è la narrazione della fondazione stessa di Roma. Secondo il mito, la città fu fondata accogliendo uomini diversi, provenienti da varie regioni e contesti, che si unirono per creare una nuova comunità. Questa origine basata sull’accoglienza e sulla mescolanza di genti diverse suggerisce un modello di identità non monolitica, ma costruita sull’integrazione e sulla diversità. La storia di Roma, in questo senso, offre una prospettiva alternativa potente rispetto alla visione dell’identità come qualcosa di statico, puro e minacciato dal contatto con l’esterno. Mostra come la forza e lo sviluppo possano nascere proprio dall’incontro e dalla fusione di elementi apparentemente eterogenei.Legare la complessa repulsione verso l’immigrazione contemporanea quasi esclusivamente a un retaggio di antichi concetti di purezza rituale non rischia di ignorare le molteplici e ben più concrete cause socio-economiche, politiche e culturali che alimentano tali fenomeni oggi?
Il capitolo, pur illuminando un legame storico affascinante, sembra concentrare l’analisi della repulsione verso l’altro, in particolare l’immigrato, quasi esclusivamente sulla persistenza di antichi concetti di purezza rituale. Questa prospettiva, sebbene valida in parte, rischia di trascurare o minimizzare il peso di fattori socio-economici concreti (come la competizione percepita per lavoro o welfare), dinamiche politiche contemporanee (la strumentalizzazione della paura da parte di movimenti populisti) e la complessa costruzione sociale dell’identità nazionale nel mondo moderno. Per ottenere una comprensione più completa, sarebbe utile integrare l’analisi con gli apporti della sociologia delle migrazioni, della scienza politica (in particolare gli studi sul nazionalismo e il populismo) e della psicologia sociale (sui meccanismi del pregiudizio e dell’identità di gruppo). Autori come Stephen Castles, Benedict Anderson o Gordon Allport possono offrire prospettive complementari.3. La sacralità dell’identità e la prigione degli stereotipi
L’identità è vista come qualcosa di sacro, quasi una difesa per un popolo. Questo aspetto sacro si vede anche nella politica, quando si usano simboli religiosi non per vera fede, ma per dare forza religiosa alle azioni politiche. In questo modo, l’oggetto diventa sacro di per sé, non uno strumento per pregare, e permette di non badare alle contraddizioni tra mostrare fede e come ci si comporta davvero. La religione che entra nella politica è un fatto che si vede in tutto il mondo; trasforma la fede da un sentimento intimo a qualcosa di esterno, usata per creare scontri basati sull’identità.L’identità come religione esclusiva
L’idea che l’identità sia sacra fa pensare che funzioni proprio come una religione. Questa “religione dell’identità” ha una natura che esclude gli altri, un po’ come le religioni che credono in un solo dio. Divide il mondo in un “noi” e un “loro”. Questa divisione netta porta a mettersi contro chi è visto come “diverso”, come gli immigrati, i Rom, o chi non ha gli stessi valori, e proprio perché esclude, l’identità va contro l’idea di considerare i diversi punti di vista (il relativismo).Il bisogno dell’altro
Eppure, l’identità non cerca di convincere gli altri ad adottare la propria cultura o i propri valori. Al contrario, ha bisogno che esistano identità “altre” per potersi definire per differenza. Un’identità esiste solo se è diversa da un’altra. Questo aspetto, che accetta e richiede la presenza di altre identità, la fa sembrare simile a un politeismo. La religione dell’identità è quindi come un monoteismo che esclude gli altri, ma allo stesso tempo ha bisogno che esistano altre identità, senza però mostrare interesse per loro, concentrandosi solo su se stessa.Stereotipi e chiusura mentale
Questa visione basata sull’identità porta a classificare gli altri usando stereotipi e idee preconcette, spesso definendo una persona per quello che si pensa le manchi. Questo impedisce di notare le differenze tra le singole persone e le riduce a semplici esempi di un tipo. Questo modo di fare può creare delle gerarchie e portare al razzismo. Vedere il mondo solo attraverso l’identità nasconde la realtà, un po’ come le ombre nella caverna di Platone: non si riescono a vedere gli altri come persone uniche, ma nemmeno le differenze e le ingiustizie che ci sono dentro il proprio gruppo. Chi si chiude in questa visione identitaria limita la sua capacità di conoscere e capire punti di vista diversi. È come rimanere prigionieri in uno spazio piccolo e falso, dove i confini diventano muri invece che porte aperte verso l’esterno.È davvero utile, o non piuttosto fuorviante, definire l’arrivo di persone come “disordine” per comprendere i processi di cambiamento sociale?
Il capitolo lega il concetto di “disordine” all’evoluzione culturale e all’integrazione degli immigrati. Tuttavia, descrivere l’arrivo di persone in questi termini, pur volendo sottolineare la forza trasformativa del “disordine”, rischia di etichettare l’immigrazione come un fenomeno intrinsecamente caotico prima ancora di considerare i processi di integrazione. Per approfondire questo aspetto, sarebbe utile esaminare le dinamiche migratorie e i percorsi di inclusione da prospettive diverse. Si potrebbero consultare studi di sociologia delle migrazioni o antropologia culturale. Autori come Zygmunt Bauman o Saskia Sassen hanno trattato temi legati alla mobilità e all’integrazione in contesti globali.9. Il Sacro: Distinto, Potente e Ambivalente
Un’entità è definita sacra quando viene considerata superiore all’esperienza umana normale e viene tenuta separata e distinta dal quotidiano. Secondo i credenti, solo a persone specifiche, come sacerdoti o eletti, è permesso gestirla o interagire con essa. Esistono due tipi principali di sacralità. Il primo riguarda entità ritenute appartenenti a un ordine soprannaturale, tipico delle religioni rivelate. In questo caso, la sacralità può essere intrinseca all’oggetto stesso, come una reliquia, o derivare da un rito compiuto da una figura autorizzata, come avviene per l’ostia consacrata. Il secondo tipo si applica a entità che, pur non essendo soprannaturali, hanno un valore sociale così elevato da occupare una posizione eccezionale. Esempi comuni includono la bandiera nazionale o la patria; questa è una forma di sacralità laica e spesso intesa in senso metaforico.Ambivalenza e impatto
Il sacro presenta una sua intrinseca ambivalenza: da un lato aspira a essere riconosciuto come intrinsecamente tale, ma dall’altro la sua accettazione universale richiede spesso l’imposizione di un’autorità o persino l’uso della forza. Senza una forma di coercizione, un’entità è sacra solo per chi la considera tale; ad esempio, l’ostia è sacra per i cristiani ma non per i laici, che la rispettano principalmente perché è sacra per altri. Il rispetto per ciò che è considerato sacro può portare a comportamenti che vanno oltre i normali codici sociali, i costumi e persino le leggi stabilite. Queste azioni possono manifestarsi in forme estreme, sia positive, come il martirio o atti di grande altruismo, sia negative e violente, come nel caso delle guerre di religione. Gestire il concetto e la presenza del sacro nella società è quindi un compito complesso e potenzialmente rischioso.Ma è davvero il “rispetto” per il sacro a condurre direttamente a comportamenti estremi come il martirio o le guerre di religione?
Il capitolo suggerisce un legame diretto tra il rispetto per ciò che è considerato sacro e l’insorgere di azioni che trascendono le norme sociali e legali, arrivando agli estremi. Tuttavia, la dinamica che porta dal mero rispetto o credenza all’azione violenta o auto-sacrificale è estremamente complessa e non può essere ridotta a un semplice rapporto causa-effetto legato alla natura del sacro in sé. Fattori sociali, politici, psicologici e contestuali giocano un ruolo cruciale nel mobilitare le credenze in azioni collettive, spesso violente. Per comprendere meglio questa complessità, è utile approfondire la sociologia delle religioni, la psicologia sociale e la storia, esplorando il pensiero di autori come Émile Durkheim, Max Weber o Mircea Eliade, che hanno analizzato il sacro nel suo contesto sociale e storico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]