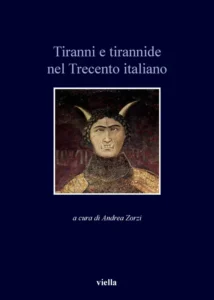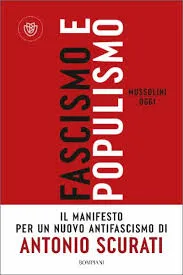1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Guerra e società” di Autori Vari non è il solito libro sulla Resistenza che inizia nel ’43. Ti porta indietro, a capire come l’antifascismo non fosse solo politica, ma una scelta personale, quasi “esistenziale”, che maturava prima del crollo del fascismo. Il libro scava a fondo nel 1943, un anno pazzesco per l’Italia, tra i bombardamenti, la crisi del regime e gli scioperi operai che mostravano quanto la gente fosse stanca. Poi c’è l’8 settembre, l’occupazione tedesca e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, che non era per niente facile da far funzionare, soprattutto fuori dalle città. È interessante vedere come la Seconda Guerra Mondiale abbia stravolto la vita di tutti, dal mondo operaio nelle fabbriche affamate al mondo rurale, dove l’incontro tra partigiani e contadini era complicato e pieno di sfide. Il libro esplora anche la violenza di quel periodo, non solo quella militare, ma anche la persecuzione e la deportazione, e come il potere locale cercasse di arrangiarsi mentre lo Stato centrale andava in pezzi. Attraverso storie che toccano luoghi come Ferrara o la Basso Padana, capisci che la Resistenza e la crisi del ’43 sono state un processo complesso, fatto di scontri, alleanze inattese e una profonda trasformazione della società italiana. È un modo per capire che la storia non è mai semplice, ma un intreccio di tante vite e decisioni.Riassunto Breve
La scelta di resistere al fascismo e all’occupazione tedesca non nasce all’improvviso nel 1943, ma matura nel tempo, frutto di esperienze personali e collettive che portano a un “antifascismo esistenziale”, una risposta spontanea e disobbediente al regime. Questo percorso di presa di coscienza si vede in giovani che leggono e discutono, come Rosario Bentivegna, o in gruppi che scoprono nel mondo operaio un potenziale di ribellione. Il mondo operaio, infatti, vive condizioni difficili sotto il fascismo e la guerra, con fame, orari pesanti e repressione, generando un malcontento diffuso che esplode negli scioperi del marzo 1943, nati da rivendicazioni economiche ma con un chiaro significato politico, mostrando il fallimento del regime. Tra il 1942 e il 1943, la propaganda ufficiale perde credibilità, sostituita da notizie alternative che rivelano il disastro bellico, portando a una crescente intolleranza verso il regime. L’invasione della Sicilia e il bombardamento di Roma nel luglio 1943 accelerano la crisi che porta alla caduta di Mussolini. Dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, l’Italia precipita in un vortice di violenza. Il sistema nazista intensifica sterminio e lavoro forzato, estendendo la rete dei campi. In Italia, la violenza si radicalizza con la persecuzione e deportazione di ebrei e partigiani, in cui la Repubblica Sociale Italiana collabora con i tedeschi. I bombardamenti alleati, intanto, distruggono le città, causano sfollamenti e peggiorano le condizioni di vita, alimentando il malcontento che sfocia negli scioperi del 1943, segnando l’inizio di un’opposizione organizzata. La Repubblica Sociale Italiana, nata sotto pressione tedesca, fatica a radicarsi, affrontando ostilità e limitazioni imposte dall’occupante. I giovani aderiscono per motivi emotivi, mentre figure più anziane cercano potere. La retorica di Mussolini si concentra sul tradimento. La presenza tedesca impone oneri economici e limita l’autonomia. Parallelamente, la guerra disgrega il mondo rurale, sfruttato intensivamente. L’incontro tra partigiani e contadini è complesso, con i contadini che offrono supporto ma temono rappresaglie. I partigiani cercano legittimazione, mentre nelle campagne della pianura padana la Resistenza si afferma intervenendo su problemi economici. Le politiche della RSI e l’occupazione tedesca influenzano questo rapporto. La crisi del 1943 rivela una profonda debolezza dello Stato italiano, incapace di mobilitare la società per la guerra, a differenza del regime fascista che aveva cercato di superare la fragilità dello Stato liberale eliminando i partiti. Il crollo dello Stato crea un vuoto che i partiti antifascisti, legittimati dalla Resistenza, cercano di colmare nel dopoguerra, agendo come rappresentanti della società. Nelle campagne basso-padane, strutture corporative fasciste locali mantengono una certa continuità e controllo economico-sociale, dimostrando una resilienza che contrasta con la disintegrazione dello Stato centrale. La crisi dello Stato si riflette anche a livello locale. I prefetti fascisti cercano di mantenere il controllo, ma la loro efficacia è limitata. Dopo il 25 luglio, il governo Badoglio attua una limitata epurazione, ma il corpo prefettizio di carriera mantiene un orientamento conservatore. Nella RSI, i “capi della Provincia” sono subordinati ai tedeschi e alle milizie fasciste, faticando a mantenere l’ordine. A livello comunale, i podestà assumono compiti cruciali nella gestione delle emergenze belliche, diventando un punto di riferimento per la popolazione, mentre il partito perde credibilità. Emerge un forte “localismo”. A Ferrara, il fascismo è segnato da contrapposizioni interne. Dopo il 25 luglio, le autorità badogliane sono riluttanti a un completo cambio del personale. La morte del capo della Provincia Igino Ghisellini nel novembre 1943 provoca una violenta rappresaglia. Dopo l’8 settembre, migliaia di prigionieri alleati fuggono e trovano rifugio e aiuto nella popolazione locale, soprattutto tra i contadini, creando alleanze inattese. Alcuni ex prigionieri si uniscono in seguito alla Resistenza.Riassunto Lungo
1. La scelta matura prima del ’43
La Resistenza non è un fenomeno che appare all’improvviso nel 1943. È il risultato di un lungo percorso che affonda le radici negli anni precedenti. Il crollo del regime fascista e i drammatici eventi del 1943, pur essendo decisivi, non fanno altro che accelerare processi di maturazione che erano già in corso nella società italiana. L’opposizione al fascismo non è solo un’attività politica organizzata, ma anche una risposta molto personale, quasi istintiva, che possiamo definire “antifascismo esistenziale”. Questa reazione nasce da un insieme complesso di esperienze vissute e di idee che spingono le persone all’azione, spesso in modo spontaneo e non coordinato.I percorsi individuali verso la scelta
La decisione di resistere è vista come un atto di profonda disobbedienza, una vera e propria rivolta contro un potere che viene percepito come ingiusto e che prevale sui valori morali e sulla libertà. Questa scelta, pur manifestandosi in un momento preciso e spesso drammatico, è preparata da un lungo cammino fatto di esperienze individuali e collettive. Possiamo trovare esempi significativi di questi percorsi nelle storie di molti giovani. Alcuni maturano i loro dubbi sul fascismo attraverso la lettura di libri proibiti o discussioni private che aprono nuove prospettive. Pensiamo a figure come Rosario Bentivegna, la cui decisione di passare all’azione diretta scaturisce in modo potente dal bombardamento di Roma nel 1943, ma che affonda le sue radici in una presa di coscienza critica sviluppata molto tempo prima. In modo simile, un gruppo di giovani a Genova trova nei libri uno strumento fondamentale per rifiutare il fascismo e scopre, nel contatto con il mondo operaio, un inatteso e potente potenziale di ribellione e cambiamento.Il mondo operaio e le prime proteste
Il mondo operaio, spesso ignorato o addirittura disprezzato dalla propaganda di regime, diventa un punto di riferimento cruciale per molti antifascisti. Le condizioni di vita e di lavoro sotto il fascismo e, in seguito, sotto il peso della guerra, sono estremamente difficili. Razionamenti sempre più stretti, orari di lavoro massacranti e una repressione costante generano un malcontento diffuso e profondo tra i lavoratori. Gli scioperi che scoppiano nel marzo del 1943, pur nascendo inizialmente da rivendicazioni economiche legate alla fame e alla miseria, assumono rapidamente un significato politico molto forte. Dimostrano in modo inequivocabile l’incapacità del regime di gestire la crisi economica e sociale e, soprattutto, evidenziano la crescente disaffezione degli operai nei confronti della guerra voluta da Mussolini. Questi scioperi, sebbene non portino a una ribellione aperta e organizzata, mostrano chiaramente il divario enorme tra la realtà vissuta dalla popolazione e la propaganda vuota e trionfalistica del regime.La crescente disillusione e il crollo
Tra l’autunno del 1942 e l’estate del 1943, si assiste a una crescita costante della disassociazione dal fascismo e dalla guerra. La propaganda ufficiale del regime perde ogni credibilità agli occhi della gente, che non crede più alle promesse e alle bugie. Al contrario, le notizie che circolano attraverso fonti alternative – le radio nemiche ascoltate di nascosto, le voci che si diffondono di bocca in bocca, i racconti drammatici dei soldati reduci dal fronte – alimentano una crescente consapevolezza del disastro in cui il paese è precipitato. La società, pur non riuscendo ancora a organizzare un’opposizione politica strutturata e visibile, manifesta in mille modi quotidiani la sua intolleranza verso il regime, attraverso critiche sussurrate, gesti di insofferenza e sguardi ostili. L’invasione della Sicilia da parte degli Alleati nel luglio del 1943 e il successivo, devastante bombardamento di Roma accelerano in modo decisivo la crisi interna, culminando nella caduta di Mussolini il 25 luglio. La scelta di resistere, che porterà poi alla lotta armata, è dunque il punto di arrivo di questo processo complesso, profondamente influenzato dalle esperienze personali, dalle difficili condizioni sociali e dal precipitare degli eventi bellici che rendono insostenibile la situazione.Se la scelta matura prima del ’43, quanto di questa maturazione è davvero “esistenziale” e quanto è frutto dell’azione politica organizzata che il capitolo sembra marginalizzare?
Il capitolo offre una prospettiva interessante sui percorsi individuali e sulla disaffezione diffusa che precedettero la Resistenza. Tuttavia, l’enfasi sull’aspetto “esistenziale” e sulla spontaneità rischia di non rendere pienamente conto del ruolo cruciale che le diverse componenti dell’antifascismo organizzato (dai comunisti ai liberali, passando per socialisti e azionisti) ebbero nel mantenere accesa la fiamma dell’opposizione, nel fornire quadri e riferimenti, e nel preparare, pur tra mille difficoltà, il terreno per la ripresa della lotta. Per comprendere meglio la complessità di questa “maturazione”, è indispensabile integrare la lettura con studi sulla storia dei partiti e movimenti antifascisti clandestini. Autori come Paolo Spriano, Guido Neppi Modona o Claudio Pavone offrono analisi fondamentali su questi aspetti, mostrando come la scelta di resistere affondi le radici anche in decenni di militanza e sacrificio organizzato.2. Il difficile radicamento: RSI, partigiani e mondo rurale
La Repubblica Sociale Italiana nasce nel 1943, frutto di una selezione confusa degli elementi fascisti preesistenti e pressata da urgenze tragiche. Ci si chiede se fosse uno stato autonomo o semplicemente un fantoccio nelle mani dei tedeschi. L’adesione dei giovani era spesso guidata da emozioni o legami familiari, come la figura paterna o un senso di onore ferito dal comportamento del re. Le figure più anziane, invece, cercavano potere o una forma di redenzione dopo gli eventi del 25 luglio. Mussolini, pur apparendo indebolito, usava una retorica forte, concentrata sul tradimento della monarchia e sulla vendetta, cercando di ricostruire un legame con il popolo basato su una tragedia condivisa. Nonostante questi sforzi, la RSI faticava a radicarsi nelle province, incontrando numerosi ostacoli e diffidenza. Anche il Partito fascista repubblicano manteneva caratteristiche conflittuali, con episodi di violenza squadrista che i vertici cercavano di tenere sotto controllo.L’impatto dell’occupazione tedesca
La situazione era ulteriormente complicata dalla presenza tedesca. L’occupazione imponeva oneri economici molto pesanti, come contributi di guerra e requisizioni forzate, e limitava fortemente l’autonomia militare della RSI. I territori di confine venivano di fatto annessi al Reich. L’opinione pubblica italiana era generalmente diffidente o apertamente ostile nei confronti dei tedeschi, anche a causa dei loro comportamenti spesso molto duri e repressivi.La crisi nel mondo rurale
Parallelamente agli eventi politici e militari, la guerra causava una profonda disgregazione sociale, specialmente nelle aree rurali. L’agricoltura subiva uno sfruttamento intensivo delle risorse interne, con costi sociali elevati per i contadini. Questi ultimi dovevano affrontare orari di lavoro lunghissimi e una drastica riduzione dei prodotti destinati al proprio autoconsumo. La politica annonaria, volta a garantire l’approvvigionamento alimentare, falliva nel suo intento. I partiti antifascisti, concentrati inizialmente sulle città, mostravano un ritardo nel comprendere e affrontare questa grave crisi che colpiva le campagne.Il difficile incontro tra partigiani e contadini
L’incontro tra partigiani e contadini, che divenne cruciale a partire dal 1944, fu un processo complesso e non privo di tensioni. Nelle zone di montagna, i contadini offrivano un supporto logistico essenziale, ma valutavano attentamente le azioni partigiane in base al rischio di subire rappresaglie da parte delle forze nemiche. Spesso, la logica della guerriglia partigiana si scontrava con le esigenze di autodifesa e protezione delle comunità contadine. I partigiani cercavano di ottenere legittimazione e consenso attraverso strategie sia materiali che culturali, a volte mediate da figure che avevano legami sia con il mondo urbano che con quello rurale. Nelle campagne della pianura padana, caratterizzate dalla presenza di grandi aziende agricole e da un vasto numero di braccianti, la Resistenza si affermò più tardi rispetto alle montagne. Tuttavia, in queste aree riuscì a costruire una solida base di massa intervenendo direttamente sui problemi economici e sociali più sentiti, come la distribuzione del cibo e il miglioramento dei rapporti di lavoro nelle campagne.Politiche e dinamiche locali che influenzano il rapporto
Le politiche messe in atto dalla RSI e le azioni dell’occupazione tedesca ebbero un forte impatto sul rapporto tra partigiani e contadini. L’amministrazione agraria repubblicana non riuscì a risolvere gli squilibri esistenti nelle campagne. In alcune aree, l’efficacia delle strutture corporative locali favorì un certo adattamento alla crisi da parte dei contadini, riducendo la loro propensione alla conflittualità e, di conseguenza, ostacolando la formazione di un’alleanza stabile con i partigiani. Nelle zone più vicine al fronte, la violenza scatenata dai tedeschi poteva spingere i contadini verso la resistenza, ma poteva anche creare divisioni e paura che impedivano la collaborazione. Nelle retrovie, i tedeschi a volte mantenevano l’ordine con fermezza per poter sfruttare al meglio le risorse agricole, e questa relativa stabilità poteva ridurre la percezione da parte dei contadini della necessità di un’alleanza con i partigiani. L’incontro tra partigiani e contadini si sviluppò, quindi, all’interno di questo quadro complesso, influenzato dalla crisi generale, dalle politiche delle istituzioni e dalle specifiche dinamiche locali di ogni territorio.Descrivere le tensioni tra partigiani e contadini è sufficiente a spiegare come sia nata un’alleanza cruciale per la Resistenza?
Il capitolo descrive efficacemente le tensioni e le difficoltà nell’incontro tra partigiani e mondo rurale, evidenziando lo scontro tra la logica militare della Resistenza e le esigenze di sopravvivenza e autodifesa dei contadini. Tuttavia, limitarsi a descrivere le tensioni non spiega appieno come, nonostante questi ostacoli, sia stato possibile costruire un rapporto di fiducia e un’alleanza che si è rivelata fondamentale. Per comprendere questo complesso processo di radicamento, è necessario approfondire la storia sociale e la microstoria, analizzando le dinamiche locali, il ruolo dei mediatori e le specifiche strategie messe in atto per superare la diffidenza. Autori come Claudio Pavone e Santo Peli offrono strumenti concettuali e ricerche approfondite su questi aspetti cruciali del rapporto tra Resistenza e società italiana.3. 1943: L’Italia nel Vortice della Crisi e della Violenza
Il 1943 segna un momento cruciale per l’escalation della violenza in Europa. Il sistema nazista perfeziona le sue pratiche di sterminio e lavoro forzato, ampliando la rete dei campi di concentramento e deportazione. L’eliminazione di prigionieri, civili e oppositori politici attraverso il lavoro coatto diventa una pratica consolidata, strettamente legata all’occupazione dei territori e a una visione gerarchica basata sulla razza. In questo periodo, la deportazione di massa di ebrei e altre minoranze raggiunge il suo culmine.L’Italia dopo l’armistizio
Dopo l’armistizio del 1943 e l’occupazione tedesca, la violenza in Italia si radicalizza. Il paese diventa teatro di un conflitto interno molto complesso. Si scontrano l’esercito tedesco, la Repubblica Sociale Italiana (RSI) e le forze antifasciste. In questo contesto, le pratiche di violenza fascista, già presenti in passato con l’internamento di slavi e le leggi razziali del 1938, si intensificano notevolmente. La RSI collabora attivamente con i tedeschi nella persecuzione e deportazione di ebrei e partigiani. Queste persone vengono inviate verso i campi di sterminio situati nell’Europa orientale. L’internamento e la deportazione degli ebrei italiani colpiscono circa un quarto dell’intera comunità, rappresentando un chiaro esempio di questa svolta violenta.L’impatto dei bombardamenti alleati
Parallelamente a questo scenario interno, i bombardamenti aerei condotti dagli alleati si intensificano dalla fine del 1942. Questi attacchi mettono in seria crisi il regime fascista, che si dimostra impreparato a difendere la popolazione civile. La difesa contraerea è scarsamente efficiente, mancano rifugi adeguati e la distruzione delle città è diffusa. Tutto ciò causa sfollamenti di massa, un peggioramento drastico delle condizioni di vita e un calo generalizzato del morale tra la popolazione. La percezione della sconfitta imminente, alimentata dai continui bombardamenti e dalla propaganda alleata, contribuisce a un crescente scontento popolare.Scontento e nascita della Resistenza
Questo diffuso malcontento sfocia in proteste e scioperi operai. Particolarmente significativi sono gli scioperi nelle città industriali come Torino e Milano nel marzo 1943. Queste manifestazioni nascono dalle difficili condizioni di vita e di lavoro causate dai bombardamenti e dalla guerra. Gli scioperi segnano l’emergere di un’opposizione organizzata al regime e l’inizio di quella che diventerà la Resistenza. L’Italia nel 1943 è quindi un paese segnato dalla sovrapposizione di diverse forme di violenza: quella legata all’occupazione militare, quella del conflitto civile e quella derivante dalla guerra aerea.Se lo Stato centrale crollò, come mai le strutture locali legate al fascismo dimostrarono una resilienza maggiore, e cosa ci dice questo sulla natura del potere e del consenso in Italia?
Il capitolo evidenzia un contrasto notevole tra la disintegrazione dello Stato centrale nel 1943 e la persistenza di strutture locali legate al fascismo, come i consorzi agrari. Questa dicotomia, presentata come un dato di fatto, merita un approfondimento critico. Per comprendere meglio questa apparente contraddizione e la natura del radicamento del fascismo a livello territoriale, è fondamentale esplorare la storia sociale ed economica dell’Italia rurale durante il ventennio e la transizione post-bellica. Si possono approfondire gli studi sulla base sociale del fascismo a livello locale, il funzionamento delle sue organizzazioni periferiche e il loro effettivo radicamento nel tessuto economico e comunitario, al di là della facciata del regime. Autori come Emilio Sereni o Paul Corner, o studi specifici sulla storia agraria e sul sindacalismo fascista, possono offrire prospettive utili a capire perché certe forme di potere e organizzazione sopravvissero al crollo del regime centrale e quale ruolo giocarono nella continuità o nella trasformazione del potere locale nel dopoguerra.7. Scontri, Fuga e Alleanze Inattese
Fin dalle sue origini, il fascismo a Ferrara è segnato da forti contrasti interni. Da una parte c’è Olao Gaggioli, espressione della borghesia della città. Dall’altra si impone Italo Balbo, appoggiato dai grandi proprietari terrieri. Nel 1921, Balbo imprime una svolta basata sulle azioni squadriste e sugli interessi agrari, prendendo il sopravvento su Gaggioli. Solo dopo la morte di Balbo, avvenuta nel 1940, Gaggioli torna a ricoprire un ruolo di primo piano come segretario federale, segnando la fine del periodo dominato dal gruppo legato a Balbo.Ferrara e la Caduta del Regime
Ferrara gioca un ruolo importante nella crisi che porta alla fine del regime fascista. Le celebrazioni in onore di Italo Balbo, che si tengono nel giugno del 1943, vedono la partecipazione di figure di spicco del fascismo nazionale. Molti di questi gerarchi voteranno poi a favore dell’ordine del giorno Grandi il mese successivo, un passaggio chiave che porta alla caduta di Mussolini. Il periodo immediatamente successivo al 25 luglio 1943, sotto il governo Badoglio, è vissuto a Ferrara con manifestazioni di gioia e richieste di liberare gli antifascisti. Tuttavia, le nuove autorità mostrano una certa esitazione nel sostituire completamente il personale legato al vecchio regime. Un esempio è il prefetto Giovanni Dolfin, che, pur allontanando altri funzionari, mantiene il suo incarico e in seguito ricoprirà ruoli nella Repubblica Sociale Italiana. Anche la borghesia locale, che in passato aveva sostenuto il fascismo, si trova in una situazione di incertezza. Questa fase di cambiamento crea tensioni che avranno conseguenze sul fascismo che si formerà sotto la Repubblica Sociale.Il Fascismo Repubblicano a Ferrara
Dopo l’armistizio e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, nel settembre 1943, Igino Ghisellini prende la guida del Partito Fascista Repubblicano (Pfr) a Ferrara. Il suo periodo alla guida del partito si rivela fin da subito molto difficile e complesso. La sua morte, avvenuta nel novembre 1943, scatena una reazione violentissima da parte fascista. Questa rappresaglia colpisce duramente la popolazione civile, gli antifascisti e in particolare gli ebrei. Le ricerche sulla morte di Ghisellini hanno esplorato diverse piste, dall’idea di uno scontro interno al fascismo ferrarese a quella di un’azione compiuta dai partigiani. Studi recenti sembrano orientarsi verso quest’ultima ipotesi.Dopo l’Armistizio: Fuga e Alleanze Inattese
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, migliaia di prigionieri alleati si trovano ancora nei campi di prigionia in Emilia. L’esercito britannico ordina loro di “restare fermi”, un comando che porta alla cattura e deportazione di molti da parte delle forze tedesche. Alcuni comandanti italiani, come Eugenio Vicedomini nel campo di Fontanellato, scelgono invece di liberare i prigionieri, mentre altri collaborano con i tedeschi. Molti prigionieri riescono a fuggire e trovano rifugio e aiuto nella popolazione locale, specialmente tra i contadini, dando vita a una “strana alleanza” basata sulla solidarietà. I fuggiaschi cercano in vari modi di raggiungere le linee alleate che avanzano verso sud o di attraversare il confine svizzero a nord. Inizialmente, molti ex prigionieri sono diffidenti verso le prime formazioni partigiane che si stanno creando. Tuttavia, in seguito, alcuni di loro, inclusi militari jugoslavi, si uniscono alla Resistenza, contribuendo a dare un carattere aperto a diverse brigate attive nell’Appennino emiliano.Se la causa della morte di Ghisellini è ancora dibattuta, come possiamo comprendere appieno la logica (o l’irrazionalità) delle violentissime rappresaglie che ne seguirono?
Il capitolo, pur menzionando il dibattito storiografico sulla morte di Ghisellini, non ne esplora le implicazioni per la comprensione degli eventi successivi. L’incertezza sulla causa di un fatto così scatenante lascia una lacuna nell’analisi delle rappresaglie. Per colmare questa lacuna, è necessario immergersi nella storiografia specifica sulla Repubblica Sociale Italiana e sulla storia di Ferrara durante la guerra civile. Consultare gli studi di autori che hanno analizzato le dinamiche interne al fascismo repubblicano e le azioni della Resistenza in Emilia può offrire il contesto necessario per valutare le diverse ipotesi e l’impatto di questo tragico evento.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]