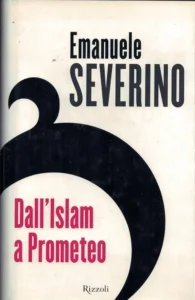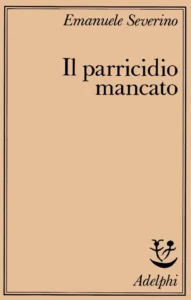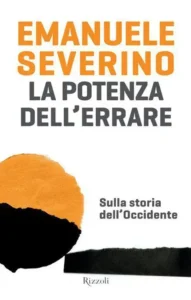1. Il Senso Europeo della Cosa e il Nichilismo
L’unificazione politica dell’Europa incontra difficoltà. Questo accade perché la conoscenza scientifica è molto divisa, creando tante “Europe” separate. Di conseguenza, l’azione politica manca di uno scopo comune, non sapendo bene dove dirigersi. Oggi, la forza più potente e dominante è l’azione scientifico-tecnologica, nata proprio in Europa. Questa azione punta a un dominio senza limiti su ciò che ci circonda, vedendo le cose solo come materiali da usare o distruggere.L’Idea Europea di “Cosa” e la Nascita del Nichilismo
Questa visione del dominio ha radici profonde nel pensiero greco. I Greci furono i primi a concepire la “cosa” (ente) non come qualcosa di stabile e permanente, ma come qualcosa che può emergere dal nulla e ritornarvi. Questa comprensione della cosa come disponibile all’esistenza e al niente, pronta per essere usata o distrutta, è il vero fondamento della civiltà europea fin dalle sue origini. Questa disponibilità radicale delle cose rivela l’essenza più nascosta e profonda di questa civiltà: il nichilismo.Il Tempo, il Dominio e la Via d’Uscita
Il nichilismo non è solo una filosofia, ma una convinzione profonda: le cose, in sé, sono niente. Questa idea si manifesta nel modo in cui l’Occidente vede il tempo. Il passato e il futuro sono visti come momenti in cui le cose “non ci sono più” o “non ci sono ancora”, cioè sono niente. Il tempo, in questa visione, separa la cosa dal suo essere, rendendola disponibile al dominio. La volontà di dominare, che trova la sua massima espressione nella tecnica, nasce proprio da questa separazione. I tentativi di “salvare” l’uomo o la civiltà attraverso il sacro, la politica o le ideologie moderne non riescono perché operano all’interno di questa stessa separazione fondamentale, accettando il tempo e l’idea che le cose siano niente. La civiltà della tecnica è la realizzazione più completa di questo nichilismo. Uscire da questa situazione difficile richiede una comprensione profonda del nichilismo stesso. Significa anche trovare un nuovo rapporto con la verità dell’essere, un rapporto che riconosca il valore intrinseco di ogni cosa. È necessario vedere ogni cosa non come disponibile al niente, ma nella sua eternità.Davvero l’intera civiltà europea, dalle sue origini, si fonda esclusivamente su questa specifica interpretazione della “cosa” greca, riducendo ogni altra influenza a mera accettazione del nichilismo tecnico?
Il capitolo presenta una linea diretta e potente tra una certa lettura del pensiero greco antico e il nichilismo tecnico moderno, identificandola come l’essenza stessa della civiltà europea. Questa tesi, per quanto suggestiva, rischia di semplificare eccessivamente la complessità storica e filosofica, ignorando o sottovalutando altre correnti di pensiero e fattori culturali (come il cristianesimo, il diritto romano, altre tradizioni filosofiche e scientifiche) che hanno plasmato l’Europa. Per mettere in prospettiva questa affermazione e comprendere meglio le molteplici radici della civiltà europea e le diverse interpretazioni del nichilismo, sarebbe utile approfondire la storia della filosofia, in particolare il pensiero antico e la sua ricezione, e confrontarsi con autori che hanno analizzato il rapporto tra tecnica, essere e storia, come ad esempio Heidegger, o che hanno offerto visioni alternative sullo sviluppo del pensiero occidentale.2. La separazione capitalistica e il dogma dell’unità necessaria
La scienza si basa su un principio fondamentale: una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo; non ci possono essere contraddizioni nella realtà che osserviamo. Questo principio di non contraddizione è essenziale per capire il mondo in modo scientifico. La dialettica, invece, è una forma di pensiero che ammette l’esistenza di contraddizioni nella realtà stessa. Questa differenza fondamentale rende la dialettica, almeno in apparenza, incompatibile con il modo di pensare scientifico. Per superare questa difficoltà e mantenere l’idea che il pensiero di Marx sia scientifico, alcuni studiosi marxisti cercano di distinguere tra un’opposizione “reale” e una “dialettica”.La visione di Colletti e un dilemma
Il filosofo Colletti, studiando gli scritti di Marx, arriva alla conclusione che i conflitti e le tensioni presenti nel capitalismo non sono semplici opposizioni, ma vere e proprie contraddizioni dialettiche. Questo crea un problema significativo per Colletti. Se la scienza ci dice che la realtà non è contraddittoria, ma Marx descrive il capitalismo – che è una realtà concreta – come pieno di contraddizioni dialettiche, allora sorge un dubbio: il capitalismo, così come descritto da Marx, può davvero esistere? Colletti si trova di fronte a un dilemma difficile, incerto se l’idea di una realtà che contiene contraddizioni possa coesistere con una visione scientifica del mondo.La separazione come contraddizione
All’inizio, Colletti definiva la contraddizione dialettica come l’unione di elementi opposti, distinguendola dall’opposizione reale che implica semplicemente una separazione tra le cose. Tuttavia, analizzando più a fondo come Marx parla del capitalismo, Colletti cambia la sua prospettiva. Arriva ad affermare che la contraddizione dialettica tipica del capitalismo è proprio la separazione. Vede questa separazione in concetti chiave come quella tra la merce prodotta e il denaro che la rappresenta, o tra il valore d’uso di un oggetto (a cosa serve) e il suo valore di scambio (quanto vale sul mercato). Questa nuova visione, in cui la separazione è la contraddizione, rovescia la sua definizione iniziale e rende il suo ragionamento meno coerente.La prospettiva di Marx: il pensiero e la realtà
L’idea che Marx descriva la separazione nel capitalismo come una contraddizione dell'”inseparabile” potrebbe far pensare, seguendo l’interpretazione di Colletti, che il capitalismo sia una contraddizione logica e quindi non possa esistere. Ma forse, secondo un’altra lettura, Marx intendeva questa separazione in modo diverso. Potrebbe averla vista come un’azione specifica del pensiero o dell’intelletto che opera all’interno del capitalismo. In questa prospettiva, il capitalismo non è solo un sistema economico, ma anche un modo di pensare e vivere la realtà, basato proprio sulla separazione tra elementi che sembrano legati. La contraddizione, quindi, non sarebbe un difetto nella realtà in sé, ma piuttosto nel modo in cui il pensiero razionale, tipico della società capitalistica, percepisce e organizza questa realtà, vivendola come divisa e separata.Una debolezza nella teoria
Una possibile debolezza nel pensiero di Marx, così come viene presentato, sta nel presupporre l’esistenza di un’unità originale e necessaria – per esempio, tra l’uomo e la natura, o tra l’individuo e la società – senza però dimostrare chiaramente perché questa unità sia necessaria. Se questa unità fosse stata solo un dato di fatto storico, allora la sua successiva separazione non sarebbe una contraddizione, ma semplicemente un cambiamento. Se invece fosse stata davvero necessaria, la ragione di questa necessità non viene spiegata a fondo. Il capitalismo, essendo una società che si fonda sulla separazione, si allinea bene con la logica del pensiero razionale e della scienza, i quali tendono a vedere questa separazione non come una contraddizione, ma come la condizione normale delle cose.Ma se l’unità originale non è mai stata dimostrata come necessaria, su cosa si basa l’idea che la separazione capitalistica sia una ‘contraddizione’ e non un semplice, benché magari sgradito, cambiamento?
Il capitolo giustamente solleva un punto cruciale: l’argomentazione che vede la separazione capitalistica come una contraddizione dialettica sembra poggiare sull’assunto implicito di un’unità originaria (tra uomo e natura, individuo e società, ecc.) che sarebbe stata “necessaria”. Tuttavia, se questa necessità non viene rigorosamente dimostrata, la successiva separazione non configura una contraddizione logica o dialettica nel senso forte, ma appare piuttosto come un’evoluzione storica o un dato di fatto. Per affrontare questa lacuna, sarebbe fondamentale indagare le basi filosofiche e storiche di tale presunta unità necessaria. Approfondire la filosofia della storia, in particolare le diverse concezioni del progresso o del divenire storico, e confrontare le interpretazioni di autori come Hegel e Marx sulla dialettica e la sua applicazione alla realtà sociale ed economica, può aiutare a comprendere se l’idea di una “necessità” intrinseca in certi stati dell’essere o della società sia sostenibile o se si tratti piuttosto di una costruzione concettuale.3. Il Divenire e il Nulla dell’Occidente
La radice del nichilismo occidentale
Il nichilismo si basa sulla convinzione profonda che ciò che esiste sia, in fondo, niente. Questa idea non è nuova, ma affonda le sue radici nel pensiero occidentale fin dai tempi antichi, strettamente legata al concetto di divenire. Credere che le cose nascano e muoiano, che passino dall’essere al non essere e viceversa, implica considerare l’esistenza stessa come qualcosa che in certi momenti o nel suo processo è assente, è nulla. Anche se non sempre espressa apertamente, questa persuasione agisce come una forza sotterranea ma potente che modella la civiltà occidentale. La fede nel divenire come l’unica realtà fondamentale porta inevitabilmente a negare l’esistenza di qualsiasi cosa sia immutabile o eterna. Se tutto è in costante cambiamento, nulla di fisso può davvero esistere, perché una realtà eterna predeterminerebbe il divenire, riducendolo a una semplice apparenza. È per questa ragione logica che le idee di “dèi” o entità fisse e immutabili, come concepite in Occidente, sono destinate a dissolversi di fronte alla logica interna del divenire.Scienza e tecnica: l’espressione del nichilismo
Le forme più coerenti e potenti di questo nichilismo si manifestano nella scienza e nella tecnica moderne. Queste discipline si fondano sull’idea che la realtà sia essenzialmente manipolabile e che non esistano verità assolute o essenze fisse e immutabili da scoprire, ma solo processi da comprendere e controllare. La loro enorme forza deriva proprio dalla capacità di accettare l’imprevedibilità di ciò che emerge dal “niente”, cioè il nuovo, e di riuscire a dominarlo e utilizzarlo. Molti pensatori, pur criticando alcuni aspetti della filosofia occidentale o gli effetti della tecnica sulla società, non riescono a cogliere questo senso profondo del nichilismo che ne è alla base. Essi rimangono intrappolati nella convinzione fondamentale che ciò che esiste possa, in qualche modo, essere niente, e questa convinzione è la vera radice dell’alienazione.Una prospettiva diversa: l’eternità delle cose
Esiste, tuttavia, una prospettiva radicalmente diversa, che si colloca al di fuori del percorso del nichilismo occidentale. Questa visione rivela l’impossibilità intrinseca che ciò che esiste possa mai essere ridotto a niente, mostrando così l’eternità di ogni singola cosa. La vera trasformazione, vista da questo punto di vista, non è un cambiamento guidato dalle azioni umane o da forze storiche, ma è l’apparire improvviso di questa verità eterna. Quando questa verità si manifesta, essa svela la fede nel divenire, così centrale per il pensiero occidentale, come una profonda illusione. In questa luce, la tecnica, pur apparendo potentissima nella sua capacità di dominio sul mondo, si rivela in realtà più debole e meno fondamentale della necessità eterna e immutabile delle cose.Come si può accettare l’eternità dell’essere come verità autoevidente quando il capitolo non ne offre alcuna giustificazione?
Il capitolo fonda la sua intera critica del pensiero occidentale e delle sue manifestazioni (nichilismo, tecnica, violenza) sull’affermazione che l’essere è eterno. Tuttavia, questa premessa fondamentale, di natura squisitamente metafisica, viene semplicemente asserita senza fornire alcuna argomentazione, prova o base razionale che ne dimostri la validità. L’intera costruzione argomentativa rischia così di apparire come una petizione di principio, partendo da ciò che andrebbe dimostrato. Per comprendere le diverse posizioni sul problema dell’essere e su come se ne possa parlare o conoscere, è indispensabile confrontarsi con la storia della metafisica e dell’ontologia. Autori come Parmenide, Platone, Aristotele, e in epoca moderna Hegel e Heidegger, offrono prospettive radicalmente diverse sull’essere, sul divenire e sulla possibilità stessa di affermare verità eterne.6. Scontri Filosofici e l’Ombra del Nichilismo
Spesso, le diverse posizioni filosofiche vengono etichettate e inserite in categorie rigide, come “irrazionalismo” o “reazionarismo”. Questo modo di classificare, però, rischia di non cogliere la vera profondità delle idee. A volte, ci si basa su letture superficiali o si prendono frasi fuori dal loro contesto originale, perdendo di vista le argomentazioni più complesse che stanno alla base di un pensiero.Il Concetto di Contraddizione
Un esempio di come le idee possano essere interpretate in modi diversi riguarda il concetto di contraddizione, specialmente nell’analisi di Marx. Si tende a pensare che per Marx la contraddizione sia legata solo al capitalismo, derivando dalla natura stessa della merce. Tuttavia, è riconosciuto che la merce esisteva anche prima del capitalismo. Questo fa sorgere una domanda: la contraddizione è davvero esclusiva del capitalismo o è presente in tutti i fenomeni, come a volte viene suggerito? Lo sviluppo della società, in realtà, sembra mostrare una contraddittorietà che è un aspetto universale, diverso dalla semplice opposizione logica, e che continua a esistere anche quando non ci sono più le divisioni di classe.Contraddizione in Diversi Pensatori
Per capire meglio la contraddizione, è utile confrontarsi con filosofi come Hegel, Kant e Aristotele. Kant parla di opposizione reale tra forze che si contrastano. Aristotele considera i contrari, dove uno è l’assenza dell’altro, ma vede anche come i contrari possano essere uniti in un concetto. Hegel, con la sua dialettica, non vede l’unione degli opposti come una loro cancellazione, ma come un superamento che mantiene l’insieme delle loro caratteristiche. Marx interpreta la dialettica hegeliana come il superamento dell’alienazione e il riappropriarsi della realtà oggettiva; in questo senso, dire che un oggetto è “nullo” significa che non è più indipendente dal pensiero, non che viene distrutto.Evitare Classificazioni Superficiali
Le critiche che definiscono alcune filosofie “irrazionaliste” o “reazionarie” spesso non tengono conto delle argomentazioni dettagliate che le sostengono. Per esempio, l’idea che la civiltà occidentale sia “nulla” non viene presentata solo in senso negativo, ma come il contrasto tra la verità e il suo allontanamento. Giudicare queste posizioni senza conoscere le ragioni profonde che le motivano porta inevitabilmente a classificazioni che non sono accurate e che non rendono giustizia alla complessità del pensiero.Se la contraddizione è davvero un aspetto universale, come si distingue rigorosamente dalla semplice opposizione logica, e su quali basi si afferma che persista anche al di là delle divisioni di classe?
Il capitolo postula che la contraddizione sia un aspetto universale, distinto dalla mera opposizione logica e presente anche in assenza di divisioni di classe, senza tuttavia fornire i criteri precisi per questa distinzione o argomentare in modo esaustivo la sua persistenza in contesti non classisti. Per approfondire questa complessa tematica e valutare la validità di tali affermazioni, è indispensabile confrontarsi con gli studi sulla logica formale e sulla dialettica filosofica. Utile sarebbe rileggere attentamente le opere di Hegel, per comprendere la sua concezione della contraddizione dialettica e il processo di superamento, e quelle di Marx, per analizzare la sua applicazione al contesto sociale ed economico e la sua visione del superamento delle classi. Anche un confronto con Aristotele e Kant sulla natura dell’opposizione può chiarire i termini del dibattito.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]