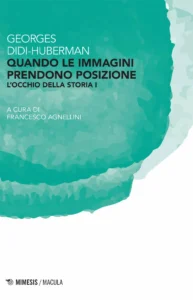Contenuti del libro
Informazioni
“Gesti d’aria e di pietra. Corpo, parola, soffio, immagine” di Georges Didi-Huberman è un libro che ti fa pensare in modo diverso a cose che dai per scontate. Partendo dalle idee del psicoanalista Pierre Fédida, esplora il legame profondo tra il nostro corpo, la parola che usiamo, il respiro che ci tiene vivi e le immagini che popolano la nostra mente, specialmente quelle dei sogni. Non è solo teoria astratta; il libro mostra come il respiro sia fondamentale per il linguaggio e il pensiero, quasi come l’aria sia la materia stessa con cui costruiamo parole e immagini. Mescola psicoanalisi, filosofia, poesia e arte per guardare all’immagine non solo come una rappresentazione, ma come qualcosa che ha vita, un suo “respiro” e una “materia”, legata alla memoria, al lutto e persino al contatto con chi non c’è più. Parla di come le immagini oniriche siano “veggenti” e di come i sogni siano una sorta di “tomba sensoriale” dove incontriamo la memoria autentica, un’idea che ribalta il concetto tradizionale di lutto. Il libro vede l’immagine come una “potenza genealogica”, qualcosa che ci connette agli antenati non solo in modo simbolico, ma attraverso una risonanza materiale, un “respiro indistinto” che può essere anche una “materia materna dell’assenza”. È un viaggio affascinante che ti porta a considerare come il soffio invisibile della vita si manifesti in forme concrete, e come l’immagine sia il respiro del tempo che ci tocca.Riassunto Breve
Il pensiero lega la parola e l’immagine al respiro e all’aria, considerati elementi fondamentali, non solo funzioni biologiche o concetti astratti. L’aria è vista come la materia e il veicolo del linguaggio e del movimento inconscio, percepita in modo particolare dal corpo vicino agli orifizi. Questa sensibilità corporea si connette all’immagine e alla parola, influenzando persino il ritmo del pensiero e della scrittura. L’immagine non è una semplice rappresentazione, ma possiede un proprio respiro e una materia. Le immagini, specialmente quelle dei sogni, non sono oggetti visti, ma sono attive, “veggenti”, legate a una memoria non cosciente e al tempo dei morti. L’immagine diventa il luogo dove si incontrano elementi opposti come l’aria e la pietra, il movimento e la stasi, il desiderio e il lutto. L’arte, come la scultura, rende visibile questo legame, catturando il movimento. L’immagine si presenta come un ostacolo diretto, un baratro, non uno spazio illimitato di rappresentazione. Il sogno, con il suo respiro indistinto dell’immagine, è inteso come una “tomba sensoriale”, un punto di contatto con i morti e con una memoria autentica. Questo processo è descritto come un’opera di sepoltura, che sposta l’attenzione dal comportamento al fare, dall’economia al valore estetico, superando l’idea di lavoro del lutto. La poesia, per la sua capacità di condensare respiro e significato, è il linguaggio che meglio esprime questo legame tra immagine, respiro e memoria. La forza del linguaggio poetico sta nella sua densità, legata alla metafora, che si manifesta come un atto di “mostrare”, simile alla formazione delle nuvole. Nominare poeticamente significa svelare mantenendo una distanza, creando paradossi tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile. Il respiro è una potenza impercettibile che può influenzare la realtà, e pensarlo poeticamente implica che il destino della verità dipenda da un equilibrio: troppa apertura porta al vuoto, troppa densità alla negazione del linguaggio. Dire poeticamente significa lavorare il linguaggio fino al limite, mostrando un’immagine fuggevole. L’immagine è considerata una potenza genealogica. La parola che ricorda fa emergere gli antenati non solo come ricordo, ma come materia. Il simbolico della parola si trasforma in materia in movimento, respirata dall’immagine nel ricordo. L’ancestralità deriva da una risonanza materiale, non solo simbolica. L’ombra del riflesso, indistinta, è necessaria per comprendere la forza degli antenati, legata all’idea antica dell’aria in movimento che anima l’inanimato. L’antenato è l’immagine dell’assenza stessa, e l’assenza è materia in movimento, impura, che tocca. Questa è l’immagine come potenza genealogica. L’immagine è il respiro del tempo che colpisce, la sepoltura sensoriale dell’assenza, che permette un contatto che fa rivivere una presenza senza rappresentarla. Si critica l’identificazione dell’antenato o del transfert solo con un’immagine paterna legata all’ordine simbolico, poiché l’oggetto perduto non è solo il padre. L’ombra del riflesso è fondamentale. Le madri in lutto o assenti partecipano all’opera genealogica; esiste una materia materna dell’assenza, un respiro indistinto. La madre del morto è la tomba sensoriale del figlio. Il respiro indistinto è la materia materna dell’immagine. Gli esseri viventi dipendono dal soffio della vita, e la loro forma è traccia di movimento. Il soffio invisibile si manifesta, ad esempio nell’amore materno, mostrando il passaggio della vita tra generazioni. L’essere vivente è un luogo di passaggio, e l’essenziale è il movimento che trasmette la vita. Questo suggerisce di pensare il respiro indistinto dell’immagine in termini di presenza.Riassunto Lungo
1. Il Respiro Nascosto dell’Immagine
La parola più giusta illumina la verità, arricchendola attraverso il ritmo, il respiro e il gesto. Pierre Fédida, psicoanalista e filosofo, esplora questa idea, collegandola a una conoscenza che nasce dalla sofferenza, richiamando il “sapere attraverso la sofferenza” greco. Il respiro, spesso considerato secondario, è in realtà fondamentale per dare forma alla parola e al pensiero.L’Aria del Pensiero
L’aria non è solo un mezzo astratto, ma il veicolo e la materia stessa del linguaggio, articolata nella bocca e nei polmoni. Fédida sviluppa un vero e proprio “pensiero dell’aria”, considerandola il mezzo attraverso cui si manifestano le immagini e i movimenti più profondi e inconsci. Questo modo di vedere supera le idee puramente teoriche sul linguaggio e sull’aria, riconoscendo l’aria come un ambiente vitale e una materia concreta, la cui presenza è pienamente avvertita soprattutto quando manca o è impura.Il Corpo Sente l’Aria
Il corpo umano avverte l’aria in modo particolare vicino agli orifizi, percependo una piccola profondità interna. Questa sensibilità fisica è strettamente connessa alla formazione delle immagini e delle parole che usiamo. Si pensi all’asma di Proust, che influenzava non solo il ritmo della sua scrittura ma anche la vividezza della sua memoria olfattiva, dimostrando come il respiro e il corpo siano profondamente intrecciati con la creazione e il ricordo.Psicoanalisi e Intervalli
Nel pensiero di Fédida, la psicoanalisi non è una disciplina isolata, ma dialoga costantemente con la filosofia, la poesia e l’arte, rifiutando di chiudersi in definizioni rigide. Gli spazi tra concetti o discipline diverse non sono visti come vuoti astratti, ma come eventi concreti, come un soffio d’aria che li attraversa. Questo porta all’idea di un “corpo della parola” e di un “corpo del vuoto”, dove l’assenza e il vuoto stesso diventano ambienti e materie tangibili e significative.Il Respiro dell’Immagine
L’immagine, quindi, non è una semplice rappresentazione visiva, ma possiede un proprio “respiro” e una sua “materia”. Le immagini che appaiono nei sogni, in particolare, non sono passive da guardare (“viste”), ma attive e dotate di una propria forza (“veggenti”). Sono legate a un tempo e a una memoria che non appartengono alla coscienza razionale, specialmente quella legata al ricordo dei morti. L’immagine diventa il luogo fisico e mentale dove si incontrano elementi apparentemente opposti: l’aria leggera e la pietra solida, il movimento incessante e la stasi, il desiderio che spinge e il lutto che ferma. L’arte, come la scultura che cerca di catturare il movimento nell’aria e nella pietra, riesce a rendere visibile questo legame profondo tra elementi diversi. L’immagine si presenta come un ostacolo diretto, un baratro da affrontare, e non come una rappresentazione infinita e facilmente accessibile.Sogno, Memoria e Poesia
Il sogno, con il suo “respiro indistinto dell’immagine”, è inteso come una “tomba sensoriale”, un luogo privilegiato di contatto con i morti e di accesso a una memoria autentica e profonda. Questa visione di un’ “opera di sepoltura” si sostituisce al concetto più comune di “lavoro del lutto”, spostando l’attenzione da un processo psicologico basato sul comportamento a un’attività creativa ed estetica. La poesia, con la sua capacità unica di condensare respiro e significato in poche parole, è il linguaggio che meglio riesce a esprimere e a rendere vivo questo legame complesso tra immagine, respiro e memoria, dando voce a ciò che altrimenti resterebbe inespresso.Ma questa “materia dell’immagine” e questo “corpo del vuoto” non rischiano di rimanere affascinanti costruzioni metaforiche, prive di un ancoraggio concreto che vada oltre la suggestione poetica?
Il capitolo propone concetti potenti e suggestivi, come l’aria quale materia del pensiero o l’immagine dotata di un proprio respiro e una propria agency (“veggenti”). Tuttavia, la transizione da queste idee a una loro tangibilità (“corpo della parola”, “corpo del vuoto”, sogno come “tomba sensoriale” per il contatto con i morti) solleva interrogativi sulla loro natura: si tratta di realtà psichiche, di costrutti simbolici estremi, o di pure metafore? Per approfondire e confrontare queste visioni, potrebbe essere utile esplorare diverse scuole di psicoanalisi, non solo quella che si rifà a Fédida, ma anche autori che hanno trattato il lutto e il sogno da prospettive differenti, magari più ancorate alla clinica o a un dialogo diverso con le neuroscienze. Approfondire la filosofia della mente e la fenomenologia potrebbe inoltre offrire strumenti per analizzare il rapporto tra corpo, coscienza e immagine al di fuori di un contesto strettamente psicoanalitico, verificando la tenuta di queste audaci identificazioni tra concetti astratti e “materia” tangibile.2. Il respiro indistinto dell’immagine e l’ombra degli antenati
Il linguaggio della poesia è potente grazie alla sua densità, che nasce dall’uso della metafora. Questa densità non è altro che un modo di “mostrare” le cose, un po’ come il vapore si addensa per formare le nuvole. L’immagine che si crea con le parole poetiche dipende proprio dalla loro natura. Quando nominiamo qualcosa in poesia, la mostriamo: la sveliamo ma allo stesso tempo la teniamo a distanza. Questo crea un gioco di contrasti: svelato e nascosto, vicino e lontano, invisibile come l’aria ma visibile come un’immagine densa. Il poeta apre uno spazio, ma allo stesso tempo dà peso e forma a qualcosa.Il respiro e la parola poetica
Il respiro è una forza che non si vede ma che ha il potere di cambiare le cose. Pensare al respiro in poesia significa correre un rischio, perché il modo in cui usiamo le parole influenza la verità che vogliamo esprimere. Se c’è troppa apertura nel linguaggio, si cade nel vuoto e le parole perdono significato; se c’è troppa densità, si crea una massa informe che soffoca la parola e impedisce la comunicazione. Parlare in modo poetico significa spingere il linguaggio al limite, quasi fino a fargli mancare il fiato, per mostrare qualcosa che non è rigido o pesante, ma un’immagine che appare per un istante e poi svanisce, lasciando una traccia.
L’immagine come legame con gli antenati
Secondo Pierre Fédida, l’immagine possiede una forza legata alla nostra storia familiare e collettiva, una forza “genealogica”. Quando una parola ci riporta alla memoria qualcosa, non fa solo affiorare un ricordo astratto, ma fa emergere gli antenati stessi come una sorta di materia viva. Il significato simbolico della parola si trasforma in materia che si muove, come se fosse respirata dall’immagine che affiora nella memoria. La rappresentazione di qualcosa non è la cosa in sé, ma la sua “emanazione”, il suo respiro vitale. Questo legame con chi ci ha preceduto nasce da una risonanza concreta, materiale, non solo da un significato simbolico.
L’ombra, l’assenza e il respiro indistinto
L’immagine non è sempre chiara; a volte è come un riflesso oscurato o deformato da un’ombra. Non è qualcosa di definito, ma piuttosto un “respiro indistinto”. Questa idea ci riporta alle antiche credenze sull’aria in movimento che dà vita a ciò che è inanimato, generando respiro quasi dal nulla. In questo senso, l’antenato non è una figura precisa, ma l’immagine stessa dell’assenza. Questa assenza non è vuoto, ma una materia che si muove, che non è pura, e che ci tocca profondamente. È qui che risiede la forza genealogica dell’immagine: nell’essere il respiro del tempo che ci raggiunge. L’immagine diventa il modo in cui l’assenza viene “sepolta” nei nostri sensi, andando oltre una semplice traccia. Permette un contatto che fa sentire una presenza, senza però mostrarla in modo definito.
Oltre la figura paterna: la materia materna dell’assenza
È importante non limitare l’idea di antenato o di legame profondo (transfert) solo alla figura del padre o all’ordine simbolico. L’oggetto che sentiamo perduto non è unicamente legato al padre. Per comprendere la vera forza degli antenati, dobbiamo considerare anche l’ombra di cui parlavamo prima, quel respiro indistinto. Le madri che piangono i figli perduti o le madri assenti partecipano attivamente a questa trasmissione genealogica. Esiste una “materia materna” fatta di assenza, un respiro che non ha forma definita. La madre che ha perso un figlio diventa una sorta di “tomba sensoriale” per lui, un luogo dove l’assenza si fa sentire. Questo respiro indistinto è, in fondo, la materia materna di cui sono fatte le immagini legate alla nostra storia.
La vita come movimento e passaggio
Infine, possiamo pensare agli esseri viventi come sospesi a quel soffio vitale. La loro forma stessa è una traccia del movimento che li anima. Questo soffio, pur essendo invisibile, si manifesta in modi concreti, come nell’amore di una madre, e mostra come la vita passi da una generazione all’altra. Ogni essere vivente è un luogo dove la vita transita; ciò che conta davvero è il movimento che permette questa trasmissione. Questo ci porta a considerare il “respiro indistinto” dell’immagine non come un’assenza totale, ma come una forma particolare di presenza.
Come si può dare concretezza a concetti come “respiro indistinto” o “materia materna dell’assenza” al di là della pura metafora, e quale evidenza ne supporta il ruolo nella trasmissione genealogica?
Il capitolo introduce concetti suggestivi ma altamente astratti, che rischiano di rimanere confinati nel regno della metafora senza un più solido ancoraggio teorico o fenomenologico. Per esplorare la possibilità di dare corpo a queste idee e comprenderne il potenziale ruolo nella trasmissione psichica o genealogica, sarebbe utile approfondire gli studi di Pierre Fédida, in particolare il suo lavoro sull’immagine e la memoria. È inoltre consigliabile esplorare la letteratura psicoanalitica sul lutto e la trasmissione transgenerazionale, così come testi di filosofia della mente o fenomenologia che trattano il rapporto tra corpo, memoria e assenza.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]