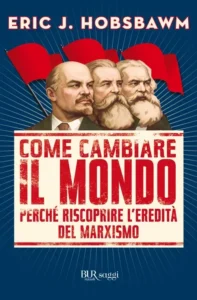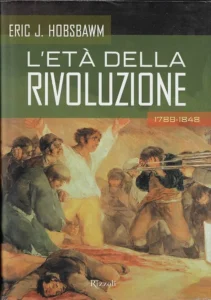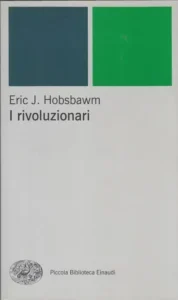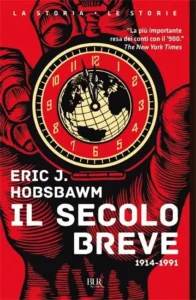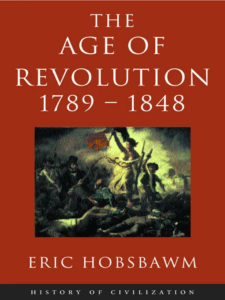Contenuti del libro
Informazioni
“Gente non comune” di Eric Hobsbawm è un libro che ti porta a scoprire chi ha davvero mosso le cose nella storia, ma non sono i soliti re o generali. Hobsbawm guarda alla storia sociale, concentrandosi su quelle figure e quei gruppi che di solito restano nell’ombra: gli umili, gli artigiani radicali come i calzolai, la classe operaia britannica che si forma tra fabbriche e pub, i contadini che lottano per la terra in posti lontani come il Perù, o anche figure più marginali come banditi e guerriglieri. Il libro esplora le loro lotte, dalla distruzione dei macchinari (il cosiddetto luddismo) alle occupazioni di terre, mostrando che dietro azioni apparentemente caotiche c’erano spesso strategie e obiettivi precisi. Non si ferma solo alla politica o all’economia del lavoro; Hobsbawm analizza anche la cultura popolare, i simboli operai come il Primo maggio, e dedica spazio a un’arte che nasce dal basso e dall’incontro di mondi diversi: il jazz, raccontando storie di musicisti come Billie Holiday. È un viaggio affascinante attraverso le vite e le azioni di chi, pur non essendo al potere, ha lasciato un segno profondo nel modo in cui viviamo e pensiamo, dimostrando come la storia sia fatta tanto dalle élite quanto dalla “gente non comune”.Riassunto Breve
La storia mostra che le persone comuni, quelle che non hanno potere o ricchezza, trovano sempre modi diversi per farsi sentire e cambiare le cose. All’inizio delle rivoluzioni, anche se gli obiettivi sembrano piccoli, c’è una grande speranza di cambiamento. Figure come Thomas Paine, che viene dal popolo, riescono a parlare per artigiani e piccoli proprietari, dicendo che la ragione e la libertà individuale possono migliorare la vita. Anche azioni che sembrano solo distruttive, come rompere le macchine nelle fabbriche, sono in realtà un modo per i lavoratori di protestare, chiedere salari migliori o difendere il loro lavoro, e a volte funzionano, almeno per un po’. Certi mestieri, come i calzolai, sono noti per avere persone molto attive politicamente, forse perché il loro lavoro permette di pensare e discutere, e le loro botteghe sono luoghi di incontro. La loro importanza diminuisce solo quando arrivano le grandi fabbriche e i partiti politici organizzati. La classe operaia, specialmente in Gran Bretagna, si forma in modo diverso a seconda delle tradizioni del paese. In Inghilterra, le idee religiose non ufficiali e le lotte per la democrazia influenzano i lavoratori a concentrarsi più sui problemi di tutti i giorni, anche se sono capaci di proteste forti. Questa classe cresce molto, si concentra nelle città e sviluppa uno stile di vita comune, con abitudini e luoghi di ritrovo che creano un senso di appartenenza. I lavoratori specializzati, gli artigiani, cercano di mantenere il loro status e il controllo sul lavoro, ma la meccanizzazione rende le loro abilità meno importanti, spingendoli a volte verso idee più radicali per difendersi. I movimenti dei lavoratori usano simboli per comunicare. All’inizio, le rivoluzioni usano immagini di donne come simbolo di libertà, ma poi, con la crescita dei movimenti operai, l’immagine principale diventa l’uomo lavoratore forte. Feste come il Primo maggio diventano importanti, nate per chiedere orari di lavoro migliori, e diventano un momento per mostrare la forza dei lavoratori e sentirsi parte di un movimento mondiale. Il rapporto tra questi movimenti e l’arte è complicato; a volte si avvicinano, a volte si allontanano, ma l’arte popolare e il design possono essere influenzati dalle idee socialiste. Anche i contadini, che vivono spesso isolati, hanno le loro forme di lotta. La loro politica riguarda i rapporti con chi sta fuori dal loro villaggio e li sfrutta. Spesso aspettano il momento giusto, quando il potere sembra debole, per agire. Un’azione tipica è occupare le terre che sentono appartenergli per tradizione, anche se la legge non lo riconosce. Esempi da paesi lontani mostrano quanto siano tenaci. A volte, l’arrivo di persone da fuori, come studenti o lavoratori emigrati, aiuta a organizzare meglio queste lotte. Queste azioni possono portare a grandi cambiamenti, ma spesso l’obiettivo dei contadini è solo riprendersi quello che pensano sia loro, non cambiare tutta la società. Ci sono anche forme di lotta meno tradizionali. Figure come i banditi che hanno un po’ di appoggio popolare mostrano come il sostegno della gente possa dare forza a chi è ai margini, anche se poi vengono usati da altri poteri. La guerriglia moderna è diversa: si basa su un grande appoggio della popolazione e su richieste di giustizia e indipendenza. Non si vince con le armi, ma politicamente, perché attaccare i guerriglieri significa attaccare la gente che li nasconde, e questo aumenta il sostegno per i ribelli. Anche grandi potenze hanno difficoltà a sconfiggere la guerriglia. I movimenti sociali improvvisi, come le proteste studentesche che portano a scioperi enormi, mostrano che la mobilitazione di massa può creare problemi al potere, anche se poi manca un piano chiaro per il futuro. La violenza stessa non è sempre uguale; ci sono regole non scritte anche dove sembra esserci molta violenza. Nelle società moderne, dove la violenza diretta è meno comune, si perde la capacità di distinguere i tipi di violenza, e questo può indebolire il controllo. Aumentano sia vecchie forme di violenza che nuove, che a volte non hanno un vero scopo politico. Non è vero che i movimenti rivoluzionari portano sempre a una maggiore libertà sessuale; spesso, anzi, sono piuttosto severi su questi temi. Anche la creazione artistica può venire da contesti non tradizionali. Il jazz, per esempio, nasce dalle comunità nere e dagli intrattenitori, e si crea insieme, non solo scrivendo musica. Musicisti come Count Basie o Duke Ellington lavorano con le loro orchestre come se fossero un unico strumento, creando musica attraverso la collaborazione e l’improvvisazione. Figure come Sidney Bechet mostrano l’importanza della voce individuale. Il jazz si diffonde in Europa non solo come musica da ballo, ma come qualcosa di nuovo e moderno, legato all’America. Il suo successo è influenzato da cambiamenti sociali, come l’emancipazione delle donne. Negli Stati Uniti, diventa musica popolare con lo swing, anche grazie a chi promuove l’integrazione razziale. Poi arriva il rock’n roll che conquista i giovani, e il jazz torna a essere di nicchia, anche se continua a influenzare e a cercare di non diventare solo musica vecchia. L’incontro tra continenti ha effetti profondi. La vita di artisti come Billie Holiday, segnata dalla sofferenza, mostra come l’arte possa trasformare il dolore in qualcosa di unico. L’America ha cambiato l’Europa non tanto con la sua cultura alta all’inizio, ma con le cose semplici: piante come patate e mais che hanno nutrito milioni di persone, o prodotti come tabacco e cioccolato che hanno cambiato le abitudini. E la musica popolare americana, come il jazz, conquista l’Europa molto prima della cultura ufficiale. Questo mostra che l’influenza può viaggiare in modi inaspettati, spesso dal basso verso l’alto o attraverso scambi culturali non controllati dalle élite.Riassunto Lungo
1. La ribellione degli umili e l’artigiano pensante
Le rivoluzioni, anche quando si pongono obiettivi limitati, accendono sempre l’attesa di un cambiamento profondo. Persone come Thomas Paine incarnano questo desiderio. Pur proponendo riforme politiche ed economiche moderate, basate sulla ragione e sull’interesse personale, Paine, un autodidatta che veniva dal mondo del lavoro, ebbe un enorme successo sostenendo la ribellione. Parlava a nome di artigiani e piccoli proprietari che vedevano nella libertà e nell’iniziativa individuale la strada per lasciarsi alle spalle la povertà e le ingiustizie causate dai privilegi. La sua forza stava nel suo sostegno aperto alla causa delle persone semplici e nella sua fiducia che la ragione potesse davvero cambiare il mondo.
La distruzione dei macchinari come forma di lotta
Distruggere i macchinari, spesso visto come un gesto irrazionale, era in realtà una forma di lotta usata dai lavoratori prima e all’inizio dell’era industriale. Non significava sempre essere contro la tecnologia in sé, ma era un modo per fare pressione sui datori di lavoro. Serviva a ottenere aumenti di stipendio o a mantenere un certo controllo sul mercato del lavoro. Questa strategia, usata da vari gruppi come i lavoratori tessili e i minatori, si dimostrò efficace nel breve periodo. Offriva ai lavoratori un vantaggio e obbligava i proprietari a considerare i rischi per i loro beni. La resistenza alle macchine non era un rifiuto totale e a volte trovava l’appoggio anche di piccoli imprenditori spaventati da un progresso senza freni. Il sostegno del governo agli imprenditori che innovavano fu fondamentale per superare questa opposizione.
Il radicalismo dei calzolai
Tra gli artigiani, i calzolai si distinguevano per le loro idee politiche e intellettuali molto avanzate. La loro fama di pensatori e agitatori tra la gente comune esisteva già prima dell’industria. Le condizioni del loro lavoro favorivano questa caratteristica: il lavoro da seduti incoraggiava la lettura e la riflessione, i viaggi dei lavoratori esperti portavano nuove idee, e le botteghe erano luoghi di incontro e discussione. La loro relativa indipendenza economica, dovuta al fatto di servire clienti per lo più poveri, permetteva loro di esprimere liberamente le proprie opinioni. Inoltre, lo status umile del mestiere poteva alimentare un senso di ingiustizia che sfociava in posizioni radicali. I calzolai spesso diventavano guide e figure intellettuali nelle campagne e nelle città di provincia, diffondendo idee radicali e organizzando proteste. Questo ruolo divenne particolarmente importante tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, con la diffusione di nuove idee non religiose e l’aumento dei lavoratori che diventavano quasi operai nel settore. Con l’arrivo della grande industria e la nascita dei grandi partiti socialisti, il ruolo centrale dei calzolai radicali diminuì.
Davvero la distruzione dei macchinari, per quanto tatticamente efficace nel breve termine, può essere definita una strategia “razionale” nel contesto più ampio della trasformazione industriale e sociale?
Il capitolo presenta la distruzione dei macchinari come una forma di lotta razionale, efficace per ottenere vantaggi immediati. Tuttavia, la razionalità di un’azione non si misura solo sulla sua efficacia contingente, ma anche sulla sua sostenibilità, sulle sue implicazioni etiche e legali, e sulla sua capacità di affrontare le cause profonde del conflitto. Il capitolo stesso ammette che questa strategia fu superata dal sostegno governativo all’innovazione, suggerendo i suoi limiti strutturali. Per comprendere meglio la complessità di questo fenomeno, è utile approfondire la storia economica e sociale dell’industrializzazione, la storia del movimento operaio e le teorie sul cambiamento tecnologico. Autori come E.P. Thompson o Karl Polanyi offrono prospettive fondamentali su queste dinamiche e sul contesto in cui tali forme di protesta ebbero luogo, permettendo di valutare la “razionalità” non solo come tattica di breve periodo, ma anche in relazione agli obiettivi a lungo termine e alle forze storiche in gioco.2. La Formazione del Proletariato Britannico e le Sue Peculiarità
Le tradizioni storiche nazionali modellano profondamente i movimenti dei lavoratori. In Francia, una forte tradizione rivoluzionaria e laica ha orientato il movimento operaio verso obiettivi politici, puntando alla conquista del potere. Al contrario, in Gran Bretagna, le radici affondano nelle tradizioni radical-democratiche e soprattutto nel dissenso religioso, in particolare il Metodismo. Questo ha portato a un movimento più concentrato su rivendicazioni economiche e sociali, pur mantenendo una capacità di radicalismo. La tradizione religiosa si è dimostrata più flessibile e adattabile rispetto a quella rivoluzionaria, che per sua natura implica un appello diretto all’azione e al rovesciamento delle autorità esistenti.La classe operaia “tradizionale”: 1870-1914
La classe operaia britannica assume la sua fisionomia “tradizionale” nel periodo tra il 1870 e il 1914. In questi anni, si assiste a un notevole aumento della sua consistenza numerica e della sua concentrazione geografica, favorita dalla crescita esponenziale delle città industriali e dalla nascita di grandi complessi produttivi. La composizione interna della classe si modifica, con un incremento significativo di figure come minatori e ferrovieri, e un timido ingresso delle donne in nuovi settori industriali. Il confronto tra lavoratori e datori di lavoro si sposta sempre più sul piano nazionale. L’estensione progressiva del diritto di voto trasforma la politica in un fenomeno di massa, elevando il concetto di “Labour” a un ruolo di crescente importanza nel dibattito pubblico e politico.Vita quotidiana e identità di classe
Diversi elementi contribuiscono a definire il tenore di vita e a forgiare un’identità comune per la classe operaia. Il calo del costo dei beni essenziali migliora il potere d’acquisto, mentre lo sviluppo di un ampio mercato interno di prodotti di consumo di massa rende accessibili nuovi beni e servizi. La costruzione di quartieri specifici per i lavoratori favorisce una crescente segregazione abitativa, ma al contempo rafforza i legami comunitari. Emergono uno stile di vita condiviso e abitudini comuni, come la passione per il calcio e le vacanze al mare, che diventano simboli di un’identità nazionale di classe, distinguendola dalle altre fasce sociali.Il ruolo e il declino dell’artigiano specializzato
Una figura centrale con radici profonde nel passato preindustriale è il lavoratore manuale specializzato, l’artigiano. Questo gruppo sociale si impegna strenuamente per preservare il proprio status, difendendo il sistema dell’apprendistato e rivendicando il controllo diretto sul processo lavorativo e sugli strumenti del mestiere. La loro forza deriva dalla convinzione, spesso fondata, che le loro competenze siano insostituibili per il funzionamento della produzione. Sebbene inizialmente riescano ad adattarsi al nascente capitalismo industriale, la loro posizione viene seriamente minacciata alla fine del XIX secolo dalla diffusione della meccanizzazione e dai processi di dequalificazione del lavoro. Questa pressione spinge alcuni artigiani verso posizioni più radicali, interpretando la lotta di classe come l’unica via per difendere i propri diritti acquisiti e il proprio status sociale. Tuttavia, la loro difesa si basa prevalentemente su metodi tradizionali legati al controllo del mestiere, piuttosto che sull’adozione di nuove strategie sindacali più adatte al contesto industriale in evoluzione. La progressiva diminuzione delle opportunità di apprendistato e la perdita del legame diretto tra abilità specifiche e livello di reddito segnano inesorabilmente il declino di questo strato sociale, che non riesce più a riprodursi e a mantenere la sua posizione come nelle epoche precedenti.Ma davvero la tradizione religiosa britannica fu intrinsecamente più “flessibile” e adattabile di quella rivoluzionaria francese, o questa è una semplificazione eccessiva?
Il capitolo pone un forte contrasto tra le radici del movimento operaio in Gran Bretagna e in Francia, suggerendo che la tradizione religiosa britannica abbia favorito un approccio più pragmatico e meno incline al rovesciamento rispetto alla tradizione rivoluzionaria francese. Questa distinzione, pur interessante, rischia di sottovalutare il radicalismo presente in alcune correnti del dissenso religioso britannico e di non considerare le componenti economiche e sociali che pure alimentarono le spinte rivoluzionarie in Francia. Per una comprensione più sfumata, sarebbe utile esplorare in maggiore dettaglio le diverse correnti all’interno di entrambe le tradizioni e il modo in cui interagirono con le specifiche condizioni materiali dei lavoratori. Approfondire la storia comparata dei movimenti sociali e le opere di storici del lavoro può aiutare a cogliere la complessità di queste influenze.3. Simboli e Rituali della Classe Operaia
Le immagini usate dai movimenti operai e socialisti cambiano nel tempo, specialmente nel modo di rappresentare uomini e donne. Nelle rivoluzioni di metà Ottocento, si usavano figure femminili simboliche, spesso poco vestite, per rappresentare il popolo che lotta per la libertà, come si vede in certi quadri famosi. Quando i movimenti operai e socialisti crescono alla fine dell’Ottocento, l’immagine della donna cambia: viene rappresentata più vestita, simbolo di sofferenza o di speranza per un futuro migliore, ma non più come protagonista dell’azione diretta. La figura centrale diventa l’uomo lavoratore. Viene spesso mostrato a torso nudo, muscoloso, per simboleggiare la forza del lavoro manuale, anche se non tutti gli operai erano così. Questo cambiamento, che rende l’immagine sempre più maschile, riflette come il lavoro nelle fabbriche fosse diviso e come gli uomini avessero un ruolo più visibile nelle proteste e negli scioperi.La festa del Primo Maggio
Il Primo maggio diventa un giorno molto importante per il movimento operaio. Nasce da un’idea del 1889 di organizzare una protesta mondiale per chiedere la giornata lavorativa di otto ore. Scegliere il primo maggio, che era un giorno lavorativo, e fare sciopero quel giorno diventa un modo per i lavoratori di mostrare la loro forza e la loro libertà. Questa festa prende subito significati legati alla primavera e alla speranza. Coinvolge intere famiglie e diventa un simbolo forte dell’identità di chi lavora e della solidarietà tra i lavoratori di tutto il mondo.Socialismo e Arte: Un Rapporto Complicato
Il legame tra il socialismo e i movimenti artistici nuovi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è complesso. All’inizio c’è un certo avvicinamento, soprattutto con la scrittura che racconta la realtà e con i movimenti che uniscono arte e artigianato, che influenzano anche le immagini socialiste. Artisti e intellettuali che si sentono ribelli spesso trovano idee simili nel movimento operaio. Però, quando i partiti socialisti diventano più organizzati e i movimenti artistici vanno verso l’arte astratta e che parla più del sentire personale, il legame si indebolisce. Chi studia le idee di Marx fa fatica a capire queste nuove forme d’arte, a volte vedendole come segno di una società borghese in crisi, mentre gli artisti si allontanano da un movimento che vedono come troppo concentrato sugli aspetti pratici o troppo moralista. Nonostante questo, il socialismo continua a influenzare l’arte in campi come l’architettura e il design, specialmente grazie alle idee di William Morris.È sufficiente l’etichetta di “americano” per spiegare il successo globale del jazz?
Il capitolo, nel tentare di spiegare il vasto successo globale del jazz, sembra concentrarsi eccessivamente sulla sua percezione come musica “americana” e simbolo di modernità. Questa visione rischia di trascurare gli elementi musicali intrinseci del jazz, la sua capacità di adattamento e fusione con culture locali, e le specifiche dinamiche sociali e culturali che ne hanno favorito la diffusione e l’accoglienza in contesti diversi. Per una comprensione più completa, sarebbe utile approfondire la musicologia e gli studi culturali, esplorando il lavoro di autori come Eric Hobsbawm o Ted Gioia, che offrono prospettive più sfaccettate sul fenomeno jazzistico globale.9. Echi dall’Oceano: Sofferenza, Ritmi e Radici che Cambiano il Mondo
La vita di Billie Holiday è stata segnata da sofferenza e autodistruzione fin dall’inizio, in un contesto difficile, proseguendo poi con traumi e dipendenze che non l’hanno mai abbandonata. Nonostante il successo che ha raggiunto e il supporto ricevuto da musicisti e intenditori del settore, la sua carriera è stata una lotta continua contro le avversità personali e professionali. La sua arte affonda le radici nel jazz e nel blues, generi che le hanno permesso di trasformare la semplice canzone popolare in una potente espressione di passioni intense e profonde. Billie Holiday riusciva a comunicare il dolore in un modo unico e toccante, rendendolo universale attraverso la sua interpretazione. La sua voce caratteristica, sottile e un po’ roca, insieme al suo modo inconfondibile di fraseggiare le note, ha reso indimenticabili brani come “Strange Fruit”. Questa canzone, in particolare, esprime con forza un sentimento di amarezza e sottomissione di fronte alla sofferenza e all’ingiustizia.L’impatto del Nuovo Mondo
L’incontro tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, iniziato con l’arrivo di Cristoforo Colombo, ha avuto conseguenze devastanti per le popolazioni native che abitavano quelle terre. Questo contatto ha portato a conquiste territoriali e alla distruzione di culture millenarie che non hanno potuto resistere all’impatto. Tuttavia, l’influenza più significativa che il Nuovo Mondo ha esercitato sull’Europa non è arrivata attraverso i conquistatori o la cultura considerata “alta”, che per secoli ha visto le Americhe come terre dipendenti e inferiori. L’influenza più profonda e duratura si è manifestata invece attraverso le culture popolari del Nuovo Mondo e, soprattutto, grazie allo scambio di prodotti agricoli e risorse naturali che hanno attraversato l’oceano.Piante originarie delle Americhe, come patate, mais, manioca e patata dolce, sono diventate con il tempo alimenti fondamentali a livello globale. Hanno rivoluzionato le diete e i modi di vivere delle persone in Europa e in molte altre parti del mondo, contribuendo a sostenere la crescita demografica. Anche altri prodotti, come il tabacco, il cioccolato, il chinino (usato in medicina) e le arachidi, hanno introdotto nuove abitudini di consumo e importanti apporti medici nella società europea. Questi elementi, che gli europei hanno imparato a conoscere e hanno adottato dalle società indigene con cui sono venuti a contatto, hanno trasformato il Vecchio Mondo in modi del tutto imprevedibili e hanno lasciato un segno indelebile nella sua storia.
Mentre la cultura americana considerata “superiore” o d’élite ha impiegato molto tempo per affermarsi e influenzare l’Europa, la cultura popolare proveniente dal Nuovo Mondo ha avuto un impatto rapido e immediato. In particolare, musica e danze come il tango e il ragtime hanno conquistato il continente europeo fin dall’inizio del Ventesimo secolo, diffondendosi rapidamente tra la gente comune. Questo dimostra come l’influenza del Nuovo Mondo sul Vecchio si sia esercitata in modo preponderante attraverso elementi popolari, spesso legati a tradizioni anonime e diffuse tra la popolazione. Questo processo contrasta nettamente con l’impatto culturale che l’Europa ha avuto sul Nuovo Mondo, un’influenza che si è esercitata principalmente attraverso le classi dirigenti, i governanti e le istituzioni imposte dai colonizzatori.
Come si legano la sofferenza individuale di Billie Holiday e l’impatto globale delle patate?
Il capitolo presenta due argomenti distinti senza esplicitare a sufficienza il filo conduttore che li lega sotto il titolo comune. La narrazione della vita e dell’arte di Billie Holiday, incentrata sulla sofferenza e le radici nel jazz e nel blues, è giustapposta all’analisi dell’influenza del Nuovo Mondo sull’Europa tramite prodotti agricoli e cultura popolare. Per comprendere meglio come questi elementi si connettano, è utile approfondire la storia della diaspora africana e l’origine del jazz e del blues come espressioni culturali nate dall’esperienza della schiavitù e del post-schiavismo nelle Americhe. Questo contesto può gettare luce su come la sofferenza individuale e collettiva si trasformi in forme artistiche che, come la musica popolare, attraversano l’oceano e influenzano il Vecchio Mondo. Per approfondire, si possono consultare opere sulla storia culturale e sociale della musica afroamericana, come quelle di Amiri Baraka.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]