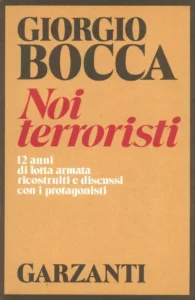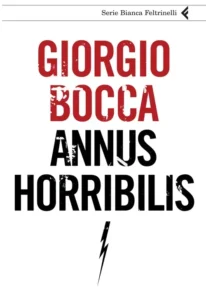1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Fratelli coltelli. 1943-2010. L’Italia che ho conosciuto” di Giorgio Bocca è un affresco potente e personale di quasi settant’anni cruciali della storia d’Italia. Partendo dalla drammatica caduta del fascismo e dalla nascita della Resistenza italiana, il libro ci guida attraverso il difficile dopoguerra e il rapido, spesso caotico, miracolo economico italiano che ha trasformato la società con migrazioni interne e nuove industrie, non senza contraddizioni. Si addentra poi negli Anni di piombo, analizzando le origini e l’escalation della violenza politica, il terrorismo delle Brigate Rosse e il tragico sequestro Aldo Moro, visto come culmine di tensioni profonde. Bocca esplora anche le trasformazioni economiche, l’evoluzione della Mafia in Italia, sempre più legata al potere e spietata, e l’emergere di forze politiche nuove come la Lega Nord, sintomo di un paese in cambiamento. Infine, affronta la figura centrale e controversa di Berlusconi politica, analizzando il suo impatto sul sistema democratico. È un viaggio appassionato attraverso la storia politica e sociale italiana, raccontata con lo sguardo critico e diretto di chi l’ha vissuta in prima persona.Riassunto Breve
La crisi del regime fascista arriva con le sconfitte in guerra e la stanchezza del paese. Dopo lo sbarco in Sicilia, i capi fascisti chiedono a Mussolini di ridare i poteri al re. Il Gran Consiglio vota contro Mussolini il 24 luglio 1943. Il giorno dopo, il re lo fa arrestare e nomina Badoglio capo del governo. La notizia si diffonde, il fascismo scompare, ma il re e Badoglio fuggono da Roma dopo l’armistizio dell’8 settembre, lasciando il paese nel caos. Da questo sfacelo nasce la Resistenza, formata da cittadini, spesso borghesi, che si organizzano in bande dopo il collasso dell’esercito. L’occupazione tedesca è brutale, con massacri come quello di Boves. La Resistenza si organizza con capi carismatici, vivendo una vita dura ma sentendosi liberi. Intanto, a Nord, nasce la Repubblica di Salò, uno stato sotto controllo tedesco, con Mussolini che tenta riforme sociali più per propaganda che per altro. La fine arriva con la cattura e l’esecuzione di Mussolini nell’aprile 1945.Nel dopoguerra, l’Italia è distrutta ma piena di energia. C’è una grande migrazione dalle campagne alle città, trasformando l’economia da agricola a industriale. Settori come auto e gomma guidano la ricostruzione e il “miracolo economico”. Aumentano i consumi e la popolazione, ma ci sono anche problemi: mancanza di etica, squilibri tra ricchezza privata e servizi pubblici. La televisione unifica la lingua ma crea conformismo. Le città crescono velocemente, mescolando le persone ma creando anche solitudine per gli anziani. Il miracolo, aiutato dagli americani, non risolve tutto e crea nuove tensioni.Il Sessantotto inizia per cambiare la società ma diventa presto una spinta rivoluzionaria confusa. Molti giovani cercano identità, ma c’è anche autoritarismo e violenza nascosta. La lotta armata, soprattutto le Brigate Rosse, nasce da qui, vista come l’unica vera politica contro l’immobilità della sinistra ufficiale. Le BR colpiscono simboli del potere, ma faticano a capire la realtà e non hanno vero appoggio operaio. Lo Stato impara a combatterli. Il sequestro Moro nel 1978 è il loro momento più alto, ma segna anche l’inizio della fine. L’organizzazione cresce ma perde coesione. I processi mostrano una società impaurita e divisa.L’industria cambia con l’automazione, le macchine sostituiscono gli operai per essere più competitive. Anche l’agricoltura usa tecnologia, creando nuove figure come il manager-contadino, anche se a volte resta un legame personale con la terra o gli animali. Intanto, la mafia cambia, diventa più moderna e violenta, legata alla droga e al controllo delle città. Fa guerre interne sanguinose, usa l’usura e il pizzo, controlla gli appalti e la politica, creando sfiducia nello Stato. La lotta contro la mafia è difficile per l’omertà e i legami politici.Nel Sud, specialmente in Calabria, il potere mafioso è ancora forte. Ci sono sequestri, villaggi sotto controllo criminale dove la gente non parla. La mafia si infiltra nelle istituzioni, influenzando le elezioni e legandosi a politici tradizionali. Nonostante qualche sviluppo, mafia e corruzione bloccano la crescita. In questo quadro di crisi dei vecchi partiti e malcontento, nasce la Lega Nord. Prende voti al Nord, dicendo no al centralismo e volendo più autonomia. Usa un linguaggio semplice, diverso dai vecchi politici. La Lega è vista come una reazione ai problemi del paese, non la causa, e mette in crisi i partiti storici.Una figura politica importante, chiamata “Il Cavaliere”, mostra un modo di gestire il potere basato sull’idea di avere sempre ragione e che chi non è d’accordo sbaglia. Questo si vede sia negli affari che nella gestione della sua squadra di calcio, dove critica e allontana gli allenatori che non fanno esattamente come vuole lui. In politica, chi non si allinea viene punito. I media a lui vicini dicono che i datori di lavoro sono buoni e i lavoratori ingrati. Chi ha successo grazie a lui deve essergli grato e obbedire. A differenza di altri potenti che agiscono di nascosto, lui dice apertamente di usare potere e soldi contro chi lo critica. Ha chiesto di allontanare giornalisti dalla televisione pubblica. Anche se usa le parole più della violenza, non perdona chi si oppone e vuole che la punizione sia visibile. Questo comportamento si inserisce in una “democrazia autoritaria”, dove chi vince le elezioni pensa di poter fare quello che vuole, anche contro la Costituzione. A differenza dei vecchi partiti nati dalla Resistenza che difendevano la democrazia, “Il Cavaliere” attacca la libertà di stampa, la magistratura e l’opposizione. Dalla sua entrata in politica, ha sempre criticato e preso in giro il sistema democratico. Tra “Il Cavaliere” e la democrazia parlamentare c’è una profonda incompatibilità.Riassunto Lungo
1. La fine del regime e la fuga
La crisi del regime fascista diventa sempre più profonda. Le cause sono le sconfitte subite in guerra, sia in Africa che in Russia. A questo si aggiunge la situazione difficile all’interno del paese: i bombardamenti, la mancanza di cibo e la stanchezza generale della popolazione. L’arrivo delle truppe alleate in Sicilia nel luglio 1943 segna l’inizio dell’attacco finale contro l’Italia.Il voto del Gran Consiglio
Di fronte a questa situazione critica, alcuni capi fascisti, guidati da Dino Grandi, decidono di agire. Chiedono a Mussolini di convocare il Gran Consiglio, l’organo più importante del regime, per restituire i poteri al re e cercare un modo per uscire dalla guerra. La riunione si tiene il 24 luglio a Palazzo Venezia e dura molte ore. Durante la discussione, figure importanti come Grandi, Ciano e Bottai criticano apertamente come è stata condotta la guerra e la dittatura di Mussolini. Mussolini cerca di difendersi, ma le sue argomentazioni sono deboli e attribuisce gli errori ad altri. Alla fine della discussione, viene messo ai voti un documento, chiamato ordine del giorno Grandi. Questo documento chiede al re di riprendere il controllo completo delle forze armate e di tutte le decisioni più importanti. La votazione si conclude con una netta maggioranza a favore della mozione: diciannove voti a favore, sette contrari e un astenuto.L’arresto di Mussolini
Il giorno dopo, il 25 luglio, Mussolini si presenta a Villa Savoia per il suo incontro settimanale con il re Vittorio Emanuele III. Il re lo informa di aver deciso di accettare le sue dimissioni. Gli comunica anche di aver già nominato Pietro Badoglio come nuovo capo del governo. Appena uscito dalla villa, Mussolini viene fermato dai carabinieri. L’arresto avviene su ordine diretto del sovrano. Mussolini viene fatto salire su un’ambulanza e portato via.Il nuovo governo e la reazione in Italia
La notizia della caduta di Mussolini si diffonde gradualmente nel paese. Il partito fascista e la sua milizia si sciolgono molto velocemente, quasi senza resistenza. Alla radio, il generale Badoglio annuncia la formazione del nuovo governo. Subito dopo, il re comunica di aver assunto il comando supremo delle forze armate e dichiara che la guerra continuerà.La reazione della Germania
La Germania, alleata dell’Italia, reagisce con preoccupazione alla caduta di Mussolini. Hitler vede questo evento come una minaccia diretta. Incontra alcuni fascisti rimasti fedeli, come Giovanni Preziosi e Roberto Farinacci. Li considera possibili leader per un futuro governo italiano che sia alleato della Germania.L’armistizio e la fuga del Re
L’8 settembre, viene diffusa la notizia che l’Italia ha firmato un armistizio con gli Alleati. Questo accordo segna la fine delle ostilità tra l’Italia e le forze alleate. Il giorno seguente, il re, la corte e i capi militari decidono di lasciare Roma. Fuggono verso Brindisi, una città che è già sotto il controllo delle truppe alleate. Questa fuga viene vista da molti come un atto di abbandono del paese in un momento cruciale. Rivelerà l’incapacità della monarchia di affrontare la crisi e guidare la nazione.Il capitolo giudica la fuga del Re come un atto di abbandono, ma non considera il caos seguito all’annuncio dell’armistizio?
Il capitolo descrive la fuga del Re e della corte, presentandola come prova di incapacità. Tuttavia, la narrazione non approfondisce sufficientemente il contesto drammatico e caotico dell’8 settembre, quando l’annuncio dell’armistizio colse impreparati l’esercito e il paese, senza ordini chiari su come reagire all’inevitabile reazione tedesca. Comprendere la gestione fallimentare dell’armistizio è fondamentale per valutare le decisioni prese dalla monarchia e dai vertici militari in quelle ore decisive. Per un’analisi più completa, è utile consultare studi storici specifici su questo periodo, come quelli di Renzo De Felice o Elena Aga Rossi, che analizzano in dettaglio la crisi dello Stato e delle forze armate nel settembre 1943.2. Settembre ’43: Dallo Sfacelo alla Resistenza
Dopo l’8 settembre 1943, l’esercito italiano si sfalda. Molti militari rifiutano di continuare a combattere o di unirsi a formazioni irregolari. È in questo caos che cittadini comuni, spesso provenienti dalla borghesia, iniziano a organizzarsi in bande. Nasce così quella che può essere definita una “guerra di borghesi” o di cittadini. L’occupazione tedesca si manifesta fin da subito con estrema violenza. Un esempio terribile è il massacro di Boves, compiuto dalle SS del maggiore Peiper. Questo evento brutale rivela la ferocia inaspettata del conflitto e insegna la dura realtà della guerra totale.La vita nella Resistenza
Per chi la vive, la guerra partigiana rappresenta un periodo di libertà dai legami sociali e familiari. È vista quasi come una “splendida, lunga vacanza”, dove i doveri vengono scelti liberamente. La politica in questo contesto non è teorica, ma molto pratica, legata al controllo del territorio e al rapporto con la popolazione locale, che viene definita “zona grigia”. Le diverse idee politiche delle formazioni, come liberali e comunisti, convivono in una sorta di confusione, con le differenze più profonde rimandate a dopo la fine della guerra.L’organizzazione e la crescita
La Resistenza si struttura attorno a figure di comandanti molto carismatici. Nomi come Bisagno, Mauri e Barbato diventano così importanti da dare il nome alle loro stesse formazioni. Questi capi provengono da ambienti diversi e hanno stili di comando differenti, ma riescono a guidare le bande in un contesto di vita quotidiana estremamente difficile, segnato da privazioni e disagi. L’estate del 1944 segna un momento di grande espansione. I partigiani estendono il loro controllo su ampie zone delle valli, creando infrastrutture e stabilendo contatti con gli Alleati. Questa fase genera un forte senso di euforia e la sensazione di essere vicini alla vittoria.La Repubblica di Salò
Mentre la Resistenza cresce, nel nord Italia si forma la Repubblica Sociale Italiana, nota come Repubblica di Salò. Questo stato si configura fin da subito come un governo fantoccio, completamente sotto il controllo dei tedeschi. Le annessioni territoriali decise dai nazisti nel nord-est riducono ulteriormente la sua già limitata sovranità. Il tentativo di Mussolini di rilanciare il regime attraverso la “socializzazione” delle imprese appare più che altro una mossa politica e propagandistica. Sembra voler cercare vendetta contro il capitalismo e ottenere il consenso degli operai, piuttosto che attuare una vera riforma economica. Le divisioni militari addestrate in Germania, nonostante gli sforzi, non vengono impiegate in modo significativo al fronte. La fine del regime si consuma nel caos generale e nella fuga, culminando con la cattura e l’esecuzione di Mussolini e dei suoi principali gerarchi nell’aprile del 1945.È davvero plausibile descrivere la vita partigiana come una “splendida, lunga vacanza”?
Il capitolo, nel tentativo di cogliere un aspetto della vita nella Resistenza, utilizza un’espressione che rischia di semplificare eccessivamente una realtà fatta di pericoli costanti, privazioni estreme, violenza brutale e sacrifici immani. Questa caratterizzazione sembra trascurare il peso psicologico e fisico della guerriglia, la precarietà dell’esistenza clandestina e il difficile rapporto con una popolazione spesso divisa o ostile. Per comprendere appieno la complessità dell’esperienza partigiana, è fondamentale approfondire la storia sociale della Resistenza, studiando le testimonianze dirette e le analisi di storici che hanno esplorato le dure condizioni di vita, le dinamiche interne alle formazioni e l’impatto della guerra sulla quotidianità. Autori come Santo Peli o Claudio Pavone offrono prospettive cruciali per bilanciare l’immagine idealizzata con la cruda realtà storica.3. Il Miracolo e le sue Ombre
L’Italia dopo la guerra si trova in una situazione economica molto difficile. Ci sono stati danni enormi all’industria, ai trasporti e all’agricoltura. La produzione è bassa e mancano le materie prime e le risorse necessarie. Nonostante queste grandi difficoltà, il paese dimostra una forte energia e una grande voglia di cambiare.La Grande Migrazione Interna
In questo periodo, molte persone si spostano dalle campagne verso le città. Questo movimento svuota le zone rurali e trasforma l’economia da agricola a industriale. La gente lascia la vita faticosa dei campi per cercare condizioni migliori nelle città e nelle aree industriali del Nord, come Torino, Carpi e Milano.Il Miracolo Economico
La ripresa economica è spinta da settori come l’industria automobilistica, la produzione di gomma e la benzina. Questo grande progresso economico, chiamato “miracolo”, porta a un aumento dei consumi e della popolazione. Allo stesso tempo, diminuisce il numero di morti.Le Contradizioni dello Sviluppo
Tuttavia, questa crescita rapida e disordinata mostra anche dei lati negativi. Manca un’etica diffusa e c’è confusione tra diversi tipi di capitalismo, come le grandi industrie e le piccole imprese. Inoltre, c’è uno squilibrio tra ciò che le persone comprano per sé (consumi privati) e i servizi per tutti (consumi sociali).I Cambiamenti Sociali e Culturali
La televisione diventa molto importante. Aiuta a diffondere una lingua e una cultura comuni in tutta Italia, ma porta anche a un certo conformismo. Nelle città che crescono velocemente, come Milano, si mescolano persone di diverse provenienze e si perdono le vecchie identità locali. Sorgono anche nuovi problemi, per esempio gli anziani vengono spesso messi da parte, visti come un peso in una società che pensa soprattutto alla produzione.Le Ombre del Miracolo
Il miracolo economico è stato reso possibile anche grazie all’aiuto degli Stati Uniti. Nonostante la crescita, non tutti i problemi vengono risolti e si creano nuove differenze sociali e tensioni. Si vedono ancora episodi di violenza nelle campagne, legati a situazioni difficili e arretrate. Le decisioni economiche e politiche prese in quel periodo, influenzate anche dalla situazione internazionale, preparano il terreno per futuri squilibri.È davvero sufficiente presentare l’ascesa della Lega Nord come una semplice ‘reazione’ ai problemi del Sud e alla crisi dei partiti storici?
Il capitolo descrive efficacemente la crisi dei partiti tradizionali e i gravi problemi legati alla criminalità organizzata nel Sud, ponendo l’ascesa della Lega Nord come una conseguenza di questo scenario. Tuttavia, l’analisi potrebbe beneficiare di un maggiore approfondimento sulle dinamiche specifiche che hanno permesso a un movimento con una forte identità territoriale di affermarsi su scala nazionale, al di là della generica insoddisfazione. Per comprendere meglio questo complesso fenomeno, sarebbe utile esplorare la sociologia del consenso politico nel Nord Italia in quel periodo e le strategie comunicative e organizzative del nuovo movimento. Approfondire gli studi di politologi che si sono occupati della transizione politica italiana e della nascita di nuove forze partitiche, come ad esempio Ilvo Diamanti o Gianfranco Pasquino, può offrire prospettive più sfaccettate.7. Il Padrone e l’Incompatibilità Democratica
Il Cavaliere si mostra in pubblico come una persona trasparente, convinta di avere sempre ragione e di essere leale. Al contrario, ritiene che gli altri siano in errore o non degni di fiducia. Questo modo di fare si vede sia quando parla di politica che quando gestisce la sua squadra di calcio, il Milan.Come tratta chi non è d’accordo
Gli allenatori del Milan, come Leonardo, Sacchi e Ancelotti, sono stati criticati e allontanati. Non è successo perché non ottenevano risultati, ma perché non soddisfacevano il suo desiderio, a volte irragionevole, di vincere spendendo poco. Oppure venivano accusati di “testardaggine”, un giudizio che sembra leggero ma che segna la fine del loro rapporto. Il Cavaliere crede di saper fare meglio di loro, dicendo che “l’allenatore dovrei farlo io”. Questo schema si ripete in politica. Chi lavora per lui o collabora e non si allinea viene punito. Invece, i suoi desideri, anche quelli che sembrano capricci, vengono accettati.L’uso dei media e la punizione pubblica
Le informazioni che dipendono da lui promuovono l’idea che chi dà lavoro sia un benefattore e chi lavora sia ingrato. Chi ha successo e fa guadagnare il Cavaliere deve essere obbediente e mostrare gratitudine. I mezzi di informazione che lo appoggiano diffondono falsità contro chi lo critica. A differenza di altre persone potenti che agiscono senza farsi notare, il Cavaliere dice apertamente di usare il suo potere e i suoi soldi per eliminare chi lo contraddice. Ha chiesto chiaramente alla televisione pubblica di allontanare giornalisti come Montanelli e Biagi perché mettevano in discussione il suo potere. Anche se preferisce usare le parole piuttosto che la violenza fisica, non perdona chi gli si oppone e cerca di allontanarlo dalla scena pubblica, volendo che questa punizione sia visibile a tutti.Un rapporto difficile con la democrazia
Questo modo di agire rientra in quella che si può chiamare una “democrazia autoritaria”. Qui, chi vince le elezioni crede di poter fare ciò che vuole, anche andando contro i principi della Costituzione. I grandi partiti del passato, nati dopo la Resistenza, proteggevano i diritti democratici. Il Cavaliere, invece, attacca continuamente le basi della democrazia: la libertà di stampa, i giudici (distinguendo tra quelli che considera “buoni” e quelli “politicizzati”), e chi si oppone, che definisce genericamente “comunista”. Da quando è entrato in politica, ha sempre ostacolato e preso in giro il sistema democratico. Tra il Cavaliere e la democrazia basata sul parlamento c’è una profonda differenza che rende difficile la convivenza.L’accusa di “incompatibilità democratica”, pur basata su comportamenti descritti come problematici, non rischia di semplificare eccessivamente il complesso rapporto tra leadership forte e istituzioni democratiche, ignorando le tensioni fisiologiche di ogni sistema politico?
Il capitolo descrive efficacemente un modello di leadership caratterizzato da intolleranza al dissenso e uso strumentale dei media, definendolo “democrazia autoritaria” e concludendo per una “profonda differenza” con la democrazia parlamentare. Tuttavia, l’analisi potrebbe beneficiare di un maggiore approfondimento teorico sulla natura stessa della democrazia e sulle sue possibili degenerazioni o tensioni interne. Per comprendere meglio se i comportamenti descritti configurino una vera e propria incompatibilità o piuttosto una manifestazione estrema di dinamiche presenti (seppur in forma meno accentuata) anche in altre democrazie, sarebbe utile esplorare la scienza politica, in particolare gli studi sulle forme di governo, il populismo e le teorie della democrazia. Approfondire autori come Giovanni Sartori o Robert Dahl può fornire gli strumenti concettuali necessari per distinguere tra una leadership “forte” o “problematicamente autoritaria” e una vera e propria “incompatibilità” con i principi democratici fondamentali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]