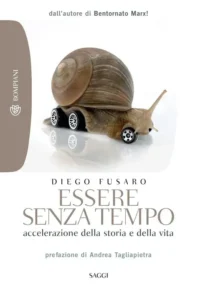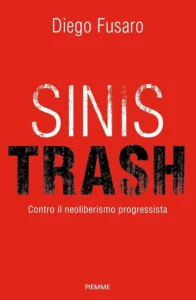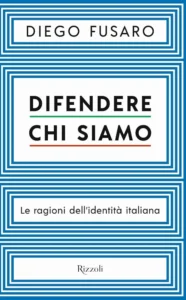Contenuti del libro
Informazioni
ti porta dentro il pensiero politico di Johann Gottlieb Fichte, mostrando che non c’è stata una vera e propria rottura, la famosa Kehre, ma un percorso unitario. Il libro spiega come la sua filosofia, la Wissenschaftslehre, sia legata a eventi come la Rivoluzione francese e veda la realtà come qualcosa che possiamo trasformare con la nostra azione, la prassi, non un destino fisso come pensano i dogmatici. Fichte vedeva lo Stato, anche quello descritto come Stato commerciale chiuso, non come un fine, ma uno strumento provvisorio per aiutare l’umanità a diventare più libera e morale, verso una comunità ideale dove lo Stato non servirebbe più. La cosa interessante è che la sua critica all’anarchia del commercio (Handelsanarchie), dove l’economia domina tutto, sembra parlare proprio della globalizzazione di oggi. Leggere Fichte, attraverso questo libro, ti fa capire che possiamo e dobbiamo usare la politica per guidare l’economia e proteggere la comunità, invece di accettare l’esistente come immutabile. È un modo per pensare in modo critico al presente partendo da un filosofo del passato.Riassunto Breve
Il pensiero politico di Fichte segue un percorso unitario, non interrotto da una svolta improvvisa. Questa filosofia è strettamente legata agli eventi storici, come la Rivoluzione francese, che sottolinea l’importanza della libertà e dell’azione umana. Fichte vede la realtà non come qualcosa di fisso, ma come il risultato dell’attività dell’Io, che può essere trasformata. L’idealismo, a differenza del dogmatismo che accetta il mondo come dato, è la filosofia della libertà perché crede nella capacità umana di cambiare la realtà per renderla più razionale. La storia è il processo in cui l’umanità si sviluppa attraverso l’azione, modificando ciò che ha creato. Lo Stato è uno strumento temporaneo per guidare l’umanità verso il progresso morale. Il suo scopo è portare gli esseri umani a vivere secondo ragione e libertà, in una comunità dove non serve più la coercizione esterna. L’obiettivo finale è l’estinzione dello Stato, quando l’umanità raggiungerà una piena autonomia morale. Questo ideale è un punto di riferimento per l’azione, anche se il perfezionamento umano è un processo continuo e infinito. La comunità è fondamentale; le persone si realizzano moralmente solo nelle relazioni con gli altri. Lo Stato serve a organizzare e proteggere questa vita comunitaria finché la ragione morale non basta a garantire l’armonia. La necessità di uno Stato forte aumenta quando l’umanità è lontana dalla moralità, come nell’epoca dominata dall'”anarchia del commercio”. Questa anarchia è una situazione in cui l’economia diventa autonoma, basata sull’egoismo e sul profitto illimitato, sottomettendo la politica e dissolvendo la comunità. Il mercato globale crea disuguaglianze, sfruttamento e conflitti. Di fronte a questo, lo Stato commerciale chiuso interviene per riaffermare il primato della politica sull’economia. Il suo compito è garantire l’etica sociale, proteggere il diritto al lavoro e alla proprietà come mezzi di sussistenza, e assicurare l’esistenza a tutti. Questo Stato è uno strumento per la moralizzazione, necessario finché l’umanità non agisce per ragione. La chiusura commerciale serve ad arginare la forza distruttiva del profitto e dell’egoismo. Lo Stato deve garantire a ognuno ciò che gli spetta, assicurando il diritto al lavoro e ai mezzi per vivere prima di proteggere la proprietà già esistente, che spesso genera disuguaglianze. L’economia deve essere regolata dalla politica, pianificando produzione e distribuzione per soddisfare i bisogni di tutti ed evitare l’accumulo eccessivo di ricchezza. Il commercio estero deve essere bloccato per impedire sfruttamento e disuguaglianze globali, mantenendo il controllo politico sull’economia interna. Anche la moneta è uno strumento statale, il cui valore è deciso dallo Stato, non dal mercato. Questo controllo impedisce all’economia di diventare autonoma e generare squilibri. L’ideale è un equilibrio basato sulla giusta misura, dove i bisogni di tutti vengono prima del superfluo di pochi. La chiusura commerciale non è un fine, ma un mezzo per ripristinare il primato della politica e preparare le condizioni per un’umanità unificata dalla ragione e dalla cultura. Lo Stato, anche nella forma chiusa, è sempre uno strumento per l’emancipazione umana universale, mai un fine in sé. La critica fichtiana all’anarchia commerciale anticipa le dinamiche della globalizzazione, vista come una forza disgregatrice che eroe la sovranità politica. Per proteggere la comunità, può essere necessaria una forza politica che riaffermi il controllo sull’economia.Riassunto Lungo
1. Il filo rosso del pensiero politico di Fichte
Il pensiero di Fichte segue un percorso filosofico unitario. Non c’è stata una rottura improvvisa, la cosiddetta Kehre, come si pensava un tempo, avvenuta intorno al 1800. L’idea tradizionale vedeva in quella data un passaggio da un idealismo basato sul soggetto a uno più oggettivo o spirituale. In politica, si credeva fosse un cambiamento da una visione rivoluzionaria e aperta al mondo a una più chiusa e legata allo Stato.Una visione unitaria
Oggi si comprende meglio l’unità di fondo del sistema filosofico di Fichte, la sua Wissenschaftslehre, anche se presentata in modi diversi nel tempo. Allo stesso modo, la sua filosofia politica e sociale è profondamente unitaria. Il cambiamento che si nota in opere come Lo Stato commerciale chiuso del 1800 non è una rottura, ma una rielaborazione coerente delle idee che aveva già espresso.La risposta ai cambiamenti storici
Questa rielaborazione nasce come risposta a un contesto storico e sociale che stava cambiando, in particolare per via di quella che Fichte chiamava l'”anarchia del commercio”. Per proteggere gli obiettivi di libertà umana e le conquiste politiche ottenute, Fichte adatta la sua visione. Lo Stato commerciale chiuso non contraddice l’idea che un giorno lo Stato non servirà più, ma diventa una forma necessaria in un’epoca che lui descrive come di “compiuta peccaminosità”, cioè di grandi difficoltà morali.Il ruolo dello Stato e il fine dell’umanità
L’obiettivo finale resta sempre lo stesso: portare l’umanità a essere eticamente libera e capace di darsi le proprie regole. Lo Stato funziona quindi come uno strumento di educazione, un aiuto per la debolezza umana (remedium infirmitatis). Guida le persone verso una condizione in cui la struttura dello Stato non sarà più necessaria. Questa visione si basa sull’idea fondamentale di Fichte che il fare, l’agire, è la base stessa dell’esistenza.Comunità e universalità
Il pensiero politico di Fichte può essere descritto come un “comunitarismo cosmopolitico”. Parte dalla comunità e punta a un’apertura progressiva verso l’universalità. Questo percorso si fonda sull’azione umana e sulla funzione etica che lo Stato deve avere. Lo studio dello Stato commerciale chiuso conferma questa continuità. Mostra come il cambiamento del 1800 sia servito a mantenere unito il sistema di Fichte, permettendogli di affrontare le sfide del suo tempo.Se lo Stato commerciale chiuso è un ‘remedium infirmitatis’ verso la libertà universale, come si concilia la sua chiusura con l’apertura cosmopolitica che Fichte avrebbe mantenuto come fine ultimo?
Il capitolo presenta lo Stato commerciale chiuso come una rielaborazione coerente e uno strumento temporaneo nel percorso verso la libertà etica e l’universalità. Tuttavia, la logica interna che permette a un sistema chiuso e dirigista di fungere da ponte verso l’apertura cosmopolitica e l’eventuale superamento dello Stato non è pienamente esplicitata. Come fa precisamente la “chiusura” a educare alla “libertà universale”? Per affrontare questo nodo critico, è fondamentale leggere direttamente i testi politici ed economici di Fichte del periodo, approfondire gli studi critici che analizzano la continuità o discontinuità del suo pensiero post-1800, e contestualizzare la sua proposta rispetto alle specifiche sfide economiche e politiche dell’epoca napoleonica. Un’analisi rigorosa richiede di confrontare le diverse interpretazioni storiografiche sulla cosiddetta Kehre e di esplorare le implicazioni pratiche e teoriche di un “comunitarismo cosmopolitico” che passa attraverso una fase di isolamento.2. La Scienza della Libertà e la Trasformazione del Reale
La filosofia di Fichte, in particolare la Wissenschaftslehre, non è una teoria astratta ma è profondamente legata agli eventi storici e sociali. Questa connessione è fondamentale per capirne la struttura e il significato politico. La Rivoluzione francese, in particolare, ha messo in luce l’importanza centrale della libertà umana e della nostra capacità di agire. Fichte parte proprio da qui, concependo l’Io, cioè la nostra coscienza o attività interiore, come l’origine e il creatore del mondo che percepiamo fuori di noi (il non-Io). Il non-Io, quindi, non è una realtà esterna già data e indipendente, ma è un prodotto della stessa attività dell’Io. Questo concetto rivoluzionario implica che la realtà non è fissa o determinata da un destino immutabile, ma è il risultato della nostra azione e, di conseguenza, può essere trasformata.L’Io Creatore e la Filosofia della Libertà
Questa prospettiva si contrappone nettamente al dogmatismo. Chi aderisce al dogmatismo vede il mondo come una “cosa in sé” già fatta e immodificabile, portando inevitabilmente a una visione fatalistica dell’esistenza, dove tutto sembra predeterminato. L’idealismo di Fichte, al contrario, è per eccellenza la filosofia della libertà. Nasce dall’idea che la nostra attività interiore (l’Io) è la fonte primaria e che la realtà esiste solo in quanto viene posta, cioè creata e definita, da questa attività del soggetto. Siamo noi a plasmare il mondo attraverso la nostra ragione e la nostra azione. Per Fichte, l’oggetto che percepiamo non ha un’esistenza separata e autonoma, ma dipende interamente dal soggetto che lo pensa e lo agisce.
La Storia come Trasformazione attraverso l’Azione
La storia stessa viene interpretata da Fichte alla luce di questi principi. È vista come il grande processo in cui l’umanità, intesa come un unico Io collettivo in evoluzione, si oggettiva, creando il mondo esterno e le strutture sociali (ponendo il non-Io). Ma questo processo non si ferma qui. Attraverso l’azione concreta, la prassi, l’umanità supera continuamente e trasforma queste oggettivazioni che essa stessa ha posto. Questo movimento dinamico di auto-creazione e superamento porta a una progressiva crescita dell’autocoscienza e a un avvicinamento costante del mondo reale all’ideale che l’umanità persegue. In questa visione, l’agire ha una priorità fondamentale rispetto all’essere: non siamo definiti da una realtà data, ma la creiamo con le nostre azioni. La realtà sociale in cui viviamo è il risultato della prassi passata, ma proprio per questo è sempre aperta alla possibilità di essere modificata e migliorata dall’azione umana presente e futura.
Ma davvero il mondo esterno è solo un’illusione creata dalla nostra mente?
Questa affermazione centrale del capitolo, che l’Io crei il non-Io, solleva interrogativi fondamentali. Come si concilia questa visione con la nostra esperienza quotidiana di un mondo che sembra esistere indipendentemente dalla nostra coscienza e che spesso resiste ai nostri desideri e azioni? Per esplorare questa tensione, è utile confrontare l’idealismo con altre correnti filosofiche come il realismo e il materialismo. Approfondire temi di metafisica ed epistemologia può aiutare a comprendere le diverse risposte alla domanda sulla natura della realtà. Autori come Aristotele, Locke o Marx offrono prospettive radicalmente diverse sulla relazione tra soggetto e oggetto, o tra pensiero e materia.3. Lo Stato come strumento verso la comunità morale
La comunità è fondamentale per l’esistenza umana. Non siamo esseri isolati, ma ci formiamo e diventiamo morali solo stando insieme agli altri. È attraverso i rapporti con le altre persone che impariamo e cresciamo moralmente. Vivere nella comunità ci permette di sviluppare la nostra capacità di agire in modo giusto e razionale. La moralità non è qualcosa che troviamo da soli, ma nasce e si rafforza nelle relazioni all’interno della comunità.Il ruolo dello Stato
Lo Stato serve a organizzare e proteggere questa vita di comunità. Pensiamolo come uno strumento, ma solo temporaneo, che opera per il progresso morale dell’umanità. Il suo compito è aiutare le persone a raggiungere una piena autonomia morale. Vuole guidare gli esseri razionali a vivere in una società dove contano la libertà e la ragione. Lo Stato è necessario finché le persone non sono abbastanza mature moralmente e la ragione morale non è sufficientemente sviluppata da garantire l’armonia sociale senza bisogno di forza esterna.L’obiettivo finale e l’ideale
L’obiettivo più alto per l’umanità è raggiungere una completa autonomia morale, dove le azioni sono guidate dalla ragione interna e non dalla coercizione esterna. Significa che non abbiamo più bisogno di essere costretti da regole esterne. Quando tutti vivranno in questo modo, basando le loro scelte sulla ragione e sulla libertà, la società sarà unita dalla moralità stessa. In un mondo così, dove la ragione morale guida tutti, lo Stato non avrebbe più motivo di esistere e svanirebbe, non essendo più necessario. Questa “estinzione” dello Stato è vista come un ideale, il traguardo ultimo verso cui l’umanità dovrebbe tendere.La realtà del progresso
Tuttavia, il cammino per diventare migliori non finisce mai. Il processo di perfezionamento umano è infinito, uno sforzo continuo senza una conclusione definitiva. Per questo, l’ideale di uno Stato che scompare rimane un punto di riferimento, un orientamento per l’azione. Ci indica la direzione giusta, ma non è qualcosa che vedremo accadere concretamente. La necessità dello Stato oggi dipende proprio da come siamo fatti ora, dalla condizione attuale dell’umanità. Siamo ancora lontani da quella piena moralità che ci renderebbe liberi da ogni costrizione esterna, quindi lo Stato continua a essere uno strumento indispensabile nel presente.Ma uno Stato che controlla ogni scambio commerciale e limita la circolazione dei cittadini non rischia forse di cadere in un dispotismo ben peggiore dell’anarchia che intende combattere?
Il capitolo propone una soluzione radicale all’anarchia commerciale, ma la descrizione di uno Stato che accentra il controllo economico e regola gli scambi con l’estero solleva interrogativi sulla natura della libertà individuale in un simile sistema. L’idea che le restrizioni a priori impediscano le trasgressioni non elimina il rischio di un controllo pervasivo sulla vita dei cittadini. Per comprendere meglio queste dinamiche, è utile approfondire la filosofia politica, in particolare le teorie sulla libertà e sul potere statale, e l’economia comparata, studiando i risultati storici di sistemi economici centralizzati rispetto a quelli di mercato. Autori come Hannah Arendt o Friedrich Hayek offrono prospettive critiche sul rapporto tra Stato, economia e libertà individuale.8. Lo Stato come strumento e la critica all’anarchia commerciale
Fichte pensa allo Stato puntando sempre e solo a liberare l’umanità intera. Questo obiettivo principale resta uguale in ogni fase del suo pensiero. Lo Stato, in qualsiasi forma si presenti, anche quello “commercialmente chiuso”, è sempre solo un mezzo per arrivare a questa libertà, mai lo scopo finale. Le diverse idee sullo Stato che Fichte ha avuto nel tempo sono sviluppi naturali della sua visione di come l’uomo possa liberarsi, non cambiamenti improvvisi.Lo Stato Commercialmente Chiuso e l’Anarchia del Commercio
La teoria dello Stato “commercialmente chiuso” che Fichte propone nel 1800, basata su idee che aveva già espresso, aiuta a capire meglio il mondo di oggi. La sua critica a quella che chiama “anarchia commerciale” è come una previsione di quello che vediamo con la globalizzazione. Questa anarchia non è un processo tranquillo, anzi, rompe i legami tra le persone nella comunità e rovina i valori morali. La globalizzazione si comporta come una specie di imperialismo moderno e flessibile, dove l’economia prende il sopravvento, diventa la forza più potente e toglie potere alla politica e alla capacità dei governi di decidere.La Critica di Fichte per il Presente
Il pensiero di Fichte si dimostra ancora attuale, nel senso che ne dà Nietzsche, perché offre una critica profonda dei modi di pensare che dominano oggi. Un punto fondamentale è la sua critica a chi accetta le cose come stanno senza discuterle. Per difendere i valori della comunità e i legami sociali che l’anarchia commerciale rischia di distruggere, può servire una “Staatsform”, cioè una forza politica che ridia alla comunità il potere di decidere sull’economia. Senza questa forza, le uniche strade sono l’idealismo puro o la barbarie. Anche se l’idea di Stato commercialmente chiuso non risolve direttamente i problemi che abbiamo adesso, è un ottimo spunto per analizzare in modo critico il mondo contemporaneo.Davvero le uniche alternative all’anarchia commerciale sono un forte controllo statale o la barbarie?
Il capitolo propone un bivio piuttosto netto, trascurando forse la complessità delle possibili interazioni tra Stato, mercato e società. Per una visione più articolata, sarebbe utile esplorare le diverse scuole di pensiero in economia politica e le loro proposte sul ruolo dello Stato, confrontando ad esempio le visioni di autori come Hayek o Keynes con quella qui presentata. Approfondire la storia economica e le diverse forme di regolamentazione statale nel tempo può offrire ulteriori prospettive.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]