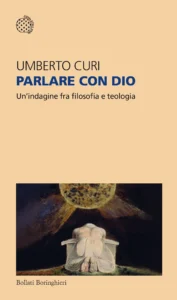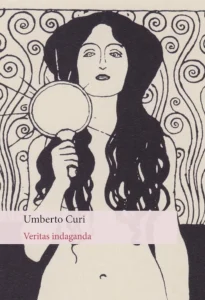1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Fedeli al sogno. La sostanza onirica da Omero a Derrida” di Umberto Curi ti porta in un viaggio pazzesco attraverso la storia del pensiero sui sogni. Non sono solo cose strane che succedono quando dormi; fin dall’antica Grecia, con Omero e filosofi come Platone e Aristotele, i sogni sono visti come segni che nascondono verità, roba che devi interpretare, non prendere alla lettera. Il libro esplora come questa idea di interpretazione dei sogni si è evoluta, passando per la medicina ippocratica che li usava per capire il corpo, fino ad Artemidoro che li ha trasformati in una vera arte, l’onirocritica. Poi si fa un salto nel mondo moderno: con Freud i sogni diventano la via maestra per l’inconscio, pieni di desideri nascosti da svelare con la psicoanalisi. Ma non è l’unica visione; il libro guarda anche come artisti come Goya o registi come Kubrick vedono i sogni, spesso intrecciati in modo inquietante con la realtà, creando un senso di perturbante. E poi c’è la filosofia più recente, con Adorno, Benjamin e Derrida, che si chiedono se si possa parlare dei sogni senza rovinarli con la logica della veglia, magari accettando la loro ambiguità e quella “possibilità dell’impossibile” che solo loro sembrano suggerire. È un’esplorazione affascinante di come i sogni ci sfidano da sempre, legandoci alla verità, all’inconscio e a modi diversi di “vedere” il mondo, anche a occhi chiusi.Riassunto Breve
I sogni sono visti come messaggi che non si capiscono subito, richiedono un lavoro per trovare il loro significato nascosto. Già nell’antica Grecia e a Roma si pensa che i sogni non parlino da soli. Si distingue tra sogni veri, che vengono da una porta di corno, e sogni falsi, da una porta d’avorio, mostrando che i sogni hanno un legame con la verità, a volte nascondendola. Questa necessità di interpretazione si trova in diversi campi. La medicina antica usa i sogni come segni per capire la salute del corpo. Platone li vede come rivelazioni dei desideri nascosti o, per chi è saggio, una via per la verità. Aristotele li chiama residui delle sensazioni. Pensatori come Artemidoro creano un metodo per interpretare i sogni, considerandola un’arte che svela il futuro o la verità. Anche un sogno che sembra ingannare ha un significato per la persona. L’indagine sui sogni riguarda temi importanti come la ricerca della verità, la condizione umana e le relazioni sociali. Il sogno è complesso, porta conoscenza ma non è chiaro subito, deve essere aperto e decifrato per mostrare il suo legame con la verità e il futuro. I sogni sono anche una strada verso l’inconscio. Freud li considera l’appagamento di un desiderio nascosto e propone un metodo per interpretarli, passando dal contenuto che appare a quello nascosto. Questo metodo cerca di dare un senso logico a ciò che nel sogno sembra assurdo. C’è anche l’idea che la realtà umana sia ambivalente. Il perturbante nasce quando qualcosa di familiare diventa strano o minaccioso. Non è l’incertezza a turbare, ma la certezza che le cose hanno una doppia natura, dove i confini si confondono. L’arte esplora questa ambivalenza. Goya mostra che l’assenza di ragione genera mostri, ma anche che la ragione stessa può creare sogni spaventosi. Alcuni autori, come Schnitzler, Fellini e Adorno, non cercano un significato nascosto nei sogni, ma li trascrivono così come sono, con la loro ambiguità, considerandoli intraducibili e legati al passato, non al futuro. Il cinema, come in “Eyes Wide Shut”, mostra come sogno e realtà siano intrecciati. Non si cerca di distinguere cosa è vero, ma si accetta che l’esperienza è ambivalente. Capire questo richiede una capacità di vedere anche con gli occhi chiusi, accettando l’enigma. L’interesse per i sogni si lega a una riflessione sul loro ruolo nella cultura e nel pensiero. Derrida, partendo da un sogno di Benjamin, si chiede se si possa parlare di un sogno senza interrompere il sonno, collegando i sogni alla filosofia. Il filosofo tradizionale, legato alla ragione, direbbe di no, mentre l’artista direbbe forse. Adorno sta in mezzo. Riconosce che insistere sulla differenza tra sogno e realtà può “ferire” i sogni. Anche i sogni belli hanno una “crepa” perché sono illusori rispetto alla realtà. Nonostante questo, si considera la “possibilità dell’impossibile”, un’idea legata a Benjamin. Significa mantenere la lucidità della veglia ma ascoltare il senso del sogno, specialmente quando suggerisce ciò che sembra impossibile. Un sogno così non si interpreta, ma si racconta. La possibilità dell’impossibile si può solo sognare, e un pensiero diverso dalla filosofia tradizionale potrebbe capirla meglio. Ci si chiede se si può parlare del sogno in modo razionale senza sottometterlo alla logica della veglia, mantenendo la sua diversità. Questo porta a pensare all’alterità. Adorno e Benjamin, con i loro scritti, suggeriscono un nuovo modo di pensare che accetta la possibilità dell’impossibile e mantiene la diversità della realtà dei sogni rispetto all’ordine razionale.Riassunto Lungo
1. Sogni: Segni, Verità e Interpretazione nel Mondo Antico
I sogni sono visti come messaggi che non si capiscono subito. Nell’antichità, sia in Grecia che a Roma, si pensava che il sogno non dicesse la verità in modo diretto. C’era bisogno di un vero e proprio “lavoro” per scoprire il suo significato nascosto. Già nell’Odissea, la regina Penelope chiede che il suo sogno venga spiegato, mostrando che il sogno non “parla” da solo. La distinzione tra sogni che vengono dalla porta di corno (veri) e quelli dalla porta d’avorio (falsi) fa capire che il sogno ha un legame con la verità, a volte la rivela e a volte la nasconde. Questa idea che il sogno vada interpretato è presente in molti ambiti.Diverse Prospettive sull’Interpretazione
La medicina di Ippocrate, ad esempio, considerava i sogni come “segni” che potevano aiutare a capire lo stato di salute del corpo; andavano analizzati con la ragione. Platone vedeva i sogni come qualcosa che poteva rivelare i desideri nascosti dell’anima, o, per le persone sagge, come un modo per arrivare alla verità, legandoli al “mythos”, un tipo di conoscenza diverso dal ragionamento logico (“logos”). Aristotele li descriveva invece come “phantasmata”, cioè resti delle sensazioni che l’anima rielabora durante il sonno. Queste diverse visioni mostrano quanto fosse centrale l’idea che il sogno, in ogni caso, non fosse chiaro di per sé ma richiedesse un’analisi.L’Arte della Decifrazione
Figure come Artemidoro hanno trasformato l’interpretazione dei sogni, chiamata onirocritica, in una vera e propria “techne”, un’arte o una tecnica precisa per svelare il significato profetico o veritiero del sogno. Anche quando un sogno poteva sembrare ingannevole o strano, si credeva che portasse comunque un significato importante che riguardava la persona che lo faceva. Decifrare il sogno diventava quindi un modo per capire meglio se stessi e il proprio destino. Questo approccio sistematico cercava di fornire regole e categorie per interpretare ogni tipo di immagine onirica.Il Sogno e i Temi Fondamentali
Studiare i sogni non era solo una curiosità, ma si collegava a domande molto importanti. Riguardava la ricerca della verità e la comprensione della condizione umana, vista come diversa da quella degli dei o degli animali (come si vede nel mito di Prometeo e l’introduzione della speranza). L’interpretazione dei sogni toccava persino aspetti sociali e politici, come nel sogno della regina persiana Atossa che sembra anticipare il conflitto tra Europa e Asia. Il sogno, quindi, era un fenomeno ricco di significati profondi, capace di riflettere sia la vita interiore che le grandi questioni del mondo.Il sogno è un fenomeno complesso, che può portare sapienza ma non è mai immediatamente chiaro. Per questo motivo, richiede sempre di essere “aperto” e decifrato per mostrare il suo legame con la verità e con ciò che accadrà in futuro.Ma questa necessità di “decifrare” il sogno per trovarvi una “verità” regge ancora oggi, o è solo un’eco di antiche credenze?
Il capitolo descrive in modo affascinante come gli antichi cercassero verità nascoste nei sogni, ma ignora completamente come la scienza moderna abbia affrontato questo fenomeno. L’idea che un sogno contenga un messaggio segreto sul destino o sulla salute è affascinante, ma si scontra con le attuali comprensioni psicologiche e neurologiche, che vedono i sogni più come processi cognitivi o fisiologici. Per capire davvero la complessità del sogno, non basta fermarsi all’antichità; è fondamentale confrontarsi con le discipline come la psicologia e le neuroscienze, esplorando autori come Freud o Jung per le prospettive interpretative, e le ricerche scientifiche che studiano il cervello durante il sonno.2. Vedere con gli occhi chiusi
I sogni sono stati visti come una porta verso l’inconscio. Freud, ad esempio, li considerava l’appagamento di un desiderio nascosto e proponeva un metodo per svelarne il significato. Questo “lavoro” di interpretazione mirava a trasformare il contenuto apparente del sogno in quello latente, riportando ciò che sembra assurdo a una logica comprensibile e razionale.Approcci diversi ai sogni
Accanto all’idea di interpretare i sogni, esiste un approccio diverso, adottato da autori come Schnitzler, Fellini e Adorno. Essi preferiscono trascrivere il sogno così come si presenta, nella sua forma ambigua e illogica. Questa pratica non cerca un significato nascosto o una traduzione razionale, ma preserva la specificità del sogno stesso. Il sogno viene visto come qualcosa di intraducibile, legato alla memoria e al passato piuttosto che a previsioni sul futuro.La realtà è ambivalente
Esiste una prospettiva che considera la realtà e l’esperienza umana come intrinsecamente ambivalenti. Il sentimento del perturbante nasce dalla scoperta che ciò che percepiamo come familiare o sicuro può rivelarsi anche estraneo o minaccioso, e viceversa. Non è tanto l’incertezza a generare inquietudine, ma la consapevolezza di questa duplicità fondamentale, dove i confini tra il nostro mondo interiore ed esteriore, tra ciò che ci è noto e ciò che non lo è, si confondono continuamente.L’arte esplora la duplicità
L’arte si addentra in questa ambivalenza. Goya, con la sua opera “Il sonno della ragione genera mostri”, illustra come l’assenza di ragione possa produrre creature spaventose. Tuttavia, l’opera suggerisce anche che la ragione stessa può dare origine a sogni mostruosi, mettendo in luce la doppia natura del “sueño”, che in spagnolo significa sia sonno che sogno. Il regista Forman, ispirandosi a Goya, riflette su come la realtà possa imitare l’arte e su come il potere, in ogni epoca, manifesti una violenza intrinseca, spesso nascosta o ambigua.Cinema e il confine labile
Il cinema esplora in profondità il confine tra sogno e realtà, mostrandoli come due piani intrecciati e spesso indistinguibili. Film come “Eyes Wide Shut” di Kubrick non cercano di stabilire una distinzione netta tra ciò che è vero e ciò che è sognato. Piuttosto, evidenziano che l’esperienza umana è di per sé costitutivamente ambivalente. Comprendere questa verità richiede una forma di visione che vada oltre la semplice percezione sensoriale, una capacità di “vedere” anche quando gli occhi sono chiusi, accettando l’enigma e la penombra che caratterizzano la nostra esistenza.Affermare che la realtà sia “intrinsecamente ambivalente” non rischia di essere una premessa filosofica non dimostrata, piuttosto che una descrizione oggettiva?
Il capitolo fonda gran parte della sua argomentazione sull’idea che la realtà e l’esperienza umana siano “intrinsecamente ambivalenti”. Sebbene questa prospettiva sia affascinante e trovi riscontro nell’arte, presentarla come un dato di fatto inconfutabile può indebolire la solidità logica del ragionamento. La natura della realtà è oggetto di dibattito millenario in filosofia, con diverse scuole di pensiero che offrono visioni radicalmente differenti. Per comprendere meglio i fondamenti di tale affermazione e le sue implicazioni, sarebbe utile approfondire discipline come la metafisica e l’epistemologia, esplorando autori che hanno affrontato il problema della percezione, della conoscenza e dei limiti della nostra comprensione del mondo.3. Il sogno tra veglia e possibilità impossibile
L’interesse per i sogni è un aspetto importante nell’esperienza di Adorno. Egli non si limita a riflettere sui propri sogni, ma ascolta con attenzione e riporta anche i sogni degli altri, come nel caso del sogno di Benjamin su Kraus. Questo interesse si lega a una riflessione più ampia sul ruolo che i sogni ricoprono nella cultura e nel pensiero. Adorno considera i sogni una dimensione significativa che merita di essere esplorata e compresa a fondo. Attraverso l’attenzione ai sogni, si aprono nuove prospettive sulla mente umana e sulla sua relazione con la realtà.La domanda di Derrida sui sogni
Jacques Derrida, nel discorso tenuto in occasione del premio Adorno, affronta il tema dei sogni partendo da un’immagine suggestiva tratta da un sogno di Benjamin: “Si trattava di trasformare una poesia in un foulard”. Da questa frase sognata, Derrida solleva questioni profonde sulla possibilità di parlare o analizzare un sogno. Si chiede se sia davvero possibile farlo senza in qualche modo interrompere o alterare lo stato onirico stesso. Per Derrida, queste domande non sono solo teoriche, ma toccano il cuore del rapporto tra l’esperienza del sogno e la possibilità stessa di farne oggetto di pensiero filosofico.Due modi di guardare al sogno
Di fronte alla sfida di parlare del sogno, emergono due approcci distinti. Il filosofo legato alla tradizione, che privilegia la ragione e la logica della veglia, tende a rispondere in modo negativo alla possibilità di cogliere l’essenza del sogno con gli strumenti razionali. Vede il sogno come qualcosa di opposto alla veglia, da analizzare dall’esterno. Al contrario, il poeta, lo scrittore o l’artista, più aperti alle dimensioni non completamente razionali dell’esistenza, rispondono con maggiore apertura, dicendo “sì, forse, talvolta”. Adorno si colloca in una posizione che cerca di tenere insieme entrambe queste prospettive. Egli riconosce la forza della ragione ma è anche sensibile alla specificità dell’esperienza onirica.L’impronta della veglia sul sogno
Adorno osserva che l’insistenza della filosofia nel distinguere nettamente sogno e realtà può finire per “ferire” i sogni. Questa separazione rigida lascia una sorta di “macchia” o imperfezione anche sui sogni più belli e positivi. Secondo Adorno, persino i sogni che sembrano felici portano con sé una “crepa invisibile”. Questa fessura è dovuta proprio alla loro natura di immagini o esperienze che non hanno la concretezza e la stabilità della realtà della veglia. Il confronto costante con la realtà sminuisce in parte il loro valore intrinseco.La possibilità dell’impossibile nel sogno
Nonostante questa distanza dalla realtà, è possibile considerare una dimensione particolare legata al sogno: la “possibilità dell’impossibile”. Questo concetto, associato in particolare a Benjamin, suggerisce un modo diverso di rapportarsi all’esperienza onirica. Significa cercare di “bandire il sogno senza tradirlo”. Questo non vuol dire eliminare il sogno, ma piuttosto mantenere la lucidità e la vigilanza tipiche dello stato di veglia. Allo stesso tempo, però, implica restare attenti al senso profondo e alla particolare chiarezza che il sogno può manifestare, soprattutto quando ci indica o suggerisce qualcosa che nel mondo della realtà appare del tutto irrealizzabile.Narrare il sogno, non interpretarlo
Un sogno inteso in questo modo, che suggerisce la possibilità dell’impossibile, non viene analizzato o spiegato secondo le logiche interpretative tradizionali. Viene invece semplicemente trascritto, narrato o riportato nella sua forma originale. La “possibilità dell’impossibile” non è qualcosa che si presta a un’analisi razionale rigorosa; è una dimensione che può essere colta solo attraverso il sogno stesso. Per questo motivo, un pensiero che si distacca dalle forme più rigide della filosofia tradizionale potrebbe avere una maggiore affinità e capacità di accedere a questa dimensione onirica e alle sue potenzialità inespresse.La sfida di preservare l’estraneità
Si pone quindi la questione fondamentale se sia davvero possibile parlare del sogno utilizzando gli strumenti del pensiero razionale, tipici della veglia, senza però snaturare la sua essenza. La sfida è riuscire a preservare la sua intrinseca estraneità, la sua alterità rispetto al mondo della logica e della ragione. Mantenere intatta questa diversità del sogno è un compito difficile per il pensiero. Questa riflessione sulla difficoltà di accostarsi razionalmente a ciò che è fondamentalmente “altro” rispetto al proprio modo di pensare porta a considerare più in generale il concetto di alterità e come il pensiero possa relazionarsi a ciò che è diverso da sé.Un nuovo approccio filosofico
Adorno e Benjamin, attraverso i loro scritti che spesso non seguono le convenzioni accademiche, suggeriscono l’idea di un “nuovo Illuminismo”. Propongono un approccio filosofico che non cerca di illuminare e razionalizzare ogni aspetto dell’esistenza, ma che riconosce il valore della “possibilità dell’impossibile” e l’estraneità del sogno. Questo approccio può essere visto come “minoritario”, in quanto si pone al di fuori delle correnti di pensiero dominanti. La sua forza sta nel salvaguardare la diversità e l’alterità della realtà onirica rispetto all’ordine razionale della veglia. Si tratta di adottare una diversa “postura” o atteggiamento mentale nei confronti della conoscenza e dell’esperienza del mondo.Ma quale “conoscenza nascosta” emerge da un tale calderone di visioni, che spaziano dal presagio divino al mero sintomo corporeo?
Il capitolo elenca prospettive affascinanti ma eterogenee sui sogni, senza però chiarire come da queste si distilli una specifica “conoscenza nascosta”. La natura di tale conoscenza – è forse predizione, diagnosi medica, o introspezione filosofica? – rimane sfumata. Per cogliere meglio il nesso tra sogni e sapere nell’antichità, sarebbe utile esplorare più a fondo l’epistemologia greca e il concetto di verità, magari confrontando le diverse definizioni di conoscenza in autori come Platone e Aristotele, e indagando il ruolo della divinazione nella cultura greca.5. Il Sogno Tra Inconscio e Risveglio
I sogni nascondono un significato profondo e rappresentano una porta verso la parte più nascosta della nostra mente, l’inconscio. Sigmund Freud è stato fondamentale nel mostrare come sia possibile interpretare i sogni per comprendere questa dimensione segreta. Il metodo che ha proposto è l’associazione libera, che consiste nel dire tutto ciò che viene in mente partendo dagli elementi del sogno stesso. In questo processo, Freud distingueva tra il contenuto apparente del sogno, quello che ricordiamo al risveglio (il contenuto manifesto), e il suo significato vero e nascosto (il contenuto latente). A volte, l’inconscio riemerge attraverso il concetto di “perturbante”, quella sensazione strana e inquietante che proviamo quando qualcosa di familiare diventa inspiegabilmente estraneo.La Ragione e i Suoi Limiti
Immanuel Kant definiva l’Illuminismo come il momento in cui l’umanità esce da uno stato di dipendenza e immaturità. Questo non accade per mancanza di intelligenza, ma per mancanza del coraggio di usare la propria ragione in modo autonomo. L’essenza dell’Illuminismo, quindi, è l’invito a pensare con la propria testa. Questa riflessione sulla ragione si lega all’opera di Francisco Goya, “El sueño de la razón produce monstruos”. La parola spagnola “sueño” è ambigua, perché può significare sia “sonno” che “sogno”. Questa ambiguità apre a diverse interpretazioni: i mostri possono nascere quando la ragione “dorme”, lasciando spazio all’irrazionale e al caos, oppure possono emergere dai “sogni” stessi della ragione, intesi come le profondità inesplorate dell’immaginazione o dell’inconscio.Sogno e Realtà nella Letteratura e nell’Arte
La letteratura ha spesso esplorato il confine sottile tra sogno e realtà. Un esempio significativo è la novella “Doppio sogno” di Arthur Schnitzler. Questa opera indaga come i limiti tra ciò che si vive nella veglia e ciò che appare nei sogni possano sfumare e influenzarsi a vicenda. Schnitzler stesso aveva legami con le idee di Freud, riconoscendo similitudini tra la sua indagine letteraria e l’esplorazione scientifica dell’inconscio. Altri artisti e pensatori hanno indagato il mondo onirico come chiave di comprensione. Federico Fellini teneva un diario dove disegnava i suoi sogni, usandoli come fonte d’ispirazione. Theodor W. Adorno registrava i suoi sogni, vedendoli come uno strumento per capire meglio la realtà che lo circondava. Walter Benjamin considerava i sogni una via per comprendere il passato e il presente, e il risveglio un momento cruciale in cui si raggiunge una nuova consapevolezza. Jacques Derrida ha interpretato il pensiero di Benjamin, suggerendo che la ricerca filosofica stessa possa essere vista come un continuo processo di risveglio.Ma l’interpretazione freudiana dei sogni, per quanto affascinante, è davvero l’unica via per l’inconscio, o il capitolo ignora decenni di dibattito e ricerca?
Il capitolo si concentra quasi esclusivamente sull’approccio freudiano all’interpretazione dei sogni, presentandolo come la porta principale verso l’inconscio. Tuttavia, questa prospettiva è stata ampiamente dibattuta e, in molti ambiti scientifici, superata o affiancata da altre teorie. Per avere un quadro completo, sarebbe fondamentale esplorare le visioni alternative offerte dalla psicologia analitica (si pensi a Carl Jung) o, più radicalmente, le ricerche neuroscientifiche e cognitive sul sonno e sull’attività onirica, che offrono spiegazioni basate su processi cerebrali piuttosto che su simbolismi repressi. Approfondire autori che hanno criticato o sviluppato il pensiero freudiano, o che si occupano di neuroscienze del sonno e della cognizione, permetterebbe di comprendere meglio i limiti e le alternative all’interpretazione proposta.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]