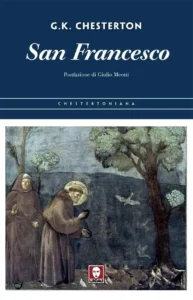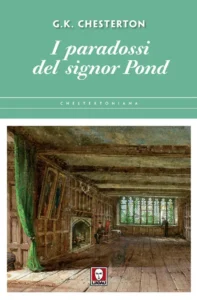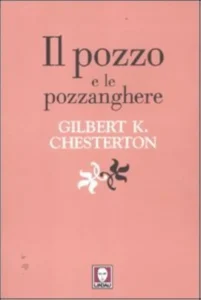1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “Eugenetica e altri malanni” di Gilbert Chesterton è un pugno nello stomaco, un libro che ti fa vedere il mondo con occhi diversi, soprattutto quando si parla di eugenetica e del suo impatto sulla società. Chesterton, con la sua solita arguzia, smonta pezzo per pezzo l’idea che lo Stato possa o debba decidere chi è “adatto” a procreare, criticando aspramente le leggi che limitano la libertà individuale in nome di una presunta “salute pubblica” o di un miglioramento genetico. Non è un libro ambientato in un luogo specifico, ma piuttosto un’analisi profonda delle idee che circolavano all’inizio del XX secolo, specialmente in Inghilterra, e che purtroppo risuonano ancora oggi. Non ci sono personaggi principali nel senso classico, ma i veri protagonisti sono le idee: la scienza di stato, la nuova povertà creata dall’industrialismo, e la deriva verso un controllo umano sempre più pervasivo. Chesterton ci mette in guardia contro l’illusione di un progresso scientifico che sacrifica la dignità umana, mostrando come la ricerca di un “superuomo” eugenetico possa portare a una società dove la libertà personale viene calpestata e i più deboli sono ancora più emarginati. È un invito a riflettere sulla vera natura della libertà e sui pericoli di un potere che si arroga il diritto di giudicare e selezionare la vita.Riassunto Breve
L’eugenetica si presenta come un sistema di pensiero e azione che richiede opposizione immediata, basato su una nuova morale che pone la responsabilità principale verso il bambino non nato, guidata dalla conoscenza biologica, discostandosi dall’etica tradizionale che privilegiava il partner esistente. Valuta le unioni in base a calcoli ereditari e mira a controllare matrimonio e procreazione, trattando gli individui come bestiame o schiavi, in contrasto con la tradizione della famiglia come impresa libera. I suoi sostenitori usano eufemismi o minimizzano le implicazioni, affidandosi a buone intenzioni o presentando riforme come estensioni di leggi esistenti. Lo Stato eugenista non è futuro, ma presente, con leggi che permettono l’internamento di persone considerate “deboli di mente” con definizioni vaghe, senza diagnosi medica, per impedire la procreazione a chi è giudicato non idoneo, segnando l’inizio di questo stato e rendendo necessaria la ribellione. L’anarchia può manifestarsi anche nei poteri di governo, come incapacità di porre fine a eccezioni trasformandole in norme senza limiti, visibile nell’ampliamento indefinito di pene o nella vaga definizione di crimini, applicati senza senso delle proporzioni. La pazzia è un’eccezione per genere, fuori dalla legge ordinaria, riconoscibile solo dall’unanimità dei sani. L’eugenetica pretende di giudicare gli uomini come si giudicano i pazzi, applicando la logica dell’eccezione alla vita umana, ma manca di un’autorità legittima per farlo. Non può essere la democrazia né gli specialisti, che conoscono le eccezioni (malattia, pazzia) ma non la regola (salute, sanità mentale), troppo vasta per la specializzazione. Governare la vita umana basandosi su un’autorità specialistica sulla salute è una tirannia medica e un’anarchia del giudizio. Il termine “debole di mente” è vago, permettendo applicazioni ampie per controllo o esproprio, rendendo difficile la difesa e invalidando statistiche basate su tale definizione. L’ereditarietà è complessa, influenzata da milioni di fattori ed esperienza individuale; legiferare su questa conoscenza frammentaria è irresponsabile. La scienza, specialmente l’eugenetica, agisce come una “Chiesa ufficiale”, usando il potere statale per imporre teorie contestate, trattando il pubblico come materiale sperimentale. L’epoca attuale è dominata dall’idea di “inevitabilità”, evitando di ammettere errori e affrontare problemi risolvibili, nascondendo la vera storia dei rapporti tra ricchi e poveri. La condizione del povero cambia: dallo schiavo (bene mobile ma umano) al servo medievale (sicurezza sulla terra) al vagabondo moderno (cacciato, senza posto, leggi che vietano azioni di sopravvivenza come cacciare o mendicare). Le leggi che puniscono i senzatetto sono assurde. Il capitalista scopre che la ricchezza dipende dalla povertà altrui, e di fronte alla degenerazione della classe lavoratrice causata dall’insicurezza, cerca di controllare la riproduzione umana per produrre il tipo di individuo desiderato. Il movimento eugenetico, rivolto ai poveri, nasce dagli interessi di datori di lavoro e industriali che vedono i poveri come strumenti malfunzionanti. L’idea è che vita e famiglia debbano adattarsi alle esigenze del mondo degli affari, con i figli visti come “indesiderati” dai datori di lavoro che non vogliono pagare salari adeguati. L’eugenetica non si applica alle classi ricche, dimostrando che l’interesse è il controllo della classe lavoratrice, vista quasi come una specie separata da gestire, ignorando che la povertà deriva spesso da ingiustizie. Questa spinta al controllo è possibile per la perdita del valore della libertà personale; l’intervento statale si sposta dal controllo di azioni dannose alla regolazione di abitudini personali per “salute pubblica”, intromettendosi negli aspetti privati. Le idee socialiste sono state distorte, adottando controlli burocratici senza uguaglianza economica, colpendo i poveri con limitazioni senza supporto, rendendoli vulnerabili a esperimenti di controllo come l’eugenetica per le necessità industriali. L’animo popolare inglese si manifesta in canzonette, come quella di un padre licenziato per aver fumato la pipa, che mostra lo scontro tra la famiglia tradizionale e le autorità artificiali. La precarietà del lavoratore industriale contrasta con la sicurezza passata. L’azienda impersonale controlla risorse essenziali, e la libertà richiede una forma di proprietà privata. Il licenziamento per un’abitudine personale mostra la contraddizione di un sistema che controlla le abitudini ma ignora il bisogno fondamentale di cibo. La “vecchia pipa” simboleggia un residuo di proprietà personale vulnerabile. La difesa delle tradizioni è ostacolata dalla mancanza di un ideale forte come la religione. L’ascesa dell’eugenetica intorno al 1913, mirata a creare un “superuomo”, fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, che espose la disumanità dello stato scientificamente organizzato prussiano, screditando temporaneamente l’eugenetica. Tuttavia, l’impulso al controllo scientifico persiste con tecniche moderne come la diagnosi genetica pre-impianto, che permette di eliminare embrioni per predisposizioni future, conferendo alla scienza potere su vita e morte, creando una “caccia al tarato” e disuguaglianze nell’accesso a tali tecnologie, mantenendo la contesa tra dignità umana e ambizione di perfezione scientifica.Riassunto Lungo
1. L’assalto dell’eugenetica
Che cos’è l’eugenetica e perché va fermata
L’eugenetica si presenta come un progetto chiaro e deciso, un modo di pensare e agire che va fermata subito, prima che diventi troppo forte. Si basa su una nuova idea di giusto e sbagliato: mette la responsabilità principale sull’individuo verso chi non è ancora nato, pensando alle conseguenze biologiche. Questo è molto diverso dalla morale di prima, dove il dovere più importante era verso il proprio compagno o compagna, e si lasciava che i figli nascessero come succedeva. L’eugenetica, invece, giudica le coppie in base a calcoli sull’ereditarietà. Così, considera sbagliati o persino peccaminosi legami che prima erano visti bene perché mostravano fedeltà verso persone malate o deboli. Sul piano pratico, vuole controllare chi si sposa e chi ha figli, trattando le persone come se fossero bestiame da allevare o schiavi. Questo va contro la tradizione, che ha sempre visto il creare una famiglia come una scelta libera e personale.Come si difende chi sostiene l’eugenetica
Quando vengono criticati, chi sostiene l’eugenetica usa spesso parole complicate o meno dirette per nascondere che le loro idee sono obbligatorie. Altri dicono che il problema è piccolo, parlando solo di casi molto evidenti ed estremi, ma non guardano alle conseguenze più grandi. Alcuni pensano che le nuove regole funzioneranno bene perché saranno applicate da persone che vogliono fare il bene, ma dimenticano che le leggi, una volta create, vanno avanti per conto loro. Altri ancora giustificano leggi pericolose dicendo che sono solo un piccolo cambiamento rispetto a regole che ci sono già, o che sono esperimenti che bisogna fare.Lo Stato eugenista è già qui
La verità è che uno Stato basato sull’eugenetica non è qualcosa che succederà in futuro, ma è già qui. È stata approvata una legge che permette di chiudere in istituto persone considerate “deboli di mente” con definizioni poco chiare, senza che ci sia una vera diagnosi medica di malattia mentale. Lo scopo di questa legge è chiaro: impedire a chi è giudicato non adatto di avere figli. Questa legge segna l’inizio dello Stato eugenista e per questo, resistere diventa necessario.Se l’eugenetica si basa su calcoli sull’ereditarietà e giudica le coppie in base a questi, come si concilia questa pretesa di oggettività scientifica con la definizione di “debole di mente” che la legge citata usa in modo “poco chiaro” e senza una vera diagnosi medica, rendendo l’intero impianto potenzialmente arbitrario e privo di fondamento scientifico solido?
Il capitolo presenta un’argomentazione che, pur puntando a evidenziare i pericoli dell’eugenetica, sembra sottovalutare la complessità della definizione di “salute” e “malattia” in ambito genetico e psicologico, nonché le implicazioni etiche e sociali di tali definizioni. La transizione da un giudizio basato su presunti calcoli ereditari a una legge che si appella a definizioni vaghe di “debolezza mentale” solleva interrogativi sulla coerenza logica e sulla base scientifica dell’azione statale descritta. Per approfondire la comprensione di questi temi, sarebbe utile esplorare i dibattiti sulla filosofia della scienza applicata alla genetica e alla psichiatria, analizzando testi di autori come Michel Foucault, che ha ampiamente trattato il tema del potere e della normalizzazione sociale, e Julian Savulescu, che si è occupato delle implicazioni etiche del miglioramento umano e delle tecnologie genetiche. La lettura di studi sulla storia della psichiatria e sulla definizione di disabilità mentale potrebbe inoltre fornire un contesto cruciale per comprendere le lacune argomentative presenti nel capitolo.2. La Follia del Giudizio Moderno
Esiste una forma di perdita di controllo che non è una ribellione dal basso, ma si manifesta nei poteri di governo. Questo accade quando non si riesce a porre fine a situazioni eccezionali o stravaganti, trasformandole in una norma senza limiti. A differenza della ribellione, che spesso cerca di creare un nuovo ordine, questa condizione è l’incapacità di tornare alla normalità.L’anarchia nel governo
Si vede questa mancanza di controllo nell’ampliamento indefinito di pene come il carcere o nella definizione vaga di crimini come la crudeltà e la diffamazione, che vengono applicati senza un senso delle proporzioni. Questa incapacità di distinguere e limitare caratterizza l’anarchia che può colpire gli organi di governo. Non è una sfida diretta al potere, ma una sua degenerazione interna, dove le regole si allungano e si distorcono senza fine.La pazzia come eccezione vera
La pazzia è diversa dalla ribellione o dal crimine. Chi è pazzo non mette in discussione la realtà che tutti condividono, ma la nega completamente. Non è una minoranza che si distingue per qualche caratteristica, ma un’eccezione unica nel suo genere, che si trova fuori dalla comprensione comune e, per questo, fuori dalla legge ordinaria. Solo l’accordo unanime di chi è considerato sano di mente può riconoscere questa condizione fondamentale e metterla in una categoria a parte.L’eugenetica e il giudizio sulla vita
L’eugenetica pretende di giudicare gli esseri umani con la stessa superiorità con cui si giudicano i pazzi, applicando la logica dell’eccezione alla regola generale della vita di tutti. Il punto cruciale dell’eugenetica è che le manca un’autorità legittima per poter dare un giudizio così radicale. Non può essere la democrazia a farlo, né possono essere i singoli specialisti. Le opinioni degli specialisti sono soggettive e limitate; sono esperti nelle eccezioni, come la malattia o la pazzia, ma non nella regola, che è la salute o la sanità mentale. La regola è troppo vasta e complessa per essere oggetto di una specializzazione scientifica. Pretendere di guidare la vita umana basandosi sull’autorità di uno specialista sulla salute è una forma di tirannia medica e un esempio chiaro di questa anarchia del giudizio che non sa riconoscere i propri limiti.Se la “pazzia” è un’eccezione che nega la realtà condivisa, come può il “giudizio moderno” e l’eugenetica, che si basano su una presunta superiorità nel giudicare la vita, stabilire un consenso unanime e legittimo per definire chi sia veramente “fuori dalla comprensione comune” e chi no, senza cadere in una tirannia basata su interpretazioni soggettive e non verificabili?
Il capitolo solleva un punto cruciale riguardo alla legittimità del giudizio e all’autorità nel definire l’eccezione. L’argomentazione sull’eugenetica che pretende di applicare la logica dell’eccezione alla regola generale della vita umana, senza possedere un’autorità legittima e basandosi su opinioni specialistiche che sono per loro natura limitate e soggettive, evidenzia una lacuna fondamentale. La questione centrale è come si possa costruire un consenso “unanime” su chi sia “fuori dalla comprensione comune” quando la definizione stessa di questa “comprensione” è intrinsecamente sfuggente e potenzialmente arbitraria. Per approfondire questo dibattito, sarebbe utile esplorare i fondamenti filosofici della conoscenza e della morale, interrogandosi sulla natura della “realtà condivisa” e sui criteri di legittimità del potere. Discipline come la filosofia morale, la teoria politica e la sociologia della conoscenza potrebbero offrire strumenti preziosi. Autori come Michel Foucault, con le sue analisi sul potere e sulla conoscenza, e Jürgen Habermas, con la sua teoria dell’agire comunicativo e della sfera pubblica, potrebbero fornire prospettive illuminanti per comprendere le dinamiche del giudizio e del consenso nella società moderna.3. La Scienza di Stato e l’Età dell’Impenitenza
Il termine “debole di mente” non ha una definizione chiara e precisa, a differenza di parole come “pazzia” o “idiozia”. Questa mancanza di precisione permette di usare il termine in modo molto ampio, a volte anche per controllare le persone o per togliere loro dei beni. È molto difficile difendersi da un’accusa così vaga. Di conseguenza, le statistiche che si basano su definizioni così poco chiare non possono essere considerate affidabili o oggettive.L’ereditarietà: una complessità fraintesa
L’ereditarietà esiste, ma è incredibilmente complessa. Milioni di elementi e le esperienze di vita di ognuno influenzano come i tratti ereditari si manifestano. La combinazione di questi tratti in ogni persona è unica e non si può semplicemente scomporre. Qualità come la salute o la bellezza non sono semplici da definire, e capire come si ereditano è molto incerto. Accoppiare persone sane non garantisce necessariamente figli sani, come ha fatto notare H.G. Wells. Per questo motivo, creare leggi basandosi su una conoscenza così incompleta dell’ereditarietà è irresponsabile.La scienza come “Chiesa ufficiale” e la nuova persecuzione
Oggi, la scienza, specialmente nel campo dell’eugenetica, agisce quasi come una “Chiesa ufficiale”. Usa il potere dello Stato, con leggi, multe e prigione, per imporre teorie che non sono ancora state dimostrate in modo definitivo e che sono ancora discusse, come nel caso delle vaccinazioni o delle politiche eugeniche. Questo modo di agire è una nuova forma di persecuzione, diversa da quella religiosa del passato. Le persecuzioni di un tempo imponevano idee considerate verità assolute e immutabili; oggi si impongono ipotesi che gli stessi scienziati ammettono di poter cambiare in futuro. Il pubblico viene così trattato come materiale per esperimenti, usato per scoprire verità che non sono ancora note.L’Età dell’Impenitenza: evitare la verità e gli errori
L’epoca in cui viviamo è caratterizzata dall’idea che certe cose siano “inevitabili” o che non si possa tornare indietro, un atteggiamento di “impenitenza”. Si accetta che il passato non possa essere cambiato e si evita di riconoscere i propri errori. Questo si vede nella politica, dove i partiti spesso non annullano le leggi fatte dagli avversari. Si manifesta anche nell’incapacità di risolvere problemi che invece si potrebbero affrontare, come il sistema educativo, mentre ci si lamenta di cose che non si possono cambiare, come il clima. Questa resistenza a disfare ciò che è stato fatto è un difetto morale, un rifiuto di ammettere gli sbagli. Questo è particolarmente vero riguardo alla vera storia dei rapporti tra ricchi e poveri, che viene nascosta dietro racconti falsi per mantenere le cose come stanno. Chi ha potere evita di affrontare la verità su come ha agito, preferendo storie che lo giustificano.Se il movimento eugenetico, come descritto nel capitolo, mira a “aggiustare” la forza lavoro per l’efficienza produttiva ignorando le cause sociali della povertà, non si configura forse un’irrazionalità di fondo nel voler ottimizzare un sistema basato su premesse intrinsecamente fallaci e nella sua applicazione selettiva, che trascura le classi agiate per concentrarsi sui lavoratori, suggerendo una motivazione più legata al controllo sociale che a un genuino miglioramento della società?
Il capitolo solleva interrogativi cruciali sulla strumentalizzazione delle politiche sociali e scientifiche a fini economici e di controllo. Per comprendere appieno la complessità di tali dinamiche, sarebbe utile approfondire le teorie socio-economiche che analizzano il rapporto tra potere, capitale e disuguaglianza. In particolare, lo studio delle opere di Karl Marx, che analizza criticamente il capitalismo e la sua tendenza all’alienazione del lavoro, potrebbe fornire un quadro interpretativo più solido. Inoltre, un’analisi storica delle diverse correnti del pensiero eugenetico e delle loro implicazioni sociali, magari attraverso testi di storici della scienza come Michel Foucault, potrebbe chiarire le origini e le evoluzioni di queste idee e la loro applicazione pratica nel corso del tempo, evidenziando come tali approcci si siano spesso discostati dai loro presunti obiettivi scientifici per servire interessi di classe o ideologici.6. La Pipa, la Famiglia e la Scienza Perfetta
Lo spirito delle persone comuni in Inghilterra si manifesta nelle chiacchiere e nelle canzoni di tutti i giorni, non nei giornali o nella politica ufficiale. Una canzone popolare racconta di un padre che viene licenziato dall’azienda dell’acqua solo perché fumava la sua vecchia pipa di ciliegio.La vita operaia e la vecchia pipa
La parola “padre” in questa canzone rappresenta la famiglia tradizionale, un legame naturale che oggi sembra schiacciato da poteri esterni come i datori di lavoro o i funzionari. L’espressione “got the sack”, cioè essere licenziato, mostra quanto fosse incerta la vita del lavoratore nelle fabbriche. Non aveva la sicurezza che avevano gli schiavi o i membri delle vecchie corporazioni di mestiere. L’azienda dell’acqua, in questo racconto, simboleggia le grandi organizzazioni, pubbliche o private, che controllano beni fondamentali per la vita. Per sentirsi davvero liberi in questo sistema, sembra necessario possedere qualcosa di proprio, come un pozzo d’acqua personale o un focolare. Il fatto che il padre sia licenziato “perché fumava” mette in luce una stranezza: un sistema che tratta il lavoratore come un estraneo da licenziare facilmente, ma poi cerca di controllare le sue abitudini personali, ignorando però il suo bisogno fondamentale di cibo. La “vecchia pipa di ciliegio” è l’ultimo segno di un legame con la proprietà, ma si limita a oggetti personali e non ai mezzi per lavorare e vivere, rendendola così inutile contro il rischio di perdere il lavoro.Scontro tra tradizione e controllo
Questa situazione descrive uno scontro tra vecchi modi di vivere, come il valore della famiglia e il desiderio di possedere qualcosa, e nuove forze come l’industria e il controllo stretto sulla società. Difendere le vecchie tradizioni diventa difficile perché manca un ideale forte, come quello che un tempo offriva la religione. La fede, infatti, rendeva sacri la casa e gli oggetti che vi si trovavano, quasi come fossero piccole divinità protettrici della famiglia.La scienza e l’ideale del superuomo
In un periodo successivo, intorno al 1913, prese piede l’eugenetica. Era un movimento basato sulla scienza che voleva migliorare la specie umana scegliendo chi poteva riprodursi e controllando le nascite per creare un “superuomo”. Questa idea, molto popolare sui giornali, fu fermata di colpo dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È ironico che l’Inghilterra si ritrovò a combattere contro la Prussia, che era vista proprio come il modello dello stato organizzato scientificamente e la fonte di quell’idea di superuomo. Le azioni violente della Prussia durante la guerra mostrarono il lato disumano di un’organizzazione così rigida, facendo perdere credito all’eugenetica per un certo tempo.Il controllo scientifico oggi
Nonostante la battuta d’arresto, il desiderio della scienza di controllare e selezionare la vita non è scomparso. Oggi, tecniche moderne come la diagnosi genetica sugli embrioni prima che vengano impiantati permettono di scartare quelli che non vanno bene. Questo non serve solo a evitare malattie gravi, ma anche a eliminare quelli che potrebbero avere problemi di salute in futuro. In questo modo, la scienza acquista un potere enorme sulla vita e sulla morte. Si crea quasi una “caccia all’individuo imperfetto” e si generano disuguaglianze, perché non tutti possono accedere a queste tecnologie. La lotta tra il valore intrinseco della persona umana e il desiderio di raggiungere una perfezione scientifica continua ancora oggi.Se la scienza moderna, nel suo desiderio di perfezione, mira a eliminare l'”imperfezione”, non rischia di creare una nuova forma di discriminazione basata sulla genetica, replicando in chiave scientifica le stesse disuguaglianze che pretendeva di superare?
Il capitolo solleva un punto cruciale sulla potenziale deriva eugenetica della scienza applicata alla selezione umana, ma l’argomentazione potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita delle implicazioni etiche e sociali di tale selezione. Per comprendere meglio le sfumature di questo dibattito, sarebbe utile esplorare le opere di filosofi che si sono occupati di bioetica e delle conseguenze sociali del progresso scientifico, come ad esempio Jürgen Habermas, che ha discusso ampiamente le implicazioni della manipolazione genetica sulla nostra concezione dell’umanità e sulla società. Inoltre, un’analisi storica più dettagliata del movimento eugenetico e delle sue diverse manifestazioni nel corso del XX secolo potrebbe fornire un contesto essenziale per valutare le analogie e le differenze con le pratiche scientifiche attuali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]