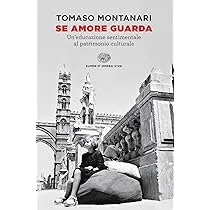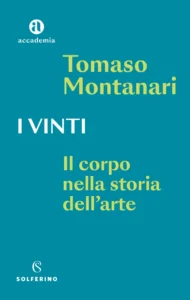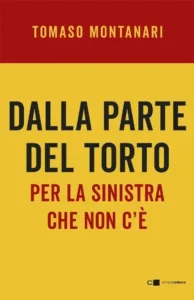Contenuti del libro
Informazioni
“Eclissi di Costituzione. Il governo Draghi e la democrazia” di Tomaso Montanari è un libro che ti fa pensare un sacco su quello che è successo in Italia durante il governo Draghi. Non è solo una cronaca, ma un’analisi super critica di come le cose sono cambiate. Montanari dice che c’è stata una specie di “eclissi” della nostra Costituzione italiana, quella che dovrebbe proteggerci tutti. Secondo lui, questo governo, presentato come quello “dei Migliori”, ha in realtà favorito gli interessi di pochi, le classi dominanti e il mercato, mettendo da parte i principi fondamentali come l’uguaglianza e la solidarietà. Il libro esplora come le decisioni sulla pandemia, la guerra in Ucraina, il PNRR, le politiche economiche e del lavoro, e persino la gestione dell’ambiente e i diritti sociali, siano state guidate da una logica di profitto e difesa di un “ordine esistente” che non ammette alternative. È come se la democrazia parlamentare fosse stata messa in crisi, con decisioni prese dall’alto, ignorando il dibattito e limitando il dissenso. L’autore usa l’immagine di un vecchio quadro per spiegare come il potere finanziario stia guidando la politica, lasciando il popolo un po’ accecato. È una lettura che ti spinge a guardare oltre la superficie e a capire come certi valori fondamentali della nostra Repubblica siano stati messi in ombra.Riassunto Breve
Il governo italiano usa un linguaggio da guerra per affrontare la pandemia e il conflitto in Ucraina, parlando di nemici e armi invece che di cura e solidarietà. Per l’Ucraina, si inviano armi e truppe ai confini, una scelta che sembra andare contro l’articolo 11 della Costituzione che rifiuta la guerra. Dare armi senza cercare la pace peggiora il conflitto. L’Italia si schiera con l’Occidente contro la Russia, senza cercare soluzioni multilaterali o una pace europea. Si esalta la “resistenza eroica” degli ucraini, anche armando i civili, cosa vista come pericolosa e fatta solo per creare un senso di appartenenza. Questa politica viene da un’idea che vuole mantenere tutto come sta, chiamata “ordine esistente”. Questa idea sembra pratica ma in realtà serve gli interessi dei potenti. Si appoggia il governo senza criticare, credendo a miti smentiti dai fatti. Si crede che il mercato risolva tutto e che l’economia debba crescere sempre, anche se l’ambiente e la società soffrono. Questa visione, che ha portato a privatizzazioni e meno regole, dice che non ci sono altre strade. Non si affrontano le cause della disuguaglianza e si danno la colpa ai più deboli, come i lavoratori che ricevono aiuti. L’idea del mercato va contro i valori della Costituzione, specialmente l’articolo 3 che vuole l’uguaglianza per tutti. Il Presidente della Repubblica affida il governo a Mario Draghi dopo una crisi, saltando il Parlamento. Questo governo, chiamato “dei Migliori”, è visto come un sistema dove pochi decidono per tutti, un colpo alla democrazia parlamentare. Mettere insieme partiti diversi, anche la Lega, serve a rafforzare l’ordine economico occidentale e l’idea che non si possa cambiare niente. Le differenze politiche spariscono perché il bene del paese è deciso dall’alto. Questo governo, definito aristocratico, rappresenta gli interessi di chi comanda, non per capacità ma per convenienza. Le politiche favoriscono la finanza. La riforma fiscale abbassa le tasse per i più ricchi, aumentando la disuguaglianza, contro la Costituzione. La gestione della pandemia minimizza i rischi per non fermare l’economia. Si allentano le regole, si usa il Green Pass criticato per le sue contraddizioni. Si incolpano i non vaccinati per la diffusione del virus, ignorando i problemi della sanità pubblica e limitando chi non è d’accordo. Questo sembra sacrificare vite per soldi e potere. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) investe molti soldi, ma ne mette pochi per la salute rispetto alle grandi opere (18,5 miliardi contro 31,4 miliardi). Pochi soldi vanno a proteggere il territorio dai disastri naturali rispetto alle nuove costruzioni. Esperti e ambientalisti dicono che il Piano pensa più all’industria e alla finanza che all’ambiente. La transizione ecologica è debole. La “semplificazione” delle regole è vista come un modo per togliere i controlli. Un decreto indebolisce la protezione del paesaggio e dei beni culturali, creando scorciatoie che saltano i controlli e permettendo di costruire più facilmente, anche impianti rinnovabili in posti delicati, danneggiando il territorio. Mettere lo “sviluppo sostenibile” nella Costituzione (articolo 9) sembra un modo per mettere insieme la protezione del paesaggio e gli interessi economici, rischiando di danneggiare il bene comune. Le politiche economiche e fiscali aiutano i più ricchi, come si vede dalla riforma fiscale e dai bonus per i proprietari di case. I ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Le tasse non aiutano a distribuire meglio la ricchezza e si pensa solo a far crescere il PIL. Fermare il “Decreto Dignità” ha aumentato i lavori precari. Questa flessibilità voluta dal governo rende i lavoratori meno sicuri e meno capaci di partecipare alla vita del paese. La precarietà diffusa mostra una democrazia più debole. Il governo ferma il blocco dei licenziamenti, permettendo alle aziende di mandare via i lavoratori, anche per email, senza una vera riforma degli aiuti per chi resta senza lavoro. Un decreto sulla delocalizzazione permette alle grandi aziende di spostarsi all’estero pagando poco, limitando i diritti dei lavoratori. I lavoratori sono visti come “capitale umano” il cui valore è solo un prezzo. L’Italia continua a finanziare la guardia costiera libica e i centri dove vengono tenuti i migranti, anche se ci sono denunce di torture e abusi. Questo sostegno è legato agli interessi economici italiani in Libia e va avanti nonostante le richieste di fermarsi, mettendo il controllo dei migranti e gli affari prima dei diritti umani e del diritto d’asilo garantito dalla Costituzione. Si vogliono fare grandi opere come il Ponte sullo Stretto di Messina, anche se ci sono rischi di terremoti e danni all’ambiente. Questo succede mentre gli studi dicono che il territorio viene consumato velocemente e servono interventi per difenderlo. La riforma della giustizia vuole velocizzare i processi per il PNRR e gli investitori stranieri. Questo rischia di chiudere i casi più lunghi, forse anche quelli su reati ambientali o criminalità organizzata, e mette in discussione l’obbligo di perseguire tutti i reati, aprendo alla possibilità che la politica decida quali reati sono più importanti da seguire. Queste azioni mostrano che il profitto e l’economia vengono prima delle persone, dell’ambiente e dei principi della Costituzione. Il governo sembra lontano dai valori antifascisti. Dopo l’attacco alla sede della CGIL, il governo non scioglie Forza Nuova, anche se la legge lo permetterebbe. La presenza della Lega, con idee vicine al neofascismo, influenza le decisioni. Nomine controverse, come quella di Mario Vattani ad ambasciatore o di Andrea De Pasquale all’Archivio centrale dello Stato (poi rimosso da un incarico specifico), vengono difese con scuse burocratiche, ignorando le proteste. Si spingono le privatizzazioni dei servizi pubblici locali con una legge sulla concorrenza. La gestione pubblica diventa l’eccezione e deve essere giustificata, andando contro il risultato del referendum sull’acqua pubblica del 2011. Questa scelta favorisce il mercato e lo sfruttamento dei beni pubblici, come chiede il PNRR. Il diritto di manifestare viene limitato con circolari che permettono di chiudere aree delle città, usando la pandemia come scusa per fermare il dissenso. Scioperi e proteste studentesche vengono contrastati o ignorati. Nella scuola, il Curriculum dello Studente valuta le attività fuori dalla scuola, legando il percorso di studio ai soldi delle famiglie e aumentando la disuguaglianza. L’alternanza scuola-lavoro è vista come sfruttamento, che prepara gli studenti a essere solo “capitale umano” per il mercato. Le morti di studenti durante queste esperienze mostrano quanto sia grave la situazione. Il sistema politico mostra un Parlamento più debole, con un uso eccessivo dei voti di fiducia. L’elezione del Presidente della Repubblica riflette la situazione creata dal governo, con la rielezione di Mattarella vista come necessaria per garantire la stabilità del governo, in un momento di crisi dei partiti. Cercare la “governabilità” sembra voler un popolo più tranquillo, senza conflitti sociali e politici. Il quadro “Eclissi di sole” di George Grosz del 1926 mostra la democrazia tedesca prima del nazismo. Ci sono politici senza testa, controllati da un generale e da un banchiere. Il banchiere, che rappresenta i soldi, suggerisce le decisioni al generale, che guida i politici. Il popolo è un asino cieco che mangia informazioni controllate, ignorando le critiche. L’eclissi è una grande moneta con il simbolo del dollaro, a dire che il potere dei soldi domina tutto. Questa immagine si adatta all’Italia di oggi, dove c’è un’eclissi di Costituzione. Il problema non è una sola persona, ma una crisi della democrazia basata sulla Costituzione. Questa crisi è nascosta da uno stato di emergenza che favorisce un gruppo di interessi, un’oligarchia. I partiti perdono importanza, prevalgono interessi non mediati e singole persone, il Parlamento si blocca e la presidenza della Repubblica diventa più simile a una monarchia. Questa malattia della politica non viene curata, ma peggiorata da chi difende il sistema e i suoi privilegi. Serve un cambio profondo nel modo di pensare, guardando il mondo dal punto di vista di chi è stato sconfitto e dei poveri. Il futuro dipende da quello che farà la gente insieme.Riassunto Lungo
1. La Difesa dell’Ordine Esistente
Il governo italiano usa un modo di parlare che ricorda la guerra, sia quando affronta la pandemia sia per il conflitto in Ucraina. Questo modo di vedere le cose parla di nemici e armi, a differenza di un approccio basato sull’aiuto reciproco e sulla vicinanza tra le persone. Riguardo alla Russia, l’Italia ha scelto di inviare armi e soldati ai confini. Questa scelta è al limite di ciò che dice l’articolo 11 della nostra Costituzione, che rifiuta la guerra. Dare armi senza fare veri sforzi diplomatici non ferma il conflitto, ma lo alimenta. L’Italia si schiera nettamente da una parte, quella dell’Occidente contro la Russia, invece di cercare un modo di agire con tanti paesi insieme o una politica di pace per l’Europa. Parlare della “resistenza eroica” degli ucraini, soprattutto armando i civili, sembra una cosa poco responsabile. Non ha un vero peso strategico e serve solo a far sentire le persone parte di un gruppo.L’ideologia che difende lo stato attuale delle cose
Questo modo di agire del governo nasce da un modo di pensare che vuole mantenere tutto com’è, chiamato “l’ordine esistente”. Questo pensiero viene presentato come un modo pratico di fare le cose, ma in realtà è un insieme di idee che servono a chi ha più potere o ricchezza. Porta a sostenere il governo senza fare domande, ignorando i problemi reali e credendo a idee false, come quella di un governo “bravo” o “attento all’ambiente”, anche quando i fatti dicono il contrario. L’idea più diffusa si basa sulla “fede nel mercato”, visto come lo strumento migliore per il bene di tutti, e sull’idea che l’economia debba crescere sempre, anche se questo crea problemi per l’ambiente e le persone. Questo modo di pensare, che ha portato a vendere aziende pubbliche e a ridurre le regole, sostiene che “non ci sono alternative” alla logica del mercato. Non affronta le cause delle differenze tra le persone e finisce per dare la colpa a chi è meno fortunato, come i lavoratori che ricevono aiuti. Questa mentalità legata al mercato è in contrasto con i valori della Costituzione italiana, in particolare con l’articolo 3, che vuole garantire a tutti le stesse possibilità per poter vivere una vita dignitosa.Ma l’invio di armi a un paese invaso è davvero “al limite” della Costituzione, o questa lettura ignora il contesto e la complessità del diritto internazionale e della difesa?
Il capitolo solleva un punto cruciale sul rapporto tra le azioni del governo e i principi costituzionali, ma la valutazione sull’articolo 11 potrebbe beneficiare di un approfondimento sul dibattito giuridico e politico che circonda l’interpretazione di “ripudio della guerra” nel contesto di un conflitto difensivo e del diritto all’autodifesa di uno Stato aggredito. Comprendere le diverse scuole di pensiero nel diritto costituzionale e internazionale, nonché le analisi della scienza politica e degli studi strategici sull’efficacia e le implicazioni dell’assistenza militare in scenari complessi, è fondamentale per valutare appieno la posizione italiana. Approfondire il pensiero di costituzionalisti e studiosi di relazioni internazionali può offrire prospettive più articolate.2. Il governo dei pochi e la democrazia in crisi
L’affidamento dell’esecutivo a Mario Draghi da parte del Presidente della Repubblica avviene dopo una crisi di governo, bypassando le dinamiche parlamentari. Questa scelta è vista come la nascita di un governo “istituzionale” o “presidenziale”, chiamato “dei Migliori”, che funziona come un sistema paternalistico e aristocratico. Un simile assetto è considerato un colpo alla democrazia parlamentare, perché le decisioni importanti vengono prese da una sola persona o da un gruppo ristretto di persone potenti. L’inclusione di partiti diversi, anche molto distanti tra loro, serve a rafforzare un certo modello economico e l’idea che non ci siano alternative possibili alla situazione attuale. Questo annulla le differenze tra le forze politiche, perché il bene del paese è visto come qualcosa di già stabilito e deciso dall’alto. Il governo, definito aristocratico, non rappresenta gli interessi di tutti, ma solo quelli di una parte, quella che ha più potere, e si basa sulla convenienza di un’élite, non sulle reali competenze.Le politiche economiche e la gestione della pandemia
Le scelte del governo favoriscono gli interessi economici e finanziari. Per esempio, la riforma fiscale riduce le tasse per i redditi più alti, allontanandosi dal principio della Costituzione che chiede tasse progressive, e aumenta così le differenze sociali. La gestione della pandemia si basa su un approccio che cerca di ridurre al minimo i rischi solo per certi aspetti, simile a quello di altri paesi che hanno dato più importanza alla ripresa dell’economia. Vengono allentate le regole per limitare i contagi, come il distanziamento nelle scuole, e si usano strumenti come il Green Pass, criticato per le sue contraddizioni. La responsabilità della diffusione del virus viene data a chi non è vaccinato, mentre non si considerano le mancanze nella sanità pubblica e si limita la possibilità di esprimere un’opinione diversa. Questo modo di agire è visto come un sacrificio di vite umane per favorire interessi politici ed economici.Se un governo viene definito “dei Migliori”, come si concilia questa etichetta con l’accusa di rappresentare solo gli interessi di un’élite basandosi sulla convenienza e non sulla competenza?
Il capitolo presenta una forte critica alla natura del governo, definendolo “dei Migliori” ma al contempo accusandolo di agire per convenienza di un’élite e non per reale competenza o rappresentanza universale. Questa apparente contraddizione merita un approfondimento per comprendere meglio i criteri con cui vengono valutati la “competenza” e l’interesse pubblico in contrapposizione agli interessi di parte. Per esplorare queste dinamiche, può essere utile confrontarsi con studi di scienza politica che analizzano le teorie della rappresentanza e del potere, e con autori che hanno indagato il ruolo delle élite nella società.3. Crescita, ambiente e disuguaglianze: le priorità del PNRR
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nasce per rispondere alla crisi pandemica e prevede investimenti per 222,1 miliardi di euro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la spesa destinata alla salute diminuirà nei prossimi anni, tornando ai livelli precedenti la pandemia. Allo stesso tempo, una parte molto più consistente dei fondi è riservata alle grandi opere infrastrutturali, con 31,4 miliardi rispetto ai 18,5 miliardi per la salute. La messa in sicurezza del territorio dai rischi legati all’acqua e al dissesto geologico riceve finanziamenti minimi se confrontati con quelli per le nuove infrastrutture.Le preoccupazioni per l’ambiente
Molti esperti e associazioni che si occupano di ambiente ritengono che il Piano favorisca soprattutto gli interessi dell’industria e della finanza, mettendo in secondo piano le esigenze ecologiche. La strategia per passare a fonti di energia pulita appare debole e non è chiaramente collegata a obiettivi precisi per contrastare il cambiamento climatico.La “semplificazione” e i suoi effetti
Un punto cruciale del Piano è la cosiddetta “semplificazione” delle procedure, vista come un’idea che punta a eliminare vincoli e regole. Un decreto specifico ha indebolito le protezioni per il paesaggio e i beni culturali, creando meccanismi rapidi che permettono di aggirare i controlli delle soprintendenze e introducendo il silenzio assenso per i progetti privati. Questo rende più facile realizzare opere, anche impianti per energie rinnovabili in zone delicate, ma a discapito della tutela del territorio. L’inserimento del concetto di “sviluppo sostenibile” nella Costituzione (articolo 9) viene interpretato come un tentativo di trovare un equilibrio tra la protezione del paesaggio e gli interessi economici, con il rischio di danneggiare ciò che è un bene di tutti.Politiche economiche e fiscali
Le scelte economiche e fiscali tendono a favorire chi ha redditi più alti. Ne sono un esempio la riforma fiscale e il prolungamento di bonus che vanno a vantaggio dei proprietari di case. Dati recenti mostrano che la ricchezza dei miliardari è cresciuta molto durante la pandemia, mentre la povertà è aumentata nello stesso periodo. La politica fiscale non ha una forte capacità di ridistribuire la ricchezza e si concentra principalmente sulla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL).Il mercato del lavoro precario
La sospensione del “Decreto Dignità” ha contribuito a far crescere il lavoro precario, con una percentuale elevata di nuovi contratti a tempo determinato. Questa maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, fortemente voluta, riduce la stabilità e la dignità di chi lavora. Concentra l’insicurezza sociale e indebolisce la possibilità per le persone di partecipare attivamente alla vita del paese. La diffusione del lavoro precario è vista come un segnale di una democrazia meno forte.Ma la “governabilità” è davvero solo un pretesto per una popolazione “docile”, o c’è dell’altro?
Il capitolo, pur evidenziando l’uso eccessivo del voto di fiducia, stabilisce un legame diretto tra la ricerca di stabilità governativa e un presunto desiderio di una popolazione remissiva. Questa interpretazione delle motivazioni politiche merita un’analisi più approfondita. Per comprendere meglio le tensioni tra stabilità esecutiva e vitalità democratica, e per valutare se la ricerca di “governabilità” sia sempre e solo un sintomo di autoritarismo latente, è utile studiare la scienza politica, concentrandosi sui sistemi parlamentari e le teorie della democrazia. Autori come Giovanni Sartori o Norberto Bobbio possono fornire gli strumenti concettuali per analizzare queste dinamiche al di là delle mere interpretazioni.6. Eclissi di Costituzione
Il quadro “Eclissi di sole” di George Grosz, dipinto nel 1926, offre un’immagine potente dello stato della democrazia tedesca prima dell’ascesa nazista. Raffigura un tavolo del potere dove siedono politici senza testa, come se fossero privi di pensiero proprio. Queste figure sono chiaramente controllate da un generale, che rappresenta l’autorità militare, e da un banchiere, simbolo del potere finanziario. È il banchiere a suggerire le decisioni al generale, il quale a sua volta guida i politici. Il popolo è mostrato come un asino con gli occhi bendati, nutrito solo da informazioni controllate e incapace di vedere le voci critiche. L’eclissi del sole, nel quadro, è rappresentata da un’enorme moneta con il segno del dollaro, a sottolineare come il potere economico e finanziario domini ogni aspetto, un concetto già descritto da John Maynard Keynes.L’allegoria applicata all’Italia
Questa immagine del quadro di Grosz trova un forte e preoccupante parallelo nella situazione attuale in Italia. Anche qui si assiste a quella che potremmo definire un’eclissi di Costituzione, un fenomeno che va oltre la figura di una singola persona. Si tratta di una vera e propria crisi della democrazia costituzionale nel suo complesso. Questa crisi, però, non è evidente a tutti perché è mascherata da uno stato di eccezione, quasi normale, che favorisce un gruppo ristretto di interessi e persone, una vera e propria oligarchia. Questo sistema nascosto permette a pochi di mantenere il controllo e di agire al di fuori delle regole democratiche ordinarie.
I segnali della crisi
I segnali di questa “eclissi” sono molteplici e visibili nella vita politica di ogni giorno. I partiti tradizionali si svuotano di significato e di partecipazione popolare. Prevalgono sempre più interessi particolari e non mediati, che bypassano i canali democratici. Emerge la figura di singole personalità forti, a discapito del lavoro collettivo e delle istituzioni. I meccanismi normali del parlamento si bloccano o vengono aggirati con frequenza. La presidenza della Repubblica, in questo contesto, assume un carattere e un ruolo che ricordano sempre più una figura monarchica, accentrando poteri e decisioni.
Cambiare prospettiva
Questa grave malattia politica non viene affrontata e curata in modo efficace. Anzi, spesso è aggravata dalla difesa a oltranza del sistema attuale e dei privilegi che esso garantisce a chi ne fa parte. Per trovare una via d’uscita da questa situazione, è fondamentale cambiare radicalmente il modo in cui guardiamo e pensiamo il mondo. Questo significa, in concreto, sforzarsi di vedere la realtà dalla prospettiva di chi è stato sconfitto, degli esclusi e dei più poveri. L’esito finale di questa complessa e delicata situazione non è affatto predeterminato. Dipende in larga misura dalla capacità di reazione e dall’azione collettiva dei cittadini.
Su quali basi concrete si afferma l’esistenza di uno ‘stato di eccezione quasi normale’ e di un’oligarchia che agisce al di fuori delle regole?
Il capitolo, pur offrendo una diagnosi preoccupante, non approfondisce le basi empiriche o teoriche su cui poggia l’affermazione di uno ‘stato di eccezione quasi normale’ e di un’oligarchia che bypassa le regole democratiche. Per comprendere meglio la natura di queste dinamiche e valutare la fondatezza di tali asserzioni, sarebbe utile esplorare gli studi sulla teoria delle élite (si pensi a Mosca o Pareto), le analisi del diritto costituzionale e degli stati d’eccezione (come quelle di Schmitt o Agamben), e le ricerche sulla trasformazione dei partiti politici e delle istituzioni democratiche contemporanee.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]