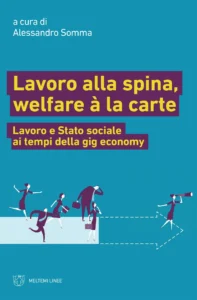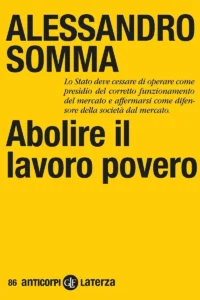1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Dopo le crisi. Dialoghi sul futuro dell’Europa” di a Somma ti porta dentro un’analisi super schietta di come funziona davvero l’Unione Europea, specialmente dopo le botte prese con le crisi recenti, dalla finanza alla pandemia. Non è una storia con personaggi, ma un viaggio tra le strutture che ci governano: la politica economica europea, l’ordoliberalismo che la domina, e come l’unione monetaria europea, l’Eurozona, mette sotto pressione gli stati e il mercato del lavoro Europa. Il libro scava a fondo nel perché le regole fiscali UE, il Patto di Stabilità, e il debito pubblico Europa creano un equilibrio precario, e come istituzioni tipo la BCE (Banca Centrale Europea) e strumenti come il Next Generation EU (NGEU) funzionano, spesso con condizionalità UE che limitano la sovranità nazionale UE e lo stato sociale Europa. Si parla anche di come la globalizzazione e l’immigrazione e lavoro cambiano tutto, e della tensione costante tra mercato e democrazia Europa. È un libro che ti fa capire che il futuro Europa non è scontato e dipende da come affrontiamo queste sfide, superando la costituzione economica europea attuale.Riassunto Breve
L’integrazione europea si basa principalmente su un modello economico che privilegia la stabilità dei prezzi, la disciplina fiscale e la concorrenza di mercato, influenzato da idee ordoliberali. Questo approccio limita la capacità degli Stati di usare la spesa pubblica per gestire crisi o disoccupazione e impone riforme orientate al mercato attraverso condizionalità. Le decisioni politiche vengono spesso presentate come tecniche, riducendo il dibattito democratico. La globalizzazione e la libera circolazione di lavoratori aumentano la concorrenza sul lavoro tra paesi diversi, mettendo pressione al ribasso sui salari e indebolendo il potere contrattuale dei lavoratori, un effetto particolarmente visibile con i flussi migratori. L’unione monetaria manca di un bilancio federale significativo e di una banca centrale che sostenga pienamente i debiti nazionali, costringendo i paesi in difficoltà a ridurre costi interni, spesso causando disoccupazione. Le regole fiscali europee sono viste come superate e dannose, specialmente in crisi, anche se la pandemia ha portato a una sospensione temporanea e a nuovi strumenti come Next Generation EU. Questo piano, pur introducendo debito comune e trasferimenti, è considerato una misura temporanea legata a strette condizioni e obiettivi di performance, mantenendo una logica di controllo tipica del modello dominante. La struttura europea favorisce gli interessi finanziari, con la “primazia del creditore” come principio centrale, evidente nei meccanismi di condizionalità e nel mandato della Banca Centrale Europea, che privilegia la stabilità dei prezzi su crescita e occupazione. Gli Stati sono obbligati a finanziarsi sul mercato, dando ai creditori privati un ruolo di controllo. Questa impostazione si scontra con i principi sociali e di giustizia fiscale delle costituzioni nazionali. Le crisi tendono a rafforzare questa struttura basata sul mercato, usando il debito come strumento di controllo sugli Stati. Il ritorno a regole fiscali rigide dopo la pandemia rischia di bloccare la crescita e rendere il debito insostenibile. La Banca Centrale Europea, pur indipendente, ha un ruolo politico significativo, ma la sua responsabilità democratica è limitata. Il futuro dell’Europa è incerto, con la necessità di bilanciare l’autonomia nazionale con una maggiore coesione per affrontare le sfide geopolitiche, ma la volontà politica per un’unione federale forte e con una dimensione sociale robusta non sembra ancora esserci.Riassunto Lungo
1. Crisi, Europa e Concorrenza sul Lavoro
Le crisi non portano automaticamente a miglioramenti, ma mettono in luce la necessità di cambiare, a patto di analizzare bene le cause. Le risposte date dalle istituzioni europee alle crisi recenti, inclusa la pandemia, mostrano che l’approccio è cambiato solo in piccola parte. I principi fondamentali della struttura economica europea, come la disciplina fiscale molto rigida e le riforme orientate al mercato con precise condizioni, restano al centro di tutto. Un progetto di unione che si basa principalmente sul mercato interno non favorisce un forte intervento dello Stato nell’economia. Questi principi guidano le decisioni economiche, limitando la possibilità di un forte intervento pubblico a favore di soluzioni basate sul mercato interno.La natura dell’integrazione europea
L’idea di un’Unione sempre più unita si vede nella rigida disciplina economica e nei limiti alla spesa pubblica, che riguardano anche le politiche fiscali e del lavoro dei singoli paesi. Questo avvicinamento avviene spesso senza che ce ne si accorga, cambiando a poco a poco le leggi interne degli Stati. Le scelte politiche vengono presentate come decisioni tecniche, senza altre strade possibili, in un sistema dove i tecnici hanno molto potere e limitano il dibattito. Le decisioni economiche sono dominate dal pensiero legato al mercato libero (neoliberale), lasciando fuori altre idee. L’Unione si è rafforzata attraverso le leggi, con organismi come la Corte di Giustizia che hanno favorito un approccio basato sull’ordine e sul mercato libero (ordoliberale).Evoluzione e nuove parole d’ordine
Dopo il trattato di Maastricht (dal 1993 al 2004), c’era ottimismo: l’Euro, l’allargamento a nuovi paesi e l’idea di una Costituzione sembravano i punti di forza. L’Euro serviva a imporre regole di bilancio severe e politiche che tenevano bassi i prezzi e i salari. Dopo il 2005, le crisi economiche e alcuni voti contrari hanno portato a un periodo di incertezza e persino di ostilità verso l’Europa (“Eufobia”). La pandemia ha introdotto nuove parole come “resilienza”, “digitale” e “verde”, ma l’idea di base legata al mercato libero non è cambiata. Il Piano di Ripresa (Recovery Plan) mantiene la richiesta di riforme e l’adattamento ai piani economici generali. Essere “resilienti” significa che sia i cittadini sia gli Stati devono adattarsi alle regole del mercato. Parole come “equità” e “inclusione” servono a creare un clima tranquillo per rendere il mercato del lavoro più efficiente, non a promuovere una vera giustizia sociale o a ridistribuire la ricchezza.Globalizzazione e impatto sul lavoro
La globalizzazione, con la libertà di spostare capitali, merci e persone, rende difficile migliorare le condizioni di chi lavora. Questo crea competizione tra i lavoratori di paesi diversi, che hanno situazioni e consapevolezze diverse. L’arrivo di lavoratori da altri paesi è il modo più diretto in cui si manifesta questa competizione. L’immigrazione, spinta da eventi internazionali e scelte politiche, aumenta la disponibilità di lavoratori disposti ad accettare paghe basse. Questo abbassa i salari per tutti, anche per i lavoratori del posto. Molti economisti ufficiali negano questo effetto negativo sui salari, ma è chiaro che i lavoratori hanno meno forza nel negoziare le proprie condizioni, soprattutto nei servizi. L’immigrazione mette a disposizione lavoratori pronti ad accettare condizioni che i lavoratori locali, più protetti dalle leggi, rifiutano. Questi nuovi lavoratori prendono il posto dei vecchi in quella che viene chiamata “riserva di manodopera”. La sinistra, concentrandosi sull’antirazzismo e sul rispetto delle diverse culture e mettendo da parte l’idea di difendere gli interessi nazionali, non affronta gli effetti negativi che l’immigrazione ha sul lavoro.Come si può affermare con tanta sicurezza che l’immigrazione abbassi i salari per tutti, quando il dibattito economico su questo punto è tutt’altro che chiuso?
Il capitolo presenta una specifica visione sul rapporto tra immigrazione e salari, riconoscendo ma liquidando rapidamente le prospettive economiche opposte. Per comprendere la complessità di questo argomento, è fondamentale esplorare le diverse scuole di pensiero economico e sociologico. Approfondire gli studi sull’impatto della migrazione sui mercati del lavoro, considerando sia gli effetti diretti sui salari sia quelli indiretti su produttività, innovazione e domanda aggregata, è cruciale. Autori come George Borjas presentano argomenti a favore di un impatto negativo sui salari dei lavoratori meno qualificati, mentre David Card offre prospettive che evidenziano impatti più limitati o nulli, o addirittura positivi in determinate condizioni. È utile anche considerare le analisi sociologiche che esaminano l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e le dinamiche di competizione e cooperazione tra diversi gruppi di lavoratori.2. Le fondamenta fragili dell’unione monetaria europea
Per funzionare bene, un’area dove si usa la stessa moneta dovrebbe unire regioni simili tra loro. Oppure, se le regioni sono diverse, dovrebbero esserci modi per gestire le differenze, come permettere alle persone di spostarsi facilmente per lavoro o avere un bilancio comune che aiuta le zone in difficoltà. L’unione monetaria europea, invece, unisce paesi con economie molto diverse. Manca un bilancio centrale abbastanza grande e una banca centrale che possa aiutare pienamente i debiti dei singoli stati. Questa struttura rende difficile per i paesi affrontare da soli i momenti di crisi economica.La priorità alla stabilità dei prezzi
L’impostazione dell’unione si basa molto sull’idea di dare priorità alla stabilità dei prezzi e al rispetto delle regole di mercato. Questo limita la possibilità per i singoli stati di usare le proprie politiche economiche, come spendere di più o meno, per gestire le crisi o la disoccupazione. Senza la possibilità di cambiare il valore della propria moneta, i paesi che si trovano in difficoltà economiche sono costretti a ridurre i costi interni, come i salari e i prezzi. Questo processo, chiamato “svalutazione interna”, spesso porta a un aumento della disoccupazione perché le aziende e le persone faticano ad adattarsi. La rigidità di questo sistema rende la ripresa più lenta e dolorosa.Le regole fiscali e i loro limiti
Le regole fiscali che l’Europa usa oggi si basano su idee economiche che molti esperti considerano superate. Si appoggiano anche su calcoli che non si sono rivelati affidabili nella pratica. Queste regole hanno portato all’imposizione di politiche di austerità, cioè tagli alla spesa pubblica, che si sono dimostrate dannose. Questo è successo soprattutto nei momenti di crisi, perché le regole non tenevano abbastanza conto della situazione economica reale dei paesi. Anche se la pandemia ha sospeso temporaneamente queste regole, c’è il rischio concreto che vengano reintrodotte.Il dibattito sul futuro dell’Europa
Di fronte a queste sfide, il dibattito sul futuro dell’Europa è aperto. Da una parte, c’è chi pensa che i singoli paesi dovrebbero riprendere in mano il controllo delle proprie decisioni economiche. Dall’altra, c’è chi crede sia necessario costruire un’unione politica ed economica molto più forte a livello europeo. Quest’ultima opzione mirerebbe a perseguire anche obiettivi sociali comuni, non solo la stabilità economica. Tuttavia, creare un’Europa così unita e con una forte attenzione sociale è un percorso difficile. Potrebbe anche portare a concentrare troppo potere economico in poche mani o istituzioni. La direzione attuale, purtroppo, sembra essere quella di voler tornare alle regole fiscali rigide del passato.Ma se le regole fiscali europee si basano su idee “superate” e l’austerità è “dannosa”, perché il dibattito economico su questi temi è ancora così acceso e privo di consenso unanime?
Il capitolo afferma che le regole fiscali si basano su idee economiche superate e che l’austerità è stata dannosa. Tuttavia, la validità di tali idee e l’impatto reale delle politiche di austerità sono temi al centro di un acceso dibattito tra gli economisti, con posizioni molto diverse e prive di consenso unanime. Per comprendere appieno questa complessità, è fondamentale approfondire le diverse scuole di pensiero macroeconomico e la letteratura sulla politica fiscale nelle unioni monetarie. Approfondire il lavoro di autori come Olivier Blanchard o Joseph Stiglitz può offrire prospettive differenti su questi temi cruciali.3. L’Europa oltre Maastricht: Crisi, Geopolitica e Autonomia Strategica
Affrontare il futuro dell’Europa richiede di guardare alla realtà attuale senza farsi illusioni. La discussione che contrappone chi difende la sovranità nazionale a chi sostiene un’Europa idealizzata non aiuta a capire i veri problemi economici e legali che l’Unione deve affrontare. Questa divisione simbolica finisce per non cambiare lo stato attuale delle cose nell’economia.La pandemia come motore di cambiamento
La pandemia di Covid-19 è stata un evento che può portare a un cambiamento profondo nell’Unione europea. Questo cambiamento non deriva dalla modifica delle regole scritte nei trattati, ma è una conseguenza pratica della situazione che si è creata. È diverso da una semplice sospensione temporanea delle regole. La reazione dell’UE alla pandemia è stata differente rispetto a quella della crisi del 2008. Questo non dipende solo dalla natura diversa delle due crisi, ma soprattutto da come è cambiato il quadro politico globale.La sfida geopolitica e l’autonomia strategica
La competizione crescente tra Stati Uniti e Cina, unita alla dipendenza dell’Europa dalle tecnologie di queste grandi potenze, spinge a ripensare il progetto europeo. Da qui nasce l’idea di “autonomia strategica”. Questo significa che i paesi europei devono fare scelte politiche precise per rendere più forte l’unione monetaria e collaborare di più in settori chiave come la produzione e la tecnologia. Questo concetto segna un cambiamento rispetto all’approccio di Maastricht, che tendeva a separare l’economia dalla politica.Le tensioni nelle politiche europee
Questa spinta verso l’autonomia strategica crea tensioni in aree fondamentali. Il ruolo della Banca Centrale Europea (BCE) si è ampliato, e questo, pur essendo necessario, solleva interrogativi su come garantirne il controllo democratico. Programmi come Next Generation EU, anche se innovativi, mantengono ancora un legame con la vecchia logica delle condizioni da rispettare per ricevere i fondi. Anche la riforma delle regole di bilancio europee (il Patto di Stabilità) è indispensabile, ma non è chiaro se porterà a un ritorno all’austerità o a regole più flessibili.Il futuro dell’integrazione europea
Alla luce dei cambiamenti politici ed economici nel mondo, un semplice ritorno all’ordine stabilito dal Trattato di Maastricht sembra poco probabile. Per evitare di essere messi da parte nella nuova competizione globale, è fondamentale che i paesi membri costruiscano uno spazio europeo più unito e capace di adattarsi. Il futuro dell’integrazione europea richiede di andare oltre la sola logica economica e definire in modo politico quali settori l’Unione deve gestire insieme con maggiore forza e in quali invece lasciare più libertà ai singoli paesi.Ma è davvero sostenibile un’Europa che impone riforme e nuove tasse che sembrano ignorare i principi costituzionali nazionali e la legittimità democratica, specialmente in materia fiscale?
Il capitolo mette in luce la tensione tra le richieste di riforme legate agli aiuti europei e l’introduzione di nuove forme di tassazione a livello comunitario da un lato, e i principi fondamentali sanciti dalle costituzioni nazionali, come la progressività fiscale e la tutela dei diritti sociali, dall’altro. Questa frizione solleva interrogativi profondi sulla natura dell’integrazione europea, sulla sovranità degli stati membri e sulla legittimità democratica delle decisioni fiscali a livello sovranazionale, in assenza di un pieno potere fiscale del Parlamento europeo. Per comprendere meglio questa complessa dinamica e le sue implicazioni, è fondamentale approfondire lo studio del diritto costituzionale comparato, del diritto dell’Unione Europea (in particolare il rapporto tra diritto UE e diritto interno), e della political economy dell’integrazione europea. Autori come Stiglitz offrono spunti critici sulla governance economica europea e sulle sue conseguenze sociali e politiche.8. La Sfida della Crescita tra Regole Fiscali e Indipendenza della BCE
Dopo la pandemia, l’Italia si trova ad affrontare una situazione economica difficile, con una diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) e dell’occupazione. Già nel 2019, i livelli non avevano recuperato quelli del 2007, specialmente per quanto riguarda le ore lavorate. A questo si aggiunge un aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL. Per migliorare questa situazione, è essenziale avere tassi di interesse bassi sul debito e una crescita economica forte e duratura.Le Regole Fiscali e la Crescita
La crescita economica dipende molto dalla domanda generale di beni e servizi. Il ritorno alle vecchie regole fiscali del Patto di Stabilità, che puntano a bilanci in pareggio e avanzi primari (cioè entrate superiori alle spese al netto degli interessi sul debito), rende complicato stimolare questa domanda. Se queste regole rientrano in vigore, i fondi e gli investimenti previsti dal Recovery Plan potrebbero dover semplicemente sostituire altre spese pubbliche già esistenti, invece di aggiungersi ad esse. Questo limiterebbe l’effetto positivo sulla crescita.I Rischi delle Politiche di Austerità
Tornare a politiche di rigore, simili a quelle del passato, può frenare la ripresa economica. Questo scenario rischia di causare la chiusura di molte imprese e di aumentare ulteriormente il rapporto debito/PIL, portando a una situazione insostenibile. In un caso estremo, si potrebbe arrivare a una ristrutturazione del debito, con conseguenze molto gravi per le banche e per l’intera economia del paese. Un possibile freno a questi scenari negativi potrebbe arrivare da una forte opposizione sociale o da risultati elettorali che portino a scelte politiche meno restrittive.Proposte per una Maggiore Flessibilità
Per avere più margini di manovra, gli Stati dovrebbero poter usare meglio gli strumenti a loro disposizione per la politica economica e sociale. Una proposta concreta è la “golden rule”, una regola che permetterebbe di non considerare gli investimenti pubblici nel calcolo del disavanzo e del debito. Questo darebbe ai governi più spazio per fare investimenti necessari a stimolare l’economia.La Banca Centrale Europea: Natura e Indipendenza
Parallelamente a queste questioni fiscali, un ruolo cruciale è giocato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Essendo un’istituzione europea, la BCE è diversa dalle banche centrali dei singoli paesi. La sua indipendenza, spesso presentata come una caratteristica puramente tecnica, la posiziona in realtà in una sfera che ha forti implicazioni politiche. Questo crea una distanza dai principi democratici che regolano le istituzioni nazionali.Controllo sulla BCE e Funzioni Ampliate
Questa distanza si manifesta anche nel controllo giudiziario sugli atti della BCE, che tende ad essere debole e spesso superficiale. Negli anni, le funzioni della BCE si sono allargate, andando oltre la semplice gestione della politica monetaria per includere anche la vigilanza sulle banche. Questo mescola di fatto la politica monetaria con quella economica e finanziaria. Tuttavia, il controllo giudiziario su queste nuove funzioni rimane limitato.Organi di Revisione Interni e Necessità di Riforme
Esistono degli organi interni alla BCE che dovrebbero controllare il suo operato, ma la loro efficacia è ridotta. Le decisioni di questi organi non sono rese pubbliche, la nomina dei loro membri è legata alla stessa BCE, e i loro pareri non sono vincolanti. Per migliorare la responsabilità democratica della BCE e renderla più trasparente, sono necessarie riforme che aumentino la trasparenza, garantiscano una maggiore indipendenza di questi organi e rafforzino il loro potere decisionale.Ma l’indipendenza della BCE è davvero solo un problema di “distanza democratica”, o serve a qualcosa di fondamentale per l’economia?
Il capitolo solleva giustamente il tema della responsabilità democratica della Banca Centrale Europea, ma non approfondisce a sufficienza le ragioni economiche e storiche che hanno portato alla scelta dell’indipendenza delle banche centrali. Questo aspetto è cruciale per comprendere il dibattito e le possibili riforme. Per avere un quadro più completo, sarebbe utile studiare i principi di economia monetaria, la storia delle crisi inflazionistiche e il dibattito sull’opportunità di sottrarre la politica monetaria alle pressioni politiche di breve termine. Autori come Paul De Grauwe o altri economisti che si occupano di politica monetaria e istituzioni europee possono offrire prospettive diverse su questo complesso equilibrio tra indipendenza tecnica e legittimità democratica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]