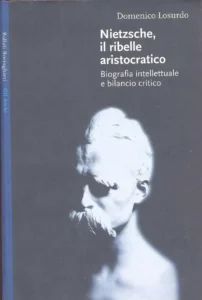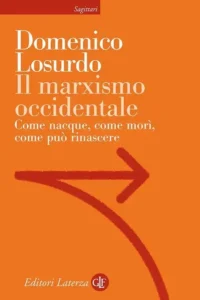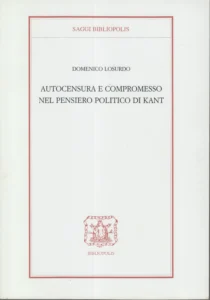1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Domenico Losurdo tra filosofia, storia e politica” di Domenico Losurdo è quel tipo di libro che ti prende e ti sbatte in faccia come le idee filosofiche si legano a doppio filo con la storia vera, quella fatta di rivoluzioni come la Rivoluzione francese, di lotte per l’emancipazione e pure di contraddizioni pazzesche. Qui si parla di come pensatori come Kant, Hegel e Marx hanno provato a capire il mondo, confrontandoli tra loro e vedendo come le loro idee sulla libertà, sull’universalismo o sulla guerra non erano campate in aria, ma figlie del loro tempo e spesso usate in modi inaspettati. Losurdo ti fa riflettere sul liberalismo, mostrandoti il suo lato oscuro legato alla schiavitù e all’esclusione, e poi analizza la crisi del marxismo dopo la sconfitta sovietica, proponendo una sua rilettura della lotta di classe che va oltre l’economia, includendo la lotta per il riconoscimento e l’emancipazione politica contro le disuguaglianze del capitalismo contemporaneo. Non è solo teoria, è un viaggio nella storia della filosofia e nella storia tout court, che ti costringe a guardare con occhi diversi figure come Stalin o a capire il legame tra il pensiero di Heidegger e la politica, facendoti capire quanto sia cruciale analizzare l’ideologia e la falsa coscienza per non cadere in trappole concettuali. È un libro pieno di spunti che ti sfida a pensare in modo critico il rapporto tra filosofia, storia e politica, un tema centrale nel pensiero di Domenico Losurdo.Riassunto Breve
La filosofia è profondamente legata al suo tempo e alle grandi lotte storiche, specialmente quella per l’emancipazione universale dell’uomo. Pensatori come Kant e Hegel hanno combattuto contro il vecchio ordine feudale e hanno valorizzato una conoscenza che richiede impegno, vedendo la Rivoluzione francese come un momento chiave per affermare libertà e uguaglianza giuridica. La lotta per un concetto universale di uomo, che superi le discriminazioni basate su ricchezza, genere o razza, è un filo conduttore che lega Kant, Hegel e Marx. Esiste però un “falso universalismo” usato per nascondere interessi di potere e oppressione, come nel neocolonialismo, mentre il vero universalismo accoglie le differenze. Dopo Hegel e Marx, non si può più ignorare che ogni pensiero è influenzato dalla sua epoca; la filosofia rischia di diventare ideologia, una falsa coscienza che nasconde interessi, se non analizza il tempo storico. È necessario unire l’ordine logico, che usa il principio di non-contraddizione per il discorso, con l’ordine storico, che riconosce le contraddizioni reali nella società. La società moderna, basata sul mercato e sulla divisione del lavoro, genera astrazione e impersonalità, portando a contraddizioni come la disuguaglianza, che Hegel cercava di mitigare con istituzioni che introducessero eticità. L’analisi del liberalismo mostra che, fin dalle origini, la libertà reclamata era spesso riservata a un gruppo ristretto, il “popolo dei signori”, e si legava alla schiavitù e all’esclusione, dimostrando che il mercato è stato storicamente anche un luogo di riduzione dell’uomo a merce. La non-violenza, in questo contesto di conflitto, è una strategia per indebolire un avversario violento, ma la sua efficacia dipende dal mettere in discussione il sistema che crea ingiustizia. La crisi del marxismo dopo la fine dell’Unione Sovietica ha mostrato i limiti di un approccio utopico e la necessità di una visione più realistica, che veda la lotta di classe in modo più ampio, come una lotta per il riconoscimento che include dimensioni sociali, internazionali e di genere. Il capitalismo, pur promuovendo l’uguaglianza formale, non ha realizzato pienamente l’emancipazione politica globale, mantenendo forme di dominio come il colonialismo. La lotta per uno Stato democratico dove il popolo controlla l’economia è una battaglia contro il capitalismo contemporaneo che usa la democrazia formale per aumentare le disuguaglianze reali. Comprendere la storia e le figure storiche richiede di andare oltre le “leggende nere”, contestualizzando gli eventi e confrontando le azioni dei diversi sistemi, riconoscendo che la storia è fatta di conflitti di potere. Anche le scelte di vita e le idee dei filosofi, come Wittgenstein o Heidegger, sono connesse al loro contesto storico e alle loro posizioni politiche, mostrando come il pensiero sia messo alla prova nella realtà storica e nei conflitti.Riassunto Lungo
1. La Filosofia Politica di Kant e la Lotta per l’Uomo Universale
La filosofia politica di Kant ha un legame forte con la Rivoluzione francese. Questo evento storico è visto come un cambiamento profondo nel modo in cui lo Stato e il popolo interagiscono, basato sui principi fondamentali di libertà e uguaglianza di fronte alla legge. Kant mette in contrasto l’idea di un individuo capace di pensare e agire in modo autonomo con la visione dello Stato come una semplice macchina. Per lui, è essenziale che l’ordine sociale sia costruito sulla base della ragione e del pensiero critico.Il confronto con Hegel
Il pensiero di Kant si confronta in modo significativo con quello di Hegel. Entrambi i filosofi si schierano contro le idee tipiche della società feudale e rifiutano un tipo di conoscenza basato solo sull’intuizione immediata. Al contrario, entrambi danno grande valore a una conoscenza che richiede impegno, studio e riflessione profonda. Anche se Hegel muove alcune critiche al pensiero di Kant, riconosce che esso rappresenta un punto di partenza fondamentale per la filosofia tedesca successiva. Vede anche un parallelismo tra il pensiero kantiano e l’importanza storica della Rivoluzione francese.La visione di Kant su guerra e pace
La posizione di Kant riguardo alla guerra è piuttosto articolata e non semplice. Da un lato, promuove con forza l’ideale della pace perpetua, considerandola un obiettivo importante da raggiungere in futuro per l’umanità intera. Dall’altro lato, riconosce che in determinate circostanze la guerra potrebbe, paradossalmente, favorire la libertà o aiutare a limitare il potere eccessivo di un despota. Kant critica in modo esplicito e netto pratiche come il colonialismo e la schiavitù, considerandole ingiuste. Non sarebbe corretto presentare Kant solo come il filosofo della pace in contrapposizione a Hegel come filosofo della guerra, poiché la realtà del loro pensiero è più sfumata.Il diritto di resistenza e la strategia politica
Quando Kant nega il diritto dei cittadini di resistere al potere costituito, questa posizione non va interpretata semplicemente come un atteggiamento conservatore o di sottomissione. Al contrario, viene letta da alcuni come una scelta strategica molto precisa, probabilmente influenzata anche dalla censura che era presente all’epoca in cui scriveva. L’obiettivo di questa posizione sarebbe stato quello di proteggere e consolidare i risultati positivi ottenuti dalla rivoluzione, per evitare che si tornasse indietro verso il vecchio sistema feudale. Inoltre, voleva prevenire situazioni di caos incontrollato o il rischio che il potere finisse nelle mani arbitrarie di masse non preparate, suggerendo un uso della dissimulazione nel suo modo di esporre certe idee.La lotta per il concetto universale di uomo
Questa discussione si inserisce in una lotta storica molto più ampia e fondamentale: quella per affermare il concetto di uomo come essere universale, valido per tutti, indipendentemente dalle differenze. Questo tema è stato centrale nel pensiero di figure come Kant, Hegel e Marx. L’obiettivo di questa lotta è superare ogni forma di discriminazione basata sulla ricchezza, sul genere, sulla provenienza geografica o sulla razza. Esiste una critica verso quello che viene definito “falso universalismo”, che è spesso utilizzato da potenze dominanti per nascondere i propri interessi particolari e giustificare l’oppressione, come accade nel neocolonialismo. Il vero universalismo, invece, non cancella le differenze, ma le include e le valorizza all’interno di un quadro di uguaglianza fondamentale. Il movimento comunista, nel corso della storia, ha avuto un ruolo attivo in questa battaglia contro le discriminazioni e per l’affermazione dei diritti universali. La sinistra nel mondo di oggi appare indebolita, in parte per aver preso le distanze dalla propria storia e dalla difficoltà di affrontare le ingiustizie concrete. Spesso si rifugia in critiche generiche che evitano di individuare chiaramente chi sono i responsabili delle ingiustizie attuali.L’interpretazione della negazione kantiana del diritto di resistenza come mera “strategia” per eludere la censura non rischia di minimizzare aspetti potenzialmente più problematici della sua filosofia politica?
Il capitolo propone una lettura specifica e benevola della posizione di Kant sulla resistenza. Tuttavia, questa interpretazione, che attribuisce la negazione del diritto a fattori esterni come la censura o a obiettivi strategici di consolidamento rivoluzionario, potrebbe non esaurire la complessità del pensiero kantiano sul rapporto tra autorità e cittadino. Per comprendere appieno questa controversa posizione, è fondamentale esaminare direttamente i testi politici di Kant, considerare il contesto storico-politico prussiano in cui scriveva, e confrontare le diverse interpretazioni proposte dalla storiografia filosofica. Approfondire autori che hanno analizzato criticamente la filosofia politica kantiana può offrire prospettive alternative.2. La Svolta che Unisce Logica e Storia
Dopo pensatori come Hegel e Marx, la filosofia non può più ignorare quanto le idee siano legate al loro tempo storico. Questa è una svolta fondamentale. Hegel ha mostrato che ogni filosofia è figlia della sua epoca. Marx ha approfondito questo concetto con l’idea di ideologia, che è una sorta di falsa visione che nasconde interessi specifici. Nonostante questo legame con la storia, la filosofia non è solo un riflesso del suo tempo; c’è una parte di verità o di conoscenza che va oltre la semplice ideologia.Il Rischio dell’Ideologia e Come Evitarlo
Quando la filosofia non analizza il contesto storico, rischia di diventare essa stessa ideologia. Non studiare la società e la storia porta a riflettere la realtà in modo passivo, come “acque stagnanti”. È cruciale distinguere tra ciò che è temporale, cioè parte del tempo, e ciò che è solo temporaneo, destinato a passare. La capacità della filosofia di andare oltre il tempo non elimina la dimensione temporale, ma supera ciò che è semplicemente passeggero. Per evitare che la filosofia si perda nell’ideologia, servono due cose: capire la storia da un punto di vista filosofico, analizzando eventi e concetti politici in modo ampio, e studiare la storia delle idee filosofiche, includendo una critica delle ideologie.Errori del Passato
Alcuni pensatori del passato si sono concentrati troppo su un solo aspetto. Pensatori come Eraclito hanno visto il cambiamento costante (l’aspetto storico) ma hanno trascurato ciò che rimane identico e universale (l’aspetto logico). Altri, come Aristotele, hanno dato grande importanza alla regola del non-contraddizione e all’ordine logico, ma hanno mostrato meno attenzione ai processi e alla storia. Usare solo la regola del non-contraddizione per capire la realtà sociale può portare a idee sbagliate, facendo sembrare verità assolute dei rapporti che invece dipendono da un momento storico preciso. La realtà sociale e storica contiene contraddizioni reali, non solo logiche.L’Integrazione di Logica e Storia: L’Intuizione di Hegel e Marx
Hegel e Marx hanno saputo unire l’aspetto logico e quello storico. Hanno dimostrato che per capire la realtà servono sia la regola del non-contraddizione per un pensiero chiaro, sia la capacità di riconoscere le contraddizioni reali nella storia e nella società. Ignorare questo legame porta a spiegazioni insufficienti, come dire che un errore filosofico è dovuto a follia o disonestà, invece di vederne le cause storiche e sociali. La grande innovazione di Hegel e Marx sta nell’aver capito che una logica che cerca la verità deve includere anche una logica che riconosce il falso, e che l’ordine logico del pensiero deve basarsi sull’ordine storico degli eventi.La Società Moderna Secondo Hegel
Hegel ha analizzato la società moderna, che ha chiamato bürgerliche Gesellschaft (società civile). Questa società si basa sui bisogni delle persone e sul mercato, che funzionano con una logica astratta e impersonale dovuta alla divisione del lavoro. Questo sistema, pur creando legami tra le persone, può portare a problemi come la grande differenza tra ricchezza e povertà. Per contrastare questa logica che vede la società come un sistema naturale o meccanico, Hegel ha proposto istituzioni come la giustizia, la polizia e le corporazioni. Queste hanno lo scopo di introdurre un senso di universalità e attenzione al bene comune, affiancando all’ordine astratto del mercato forme di eticità, cioè di vita morale e sociale condivisa.Ma questa “svolta” che unisce logica e storia, come presentata dal capitolo, è davvero l’unica o l’ultima parola sul rapporto tra pensiero e realtà?
Il capitolo pone l’integrazione hegelo-marxiana di logica e storia come la “grande innovazione” e la via per superare i limiti del pensiero precedente. Tuttavia, presentare questa sintesi come definitiva ignora le complesse evoluzioni filosofiche successive, che hanno criticato o proposto alternative a questo approccio. Per comprendere appieno il dibattito, è utile esplorare pensatori che hanno messo in discussione le pretese di totalità o di necessità storica della dialettica, come Nietzsche, o che hanno analizzato il rapporto tra sapere e potere in modi diversi, come Foucault, o che hanno sviluppato logiche non dialettiche. Approfondire queste prospettive può aiutare a contestualizzare e valutare criticamente la “svolta” descritta nel capitolo.3. Il Paradosso della Libertà e l’Ombra della Schiavitù
Il liberalismo si presenta spesso come un’idea di libertà per tutti, ma la sua storia è più complessa. Fin dalle sue origini, è stato strettamente legato alla schiavitù e all’esclusione, quasi fossero nati insieme. La libertà di cui parlavano i primi pensatori liberali, come Locke o Tocqueville, era pensata per un gruppo ristretto di persone, spesso chiamate il “popolo dei signori”, che in molti casi erano proprietari di schiavi. La schiavitù, che prendeva forme diverse (come merce, per i popoli nativi, o per i poveri), non era un semplice resto del passato. Era invece una condizione utile e necessaria perché il liberalismo potesse crescere, raggiungendo il suo momento di massima espansione proprio nel periodo in cui la schiavitù era più diffusa.Chi era libero? Il “popolo dei signori” e l’esclusione
Questo modo di vedere le cose ha creato una sorta di “democrazia del popolo dei signori”. In questa visione, l’uguaglianza e la libertà erano riservate solo a un gruppo specifico, scelto in base a caratteristiche come la proprietà o la razza. Tutti gli altri venivano esclusi e spesso non considerati pienamente umani. Per esempio, pensatori come Locke cercavano di giustificare la schiavitù. Usavano argomenti basati su interpretazioni della Bibbia o sull’idea che chi non lavorava la terra non avesse diritti, arrivando a considerare le persone non libere quasi come animali o semplici strumenti. Anche il mercato, che oggi vediamo come un luogo di libero scambio per tutti, nella storia è stato spesso un posto dove le persone venivano escluse o addirittura ridotte a merce da vendere.La non-violenza come strategia di cambiamento
In un contesto dove esistono forti disuguaglianze e oppressioni, la non-violenza emerge come una possibile strategia politica. Non va vista solo come un principio morale, ma come uno strumento efficace per indebolire un avversario che fa uso della violenza. Spesso, questa strategia cerca di usare la violenza stessa dell’oppressore per mostrare a tutti la sua illegittimità. Tuttavia, questa tattica presenta delle difficoltà: funziona al meglio quando l’avversario non può usare una violenza illimitata e a volte richiede decisioni difficili. I grandi movimenti storici che hanno usato la non-violenza dimostrano che è una pratica legata al bisogno di ottenere diritti o cambiare la situazione politica. La sua vera efficacia, però, dipende dalla capacità di mettere in discussione e cambiare il sistema sociale e politico che è la causa dell’oppressione e dell’ingiustizia.Ma la “leggenda nera” di Stalin non si basa anche su un’ampia documentazione storica di repressioni e violenze che il capitolo sembra voler contestualizzare fino a sminuire?
Il capitolo, nel suo tentativo di contestualizzare le repressioni degli anni Trenta all’interno di uno scenario di “guerra civile” e minaccia esterna, rischia di non rendere pienamente conto della vastità e della brutalità delle purghe, delle carestie indotte e del sistema dei gulag. Queste non sono solo frutto di una “leggenda nera” creata a posteriori, ma eventi storici ampiamente documentati da studi approfonditi. Per comprendere meglio questa complessità, è fondamentale approfondire la storia interna dell’Unione Sovietica staliniana, studiando le opere di storici che hanno analizzato in dettaglio le dinamiche del potere, le repressioni e le loro conseguenze sulla popolazione. Si consiglia di consultare studi sulla storia sovietica del periodo staliniano, ad esempio quelli di Robert Conquest o Orlando Figes.8. La prova del pensiero nella guerra
Per comprendere davvero il pensiero di filosofi come Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger, è essenziale considerare le loro vite e il periodo storico in cui hanno vissuto. Le scelte personali, come l’arruolamento volontario di Wittgenstein nella Prima guerra mondiale, possono essere viste come azioni con un significato politico profondo.Ludwig Wittgenstein: la prova personale nella guerra
Wittgenstein cercava nella guerra una sfida interiore, un modo per confrontarsi con l’idea della morte e trovare chiarezza per il suo carattere e il suo lavoro filosofico. Sperava forse di trovare un senso di comunità al fronte, ma incontrò invece disillusione e si sentì isolato tra i suoi compagni soldati. L’esperienza della morte divenne centrale per lui, vista come un elemento capace di dare valore alla vita e di infondere il coraggio necessario per affrontare sé stessi con onestà.Martin Heidegger: critica della modernità e politica
Fin dai suoi primi scritti, Martin Heidegger mostrò una netta opposizione alla modernità. La sua critica alla metafisica e alla ragione è legata al desiderio di superare il presente e il passato moderno, guardando a un futuro che sembrava prefigurato da epoche passate idealizzate, come il mondo dei filosofi presocratici o il periodo pre-industriale. Questo pensiero si manifesta nella sua critica della tecnica, che considerava il punto più alto della metafisica, capace di ridurre ogni cosa a un semplice oggetto da manipolare, contrapponendola all’idea dell’ente come “cosa” con una sua essenza profonda. La posizione politica di Heidegger, inclusa la sua adesione al nazionalsocialismo, è vista come strettamente connessa a questo suo grande progetto filosofico di superare la modernità. Capire questi pensatori significa riconoscere il forte legame tra le loro idee e il loro coinvolgimento nella storia e nelle vicende personali.Ma siamo sicuri che il legame tra il pensiero di Heidegger e la sua adesione al nazismo sia così diretto e univoco come suggerisce il capitolo?
Il capitolo presenta il legame tra la critica heideggeriana della modernità e la sua adesione al nazionalsocialismo come un dato di fatto quasi assodato. Tuttavia, la relazione tra la filosofia di Heidegger e il suo coinvolgimento politico è oggetto di un vastissimo dibattito interpretativo che divide gli studiosi da decenni. Affermare una connessione così “stretta” senza menzionare la complessità e le diverse posizioni critiche rischia di semplificare eccessivamente una questione cruciale. Per approfondire, è indispensabile confrontarsi con la letteratura critica su Heidegger, esplorando le diverse tesi sul rapporto tra il suo pensiero e la politica, e considerando le analisi di autori che hanno affrontato questo nodo problematico da prospettive differenti.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]