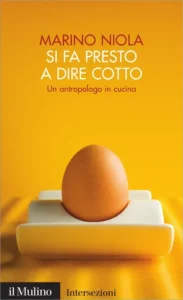1. Il Mito del Dissoluto e l’Ospite d’Oltretomba
Don Giovanni è un mito che tocca aspetti profondi dell’esistenza umana. È un uomo dominato da una sensualità potente e incontenibile, un seduttore seriale che ignora ogni legge, sia umana che divina. La sua figura va oltre quella del semplice conquistatore; incarna un disprezzo radicale per le regole e una spinta alla trasgressione che non si ferma nemmeno di fronte all’idea della morte. La sua dissolutezza rappresenta una sfida aperta alle norme sociali e morali stabilite. Il suo atteggiamento verso la religione non è una scelta filosofica, ma nasce dalla sua natura istintiva e sensuale che rifiuta ogni limite, in particolare quello imposto dal matrimonio. Non nega i dogmi, ma li usa per i suoi inganni, dimostrando una forza che deriva dall’essere guidato unicamente dall’istinto. La figura di Don Giovanni non ha un’identità fissa e immutabile, ma è piuttosto una forza di desiderio in continuo movimento, attratta dal mondo femminile in generale. La sua vera identità si manifesta e prende forma attraverso l’elenco delle sue innumerevoli conquiste.L’Incontro con l’Ospite d’Oltretomba
Un momento centrale e cruciale del mito è l’incontro con il morto, il convitato di pietra. Dopo aver ingannato una donna e ucciso suo padre in duello, Don Giovanni osa invitare a cena la statua funeraria del Commendatore ucciso. Contro ogni aspettativa, il morto accetta l’invito e si presenta, non come uno spettro, ma come una statua che prende vita, venuta per punire il dissoluto. Anche quando si trova faccia a faccia con la morte e la prospettiva dell’inferno, Don Giovanni mantiene la sua sfida e rifiuta ostinatamente di pentirsi dei suoi atti. Questo scontro tra la sua natura trasgressiva e la giustizia che arriva dal soprannaturale è l’elemento portante della storia. La figura del convitato di pietra è profondamente legata alle credenze cristiane sul Purgatorio e sull’idea che i defunti possano tornare per ristabilire la giustizia divina, temi molto sentiti nella cultura dell’epoca post-Concilio di Trento. L’invito rivolto a un morto è visto come un’offesa gravissima alla pietà e al rispetto cristiano.Le Origini Teatrali del Mito
Il personaggio di Don Giovanni compare per la prima volta nel teatro barocco, grazie all’opera di Tirso de Molina nel Seicento. Da lì, la sua figura è stata ripresa e trasformata da diverse tradizioni teatrali, inclusa la Commedia dell’arte, e da autori importanti come Molière. Tuttavia, è la versione creata da Mozart e dal librettista Da Ponte che è diventata il modello per eccellenza del mito, quella più conosciuta e influente. Il teatro, fin dalle sue origini, si conferma come il luogo fondamentale dove il mito di Don Giovanni prende vita, si sviluppa e raggiunge la sua massima espressione e il suo prestigio duraturo. Il mito si è evoluto nel tempo attraverso varie forme narrative, ma ha sempre mantenuto saldi i suoi elementi essenziali: la dissolutezza del protagonista e il suo incontro fatale e inevitabile con l’ospite che arriva dall’aldilà per reclamare giustizia.Ma come può una figura nata in un’opera teatrale specifica essere definita un “mito” nel senso classico?
Il capitolo introduce Don Giovanni come un “mito” che tocca aspetti profondi dell’esistenza, per poi descriverne le origini precise nel teatro barocco con Tirso de Molina. Questa presentazione sequenziale crea una potenziale ambiguità: si tratta di un mito preesistente adattato al teatro, o di una creazione teatrale che ha assunto uno status mitico? La distinzione è cruciale per comprendere la natura del personaggio. Per esplorare questa tensione e capire come una figura letteraria o teatrale possa trascendere la sua origine per diventare un simbolo culturale duraturo, sarebbe utile consultare studi sulla teoria del mito, sulla ricezione delle opere letterarie e sulla storia delle idee. Approfondire il pensiero di autori che hanno analizzato la funzione dei miti nella società e nella cultura può fornire gli strumenti critici necessari.2. La vendetta del teschio invitato
La storia di un giovane che insulta un morto e viene punito ha radici antiche. Una versione molto conosciuta è quella del conte Leonzio. Questa storia narra di un giovane che non crede in Dio e che, trovando un teschio in un cimitero, lo prende in giro e lo invita a cena. Il morto accetta l’invito, si presenta e uccide violentemente il giovane.Il significato morale e l’uso della leggenda
Questa narrazione fu usata in passato per dare insegnamenti morali. Ad esempio, i gesuiti la utilizzarono a Ingolstadt nel 1615 per mettere in guardia contro l’ateismo e le idee di Machiavelli, che era visto come un cattivo maestro. In alcune rappresentazioni dell’epoca, l’immagine di Machiavelli veniva addirittura bruciata. Spesso, il giovane protagonista di queste storie, descritto come una persona che vive in modo sregolato, è presentato come italiano.Il legame con il culto dei morti
La leggenda si collega strettamente al culto delle anime che si crede siano in purgatorio. Offendere i morti, in questo contesto, significa mancare di rispetto a queste anime, che spesso si pensa abbiano bisogno di preghiere e suffragi. Luoghi come il cimitero delle Fontanelle a Napoli, famoso per i suoi numerosi teschi anonimi chiamati “anime pezzentelle”, sono ambientazioni ideali per storie simili, dove il defunto offeso torna dal mondo dei morti per vendicarsi.Dalla leggenda al teatro
Nelle versioni teatrali della storia, il teschio non si limita a presentarsi, ma si trasforma in una statua che prende vita. Un esempio celebre è quello del Burlador de Sevilla dello scrittore Tirso de Molina. Questa trasformazione scenica non solo permette effetti visivi più potenti, ma si lega anche a simboli antichi che associano la pietra alla morte e al mondo dei defunti.L’influenza della Commedia dell’Arte
La commedia dell’arte italiana, specialmente quella sviluppata a Napoli, ha avuto un ruolo fondamentale nel far conoscere questa leggenda in tutta Europa. Adattando la storia di Tirso, gli attori della commedia dell’arte hanno messo in risalto gli aspetti più divertenti e hanno dato grande importanza ai personaggi dei servi. Questo adattamento ha contribuito in modo decisivo a definire il personaggio di Don Giovanni come lo conosciamo oggi: un uomo che non crede in Dio, un grande seduttore e un burlone. Alcuni studiosi suggeriscono che la figura del Capitano, un personaggio tipico della commedia dell’arte, possa avere qualche legame con il nome dato al teschio in alcune varianti della leggenda.Davvero la Commedia dell’Arte, con i suoi lazzi e servi, basta a spiegare la metamorfosi di un teschio vendicativo nel seduttore Don Giovanni?
Il capitolo suggerisce che la Commedia dell’Arte abbia avuto un ruolo decisivo nel plasmare la figura di Don Giovanni, ma questa spiegazione rischia di apparire riduttiva. Come può una storia di un teschio vendicativo trasformarsi nel mito del seduttore impenitente solo grazie al teatro popolare? Per cogliere la profondità di questa metamorfosi, non basta guardare alla storia del teatro (studiando, ad esempio, autori come Flaminio Scala), ma è cruciale indagare il contesto culturale e sociale più ampio. Approfondire la storia delle idee e la storia della morale, magari leggendo autori che trattano del Seicento europeo, aiuterebbe a capire quali tensioni sociali e psicologiche abbiano reso il personaggio di Don Giovanni, con la sua sfida alle convenzioni e alla divinità, così rilevante e duraturo, ben oltre la sua origine di semplice monito morale.3. L’Eco dei Morti e il Tempo Dimenticato
Le Radici del Mito
Il mito di don Giovanni nasce dall’unione di leggende popolari e drammi religiosi. È legato al nome Giovanni e a credenze antiche sul ritorno dei morti. Questo tema si connette anche alla festa di san Giovanni, che unisce idee precristiane legate alla fertilità e al ritorno delle anime. San Giovanni Battista è una figura associata sia alle anime del purgatorio che ai condannati a morte, rinforzando il legame tra il mito e il mondo dei defunti.Il Confine tra Vivi e Morti
Un punto centrale del mito è la vicinanza pericolosa tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Questa prossimità è simboleggiata dal banchetto. Condividere il cibo con i morti è un forte tabù. L’unica eccezione è fatta per i poveri, visti in alcune tradizioni come rappresentanti terreni dei defunti. Il rifiuto del cibo da parte della statua o dello spettro è un chiaro avvertimento contro questa confidenza eccessiva. Ignorare questo avvertimento porta a conseguenze fatali. Questo motivo si trova anche in miti molto antichi, come quello di Persefone, che rimane legata all’Ade per aver mangiato un chicco di melograno.Il Difetto Fondamentale: Il Tempo Dimenticato
La dissolutezza di don Giovanni e la sua punizione più profonda derivano dalla sua trasgressione dei confini tra i mondi. Il suo difetto principale è un’offesa contro il tempo stesso. Vive unicamente l’istante presente, ignorando completamente il passato e la memoria. La statua animata non è solo un personaggio, ma agisce come un “monumento” che ricorda ciò che è stato dimenticato. La rovina di don Giovanni non è solo una questione morale, ma ha una base strutturale, legata a un “tempo abolito” che non può semplicemente essere ignorato per sempre.La Figura del Dissoluto
La figura di don Giovanni unisce diversi tratti: è il seduttore, il beffardo e il trickster. La sua lascivia si unisce a una sfida aperta all’ordine divino e temporale. Elementi come l’invito a cena a un morto e l’animarsi di una statua erano temi già presenti in altre opere teatrali del Seicento. Questo dimostra che questi motivi circolavano ampiamente. Il mito di don Giovanni non si esaurisce in una singola opera, ma si manifesta nelle sue diverse varianti, che ne rivelano la struttura profonda e complessa.Se Don Giovanni sfida Dio e la società, quali sono esattamente i pilastri teologici o filosofici che intende abbattere, al di là di una generica ‘empietà’?
Il capitolo descrive le azioni di Don Giovanni come una sfida radicale, ma non approfondisce sufficientemente il contesto filosofico e teologico dell’epoca barocca che egli contesta. Per comprendere appieno la portata della sua ribellione, sarebbe utile esplorare le correnti di pensiero che mette in discussione, come il giansenismo o le prime forme di libertinismo filosofico non solo sessuale. Approfondire autori come Pascal o Spinoza, che riflettevano profondamente su fede, morale e libertà, potrebbe fornire le chiavi per interpretare la natura esatta della sua “empietà” e della sua sfida all’ordine stabilito.5. Il corpo, il castigo e l’eterno seduttore
Nella storia del dissoluto punito, la distruzione fisica del corpo, come lo smembramento, richiama antichi riti e sottolinea il carattere pubblico della pena. Questo serve a mostrare la volontà della società di eliminare il male che la minaccia. Il teatro è il luogo ideale per rappresentare questo castigo. Nel Barocco, il corpo è una figura centrale per l’allegoria, specialmente il corpo morto o le sue parti. Racconti popolari mostrano incontri con spettri o statue animate che puniscono chi li ha offeso, a volte con la distruzione del corpo del trasgressore. Il corpo morto diventa un simbolo potente.La natura del dissoluto e il castigo che lo attende
La dissolutezza di don Giovanni è un impulso irrefrenabile, una voglia non controllata dalle regole sociali. Questa mancanza di rispetto per le leggi e la morale si manifesta nell’empietà, nella burla e nella seduzione. In questo contesto, il corpo, sia vivo che morto, diventa il teatro della punizione. La punizione finale, spesso inflitta da un morto o una statua che prende vita, è una forma di vendetta che ripristina l’ordine violato. L’idea centrale è che ‘non c’è debito che non si paghi’, un concetto che sottolinea l’inevitabilità della resa dei conti per chi sfida le norme.Come cambia la rappresentazione del castigo nel tempo
Con il passare dei secoli, il modo di rappresentare la punizione del dissoluto si trasforma. Dalla distruzione fisica del corpo, come si vedeva inizialmente, si passa a forme più simboliche e meno materiali. Esempi di queste nuove forme includono una stretta di mano fatale o un semplice grido che porta alla fine. Nei secoli successivi all’epoca di Mozart, la punizione soprannaturale, inflitta da entità dall’aldilà, tende a scomparire. Viene spesso sostituita da morti più terrene, come incidenti o decessi causati dal rimorso interiore. Questo cambiamento riflette un processo di interiorizzazione del senso di colpa e una visione più laica del destino umano.Il mito oggi: dal desiderio alla seduzione digitale
La musica di Mozart ridà forza al mito, esprimendo la tensione tra desiderio e legge. Il mito continua a vivere oggi, adattandosi alla società digitale e alle identità fluide. Il desiderio del seduttore si trasforma in un consumo veloce e seriale di relazioni, facilitato dalle app di incontri che permettono di accumulare conquiste come oggetti in una lista. Questa ricerca di piacere rapido non è più solo maschile. Nonostante i cambiamenti, la figura del seduttore mantiene il suo fascino, sfidando i limiti e le regole in contesti sempre nuovi.Ma il concetto di “non c’è debito che non si paghi” si applica ancora al seduttore digitale?
Il capitolo descrive efficacemente l’evoluzione storica del castigo del dissoluto, culminando nella sua trasformazione in un “consumo veloce e seriale di relazioni” nell’era digitale. Tuttavia, la connessione tra questa moderna forma di seduzione e l’antica idea di una resa dei conti inevitabile non è pienamente esplorata. Se la punizione si interiorizza o scompare del tutto, come si concilia ciò con il principio che ogni debito debba essere saldato? Per comprendere meglio questa apparente contraddizione, potrebbe essere utile approfondire studi sulla sociologia delle relazioni moderne, in particolare l’opera di autori come Zygmunt Bauman, e considerare le prospettive della psicologia contemporanea sul senso di colpa e le conseguenze delle azioni nell’era digitale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]