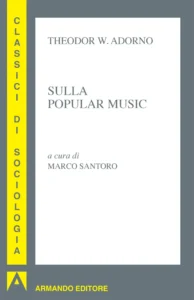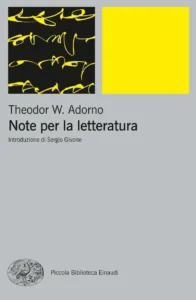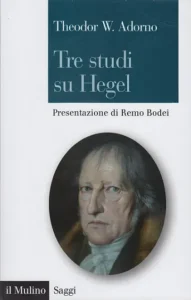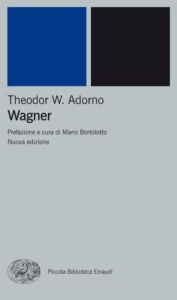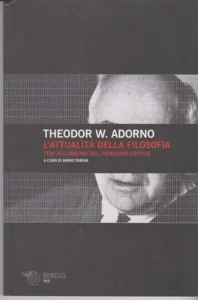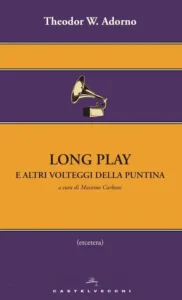Contenuti del libro
Informazioni
“Dialettica negativa” di Theodor Adorno ti sbatte in faccia quanto la filosofia tradizionale, soprattutto quella che parla di `ontologia` e `essere` alla `Heidegger`, spesso non faccia altro che giustificare lo stato delle cose, nascondendosi dietro parole vuote. Adorno non le manda a dire neanche al dualismo `soggetto-oggetto` o alla `libertà Kant`, mostrando come queste idee, apparentemente solide, siano in realtà piene di contraddizioni e riflettano le dinamiche di una società non libera. È un viaggio pazzesco attraverso la `filosofia tedesca`, smontando pezzo per pezzo concetti come lo `spirito universale` di Hegel. Il libro è scritto dopo `Auschwitz`, e questo si sente: la `metafisica` come la conoscevamo non funziona più, non può ignorare l’orrore e la sofferenza concreta. Adorno cerca un modo diverso di pensare, una `Dialettica Negativa` che non cerchi di far rientrare tutto in schemi rigidi, ma che dia spazio a ciò che è diverso, al `non-identico`. Non è una lettura facile, ma è fondamentale per capire perché certi modi di pensare ci intrappolano e come potremmo forse uscirne, guardando la realtà per quella che è, senza filtri consolatori.Riassunto Breve
La filosofia si confronta con l’idea di essere, vista spesso come una ricerca profonda, ma che in realtà finisce per sostenere l’ordine esistente senza una vera ragione. Questo bisogno di parlare dell’essere, che cerca di andare oltre la scienza, è un ritorno a modi di pensare vecchi. Però, questa ricerca di totalità diventa un’astrazione vuota, un oggettivismo che toglie ogni concretezza all’essere, rendendolo una parola senza significato, che nasconde la sua vuotezza dietro l’idea di profondità. La filosofia dell’essere non supera la reificazione del mondo, ma la ripete, usando un metodo che confonde l’intuizione con la vera comprensione. Questo bisogno di essere è falso, una consolazione che non affronta i problemi della società, ma li nasconde dietro un’idea astratta. La vera filosofia dovrebbe invece criticare le strutture di potere che mantengono questa illusione.La critica si rivolge anche alla filosofia dell’essere di Heidegger, vista come un sistema che sembra preciso ma è illusorio. Non basta dire che l’essere heideggeriano non esiste; bisogna mostrare che il suo concetto è privo di senso, un’idea teologica svuotata. Cercare un senso dell’essere che il pensiero stesso ha fatto sparire è un fallimento. La distinzione tra essere e ente diventa un’incognita vuota. La critica di Heidegger al soggetto porta a un oggettivismo eccessivo. La sua filosofia, presentata come salvifica, è in realtà uno strumento di dominio, che manca di autocritica. Il culto dell’essere si adatta a una cultura che valorizza la credulità vuota. Il concetto di essere, rifiutando la mediazione, diventa una ripetizione vuota dell’ente, dipendendo da esso per la sua apparente assolutezza. Questa filosofia oscilla tra l’astratto e l’immediato, ricadendo in un mito che cerca un’origine fuori dal tempo, un’immanenza che si crede trascendente.Anche la dialettica tradizionale, che cerca di unire particolare e universale, crea un’illusione di identità. Soggetto e oggetto non sono punti di partenza, ma concetti che mostrano la non-identità. L’idealismo ha cercato di mettere il pensiero al primo posto, ma il dualismo resta. Ridurre l’oggettività al soggetto è sbagliato. La filosofia ha dimenticato la mediazione nel soggetto stesso, che diventa una cosa quando lo si analizza. Il soggetto trascendentale, base della filosofia, è in realtà un’ideologia, legato al lavoro sociale e al dominio, un’astrazione che riflette la società. La sua universalità è solo quella del sistema sociale che annulla i singoli. Il primato del soggetto è falso, nasconde la realtà materiale. La critica dell’identità porta a riconoscere l’importanza dell’oggetto.La libertà, come intesa da Kant, presenta dei problemi. Sembra trascendere la causalità, ma Kant la lega a un’assoluta spontaneità, simile a un atto divino, che ostacola la vera libertà. La libertà kantiana, vista come indipendenza dalle leggi naturali, diventa anche liberazione dalle regole, ma Kant la lega subito alla legge, mostrando un timore borghese per l’anarchia. La società influenza le sue idee. La dottrina kantiana della libertà è repressiva, legata al bisogno di punire. L’imperativo categorico, che dovrebbe essere libertà, è una costrizione irrazionale. La libertà individuale nella società borghese è un’illusione; la legge del valore domina gli individui formalmente liberi. L’emancipazione individuale finisce nell’integrazione e nell’annullamento dell’individuo. La crisi della causalità nella società moderna, dove tutto è interconnesso, è legata al declino della libertà. La causalità è un principio soggettivo di dominio sulla natura. La coscienza morale (il super-io freudiano) è l’interiorizzazione della costrizione sociale, non un principio trascendentale puro. La critica alla coscienza morale mira a salvare un potenziale di resistenza alla coazione sociale. La morale kantiana, pur rigorosa, finisce per coincidere con l’egoismo, mostrando la frattura tra ideale sociale e ragione individuale. La coscienza morale è il segno di una società non libera. Il personalismo etico, che si concentra sulla persona, ignora la società e la persona stessa come nodo storico irrisolto, un’ideologia che ripete il dominio nel soggetto. La persona è una menzogna, un’antropomorfizzazione del principio economico. L’ontologia esistenziale, con l’esserci e l’autenticità, metafisicizza un io forte, ma l’uso di termini impersonali mostra la supremazia dell’identità sul soggetto. La spersonalizzazione è già nella soggettività. L’esserci impersonale è una metafora del mondo amministrato. La libertà, valore limite, scompare in una totalità invisibile. La contraddizione tra libero arbitrio e determinismo non si risolve con valori esterni, ma con la resistenza alla coazione. La critica alla morale vuole salvare questo potenziale per una vita conciliata. La libertà aggressiva attuale è quella degli uomini liberi in una società non libera. Collettivismo e individualismo sono falsi. La modernità non è brutta di per sé, ma lo è per un difetto legato ai rapporti di produzione. La scomparsa dei vincoli non è necessariamente negativa. La nostalgia per i vincoli mostra una società che simula la libertà. Le questioni morali serie riguardano orrori come la tortura. L’impulso morale contro l’orrore è reale, non un principio astratto. La differenza tra teoria e prassi mostra che la prassi non si riduce alla teoria, ma non è separata. L’inseparato vive negli estremi: la pulsione contro l’orrore e la coscienza che vede la sua persistenza.Lo spirito universale di Hegel è una forza oggettiva che domina gli individui, spesso negata dall’individualismo. Non è divino, ma una forza antagonista che si rende autonoma dalle azioni individuali. La storia non è guidata da un soggetto unico, ma si sviluppa indipendentemente dai singoli. Lo spirito universale è negativo, fallibile, irrazionale rispetto agli interessi individuali. La sua unità è una divisione, una forma di dominio che nega il particolare. La ragione universale, totalitaria, è limitata e antagonista. La storia universale non è progresso, ma una dialettica che porta alla catastrofe, dove l’unità sociale è catastrofe permanente.Dopo eventi come Auschwitz, la metafisica tradizionale è paralizzata. L’orrore ha rotto il legame tra esperienza e pensiero metafisico. Affermare la positività dell’esistenza è un’ingiustizia verso le vittime. La cultura diventa ideologia. La metafisica non può ignorare la sofferenza. La morte, un tempo integrata, è ora estranea. In questo vuoto, la metafisica cerca un’esperienza autentica. La felicità è effimera. Kant non offre consolazione, ma rassegnazione. Il desiderio di salvare la metafisica si scontra con un limite. Essa persiste nel cercare un mondo intelligibile, un tentativo disperato di salvare la trascendenza in un mondo dominato dall’immanenza. La verità metafisica è fragile, al confine tra essere e nulla.La religione, pur parlando di speranza nell’aldilà, non le dà l’importanza dovuta. La metafisica rischia di abbellire l’esistenza invece di trascenderla. La consapevolezza della vanità non porta protesta finché non cambia la posizione verso l’esistenza. La critica dell’ente come nulla favorisce una pratica degradata. La neutralizzazione persiste nonostante le catastrofi. Gli interessi metafisici hanno bisogno di quelli materiali. Solo la trasformazione dell’esistente mostra che non è la totalità. Le promesse teologiche sono simboli, non letterali. Reificare la trascendenza è mancanza di fantasia. Separare corpo e anima alimenta l’idolatria. La speranza si lega al corpo trasfigurato, che la metafisica ignora. L’idealismo, creando una coscienza trascendentale, finisce per assumere un’egoità non sensibile. Cielo e inferno spaziali sono arcaismi. La conoscenza tende alla mortalità assoluta, intollerabile per la metafisica. Chi crede in Dio non può crederci pienamente; la possibilità divina è preservata dal non credente. La storia, demitologizzando, torna al mito. La metafisica si ritira in questa contraddizione. La dialettica hegeliana fallisce perché dissolve il non identico nell’identità. L’illuminismo nasconde il trascendente concentrandolo in un’alterità estrema. La metafisica si riduce a difesa astratta o sopravvive nel piccolo. Il positivismo nega anche questa metafisica. Wittgenstein invita al silenzio. L’esperienza che il pensiero non censurato raggiunge la trascendenza, aspirando a un mondo senza sofferenza, resiste alla demitologizzazione. Questa convergenza verso l’Altro non è misurabile, ma motiva l’esperienza correttiva. Il mondo, pur immanente, ha fratture dove appaiono promesse non mantenute dell’Altro. Ogni felicità terrena è un frammento di una felicità negata. La trascendenza non è reale, ma la sua pensabilità suggerisce una spinta. La metafisica non può risorgere, ma forse sorge realizzando ciò che è pensato nel suo segno, anticipato dall’arte. L’arte prende forza dal senza apparenza, dicendo che non tutto è vanità. La luce nel mondo è un riflesso della trascendenza. La metafisica non è sapere assoluto, ma costellazione dell’ente. La dialettica, critica dell’assolutezza, deve criticare se stessa, riconoscendo la propria ombra di assolutezza. La sua autoriflessione cancella l’apparenza di sapere assoluto, rivelandosi negazione della negazione. È autocoscienza dell’accecamento. La sua forza viene dall’immanenza, sperando di superarne la coercizione. L’assoluto metafisico è il non identico che emerge dalla dissoluzione della coazione d’identità. Kant accenna a questo con la cosa in sé. I successori hanno rafforzato la coazione. Kant ha assimilato la cosa in sé al soggetto. L’avvicinamento asintotico la allontana. Le identificazioni dell’assoluto sono antropomorfismi. L’assoluto svanisce quando lo spirito si avvicina. L’eliminazione dell’antropomorfismo sarebbe l’identità assoluta. Il mistero smentisce il dominio della natura. L’illuminismo lascia poco contenuto metafisico di verità. Ciò che retrocede diventa piccolo. La metafisica si rifugia nella micrologia. Nessun assoluto è esprimibile se non con categorie immanenti, ma né l’immanenza né la sua totalità sono divine. La metafisica non è deduzione logica né un Altro separato. È costellazione dell’ente, usando l’immanenza per configurazioni che si scrivono. La metafisica deve desiderare. Il bisogno nel pensiero vuole essere negato per realizzarsi. I piccoli tratti mondani sono rilevanti per l’assoluto, perché lo sguardo micrologico rompe l’identità rigida, rivelando l’inganno. Questo pensiero si unisce alla metafisica nella sua caduta.Riassunto Lungo
1. L’Illusione dell’Essere
Critica dell’Ontologia nella Dialettica Negativa
La Dialettica Negativa di Adorno affronta l’influenza persistente dell’ontologia, specialmente nella forma proposta da Heidegger, all’interno del pensiero filosofico contemporaneo. L’ontologia, anche se si presenta come una ricerca profonda sulla natura dell’essere, viene interpretata da Adorno come un sostegno implicito all’ordine sociale esistente. Secondo Adorno, l’ontologia evita di fornire una vera giustificazione razionale a questo ordine. Questo modo di pensare filosofico, che mette la domanda sull’essere al di sopra di ogni risposta concreta, rivela un bisogno profondo di superare i limiti della conoscenza scientifica e razionale. Questo bisogno, per Adorno, rappresenta un ritorno a forme di pensiero che precedono la critica razionale.L’Insoddisfazione del Bisogno Ontologico
Nonostante questa aspirazione, il bisogno ontologico si dimostra insoddisfacente. L’ontologia, nel suo tentativo di recuperare un senso di completezza e di superare la riduzione del mondo moderno a semplice oggetto (reificazione), cade in un’astrazione ancora più estrema. La critica che l’ontologia rivolge all’idealismo e al soggettivismo si trasforma in un oggettivismo metafisico. Questo oggettivismo svuota l’essere di ogni significato concreto, riducendolo a una formula vuota e ripetitiva. Invece di offrire risposte fondamentali, l’ontologia si rifugia in concetti vaghi e non definiti, presentando questa mancanza di contenuto come se fosse un segno di profondità.L’Ontologia e la Riproduzione delle Dinamiche Criticate
La filosofia dell’essere, pur nascendo dal desiderio di raggiungere l’oggettività e di criticare la reificazione, finisce per ripetere proprio quegli schemi che voleva superare. L’intuizione categoriale, che è il metodo centrale dell’ontologia, si dimostra insufficiente per comprendere la complessità della realtà. L’ontologia confonde una presunta immediatezza spirituale con una vera comprensione che richiede riflessione e analisi. In conclusione, il bisogno ontologico appare come un bisogno artificiale e ingannevole. È una consolazione illusoria che, invece di affrontare le contraddizioni della società moderna caratterizzata dalla reificazione, le mantiene in vita attraverso la celebrazione di un essere astratto e impossibile da definire. La vera filosofia, al contrario, dovrebbe riconoscere la natura illusoria di questo bisogno e impegnarsi in una critica radicale delle strutture di potere e delle costanti che lo alimentano.Ma è davvero l’ontologia intrinsecamente conservatrice e incapace di critica sociale, o questa è solo una delle possibili interpretazioni, magari influenzata dal contesto storico e dalle specifiche critiche di Adorno?
Questa domanda mira a mettere in discussione la condanna apparentemente definitiva dell’ontologia presentata nel capitolo. Si invita il lettore a considerare se la prospettiva di Adorno sia l’ultima parola sull’ontologia, o se esistano punti di vista alternativi. Per approfondire, si potrebbe esaminare le opere originali di Heidegger per comprendere direttamente la sua ontologia, e confrontarla con la critica di Adorno. Inoltre, esplorare altri teorici critici che si sono confrontati con o contro l’ontologia, e considerare diverse scuole di pensiero all’interno dell’ontologia stessa, potrebbe fornire una comprensione più sfumata.2. L’Illusione dell’Essere
Critica alla filosofia dell’essere di Heidegger
La filosofia di Heidegger sull’essere viene analizzata in modo approfondito, mettendo in discussione le sue basi fondamentali. L’analisi si concentra su una critica interna, che mira a individuare le debolezze strutturali di questa filosofia, piuttosto che contestarla con argomentazioni esterne. Sebbene Heidegger sembri seguire un approccio logico e sistematico, in realtà la sua costruzione concettuale, pur precisa nelle intenzioni, risulta essereillusoria.L’illusione di profondità nel concetto di “essere”
Non è sufficiente semplicemente negare che esista qualcosa che corrisponda all’ “essere” di Heidegger. È necessario dimostrare che questo concetto è privo di significato partendo dalle sue stesse affermazioni di essere inconfutabile. La parola “essere” appare profonda, ma in realtà questa profondità è solo apparente. Questa illusione nasce dalla trasformazione in chiave moderna e soggettiva di concetti che originariamente avevano un significato teologico. Heidegger, anche se rifiuta la metafisica tradizionale, commette un errore simile a quello di Hegel. Entrambi, in modi diversi, presuppongono che ci sia una presenza immediata di qualcosa che dovrebbe essere salvato o recuperato.Il fallimento della ricerca di senso nell’essere
La filosofia dell’essere fallisce nel momento in cui cerca di trovare un significato nell’ “essere” stesso, un significato che è stato però cancellato dal pensiero filosofico. La mancanza di significato della parola “essere” non è un errore del pensiero, ma piuttosto la conseguenza inevitabile di un modo di pensare che ha eliminato il senso oggettivo delle cose. Heidegger distingue tra “essere” e “concetto generale”, ma questa distinzione si rivela vuota e senza contenuto, simile al concetto kantiano della “cosa in sé”.L’oggettivismo di Heidegger come reazione eccessiva
La critica che Heidegger rivolge al soggetto pensante, tipica del suo oggettivismo, appare come una reazione esagerata. Le affermazioni del positivismo, che a prima vista sembrano prive di senso, sono in realtà un sintomo del nostro tempo. Non sono false perché mancano di significato, ma perché pretendono di averne uno in modo assoluto. La filosofia di Heidegger, presentata come una via di salvezza, si rivela invece un sistema di potere, repressivo e incapace di mettere in discussione se stesso in modo critico.Il culto dell’essere e l’oppressione
Il modo in cui Heidegger venera l’ “essere”, pur criticando l’idea di uno spirito umano che si considera divino, finisce per proporre una forma di oppressione più nascosta e meno aperta alla critica. L’attrazione per la parola “essere” si adatta bene a una cultura moderna che ha perso i suoi valori tradizionali. Questa cultura esalta la devozione e la credulità fine a se stesse, svuotando di significato le religioni tradizionali. Heidegger, nel tentativo di recuperare un’aura di sacralità perduta, isola e rende assoluto il momento del cambiamento e della trasformazione, presentandolo come qualcosa di immediato e oggettivo, ma in realtà privo di concretezza.L’inessenzialità del concetto di essere
Il concetto di “essere”, rifiutando l’idea di mediazione e di passaggio attraverso altri concetti, diventa vuoto e ripetitivo, una semplice ripetizione dell’ “ente”, cioè delle cose esistenti. L’ “essere” di Heidegger, pur volendo distinguersi dall’ “ente”, dipende da esso per la sua stessa pretesa di essere assoluto e dotato di un’aura speciale. La filosofia di Heidegger oscilla tra un pensiero astratto e lontano dalla realtà e un’attenzione immediata e superficiale ai dati sensoriali. In questo modo, essa si trasforma in un mito tipico del XX secolo, che ripropone l’illusione di un’origine che si trova fuori dal tempo e dalla storia. Questa idea di un “essere” trascendente, che va al di là della realtà concreta, è in realtà una forma di immanenza portata all’estremo, che non si rende conto della sua stessa natura limitata e legata al mondo terreno.Se il capitolo afferma che il concetto di “essere” di Heidegger è un’illusione, su quale solida base filosofica poggia tale affermazione, considerando la vasta influenza e il dibattito che circonda il pensiero di Heidegger?
Il capitolo critica aspramente il concetto di “essere” heideggeriano definendolo “illusorio”, ma non chiarisce esplicitamente quale quadro filosofico alternativo viene utilizzato per giungere a tale conclusione. Per comprendere appieno la validità di questa critica, sarebbe utile esplorare le diverse interpretazioni del pensiero di Heidegger e confrontarle con approcci filosofici alternativi, ad esempio quelli della filosofia analitica o del pragmatismo. Approfondire autori come Carnap, che criticò la metafisica, o filosofi come Gadamer, che invece difese e interpretò Heidegger, potrebbe fornire una prospettiva più completa.3. L’Illusione della Soggettività
La Critica alla Dialettica Tradizionale
La dialettica tradizionale affronta gli aspetti specifici della realtà come se fossero problemi da risolvere attraverso un’idea universale. Questo modo di fare, però, crea un’apparenza di identità che non riesce a comprendere la vera natura delle cose specifiche. La dialettica che mette in relazione soggetto e oggetto, considerata fondamentale nella filosofia, si rivela quindi un sistema che non è realmente dialettico. È un metodo per cercare di unire ciò che in realtà non può essere unito. Soggetto e oggetto non sono quindi concetti di base, ma nascono da altro. Sono modi per esprimere la non-identità, piuttosto che rappresentare una divisione fondamentale o un’unità nascosta.I Limiti dell’Idealismo Filosofico
La filosofia idealista, iniziata con Hegel, ha provato a includere questa divisione nel pensiero, dando al soggetto un ruolo di primo piano nella realtà. Tuttavia, così facendo, ha affermato che il pensiero è più importante di tutto, senza considerare che la divisione tra soggetto e oggetto rimane anche quando pensiamo. Ogni concetto, anche quello di esistenza, mostra la differenza tra chi pensa e cosa viene pensato. Questa divisione è radicata nella realtà, che è piena di contrasti e opposizioni.L’Oggettivazione del Soggetto
Pensare che l’oggettività dipenda dal soggetto è un errore. La filosofia non ha considerato che anche il soggetto è influenzato da diversi fattori. Questa dimenticanza fa sì che il soggetto diventi un oggetto nel momento in cui viene analizzato. L’io puro, che è alla base della filosofia trascendentale, assomiglia più a una cosa concreta rispetto ai contenuti psichici che rifiuta perché considerati materiali. Il soggetto trascendentale, quindi, non è un principio indipendente, ma può essere interpretato come la società che non è consapevole di sé stessa. È radicato nel lavoro della società e nei rapporti di potere.La Natura Ideologica del Soggetto Trascendentale
Il soggetto trascendentale si presenta quindi come un’idea falsa, un concetto astratto che riflette la separazione tra chi lavora manualmente e chi non lo fa, e l’importanza del denaro. La pretesa universalità del soggetto trascendentale non è altro che l’universalità del sistema sociale, che uniforma e annulla i singoli individui. Dare la priorità al soggetto, quindi, è un’illusione, una falsità che nasconde la vera natura oggettiva e materiale della realtà. La critica all’idea di identità ci spinge quindi a rivalutare l’oggetto, riconoscendone la maggiore importanza e smascherando la visione soggettivistica che si nasconde nel pensiero che cerca l’identità.Ma è davvero la “crisi della metafisica” una conseguenza inevitabile di eventi catastrofici, o non piuttosto una trasformazione interna al pensiero filosofico stesso, accelerata da tali eventi?
Il capitolo sembra suggerire un nesso causale diretto tra eventi traumatici e crisi della metafisica, quasi che quest’ultima fosse robusta e intatta fino ad Auschwitz. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare la storia della metafisica, notando come le critiche interne e le trasformazioni del pensiero filosofico abbiano già da tempo messo in discussione le sue fondamenta. Approfondire autori come Nietzsche, con la sua critica radicale alla metafisica, o Heidegger, che pur cercando un “superamento” della metafisica ne evidenzia la persistente influenza, potrebbe offrire una prospettiva più complessa e sfumata sulla questione.7. La Metafisica e l’Altro: Oltre l’Illusione dell’Immanenza
Critica alla Religione e alla Metafisica Tradizionale
La religione, nonostante sia spesso vista come fonte di superstizione e magia, raramente ha dato alla speranza nell’aldilà l’importanza che merita. La riflessione metafisica, unendosi alla filosofia della storia, immagina un futuro senza sofferenza, guidato da una coscienza retta. Tuttavia, la metafisica stessa rischia di diventare un abbellimento dell’esistenza attuale, invece di superarla veramente. In questo modo, anziché trascendere l’immanenza, la consolida. La consapevolezza che la vita è vana non porta a una ribellione finché non cambia il nostro modo di vedere l’esistenza stessa.Il Pericolo della Critica Distruttiva e l’Importanza della Trascendenza
Quando si critica tutto ciò che esiste come se fosse nulla, si rischia di cadere in comportamenti degradanti e animaleschi. Predicare che la vita terrena è vana può nascondere la trascendenza, che invece si alimenta proprio delle esperienze terrene. Anche di fronte alle catastrofi, l’indifferenza persiste. La società borghese preferisce crollare piuttosto che mettere in discussione le proprie fondamenta. Gli interessi metafisici hanno bisogno della protezione degli interessi materiali, altrimenti si vive in un mondo di illusioni. Solo trasformare la realtà ci fa capire che ciò che esiste non è tutto ciò che c’è.Simbolismo e Limiti del Linguaggio Religioso e Poetico
La poesia neo-romantica usa immagini di altri pianeti per parlare di crescita interiore, non di vere esperienze nello spazio. Allo stesso modo, le promesse religiose non vanno prese alla lettera, ma come simboli. Una religione che interpretasse tutto alla lettera diventerebbe fantascienza. Le idee infantili di viaggi spaziali nella teologia riflettono un infantilismo nascosto nei messaggi di salvezza. Se togliessimo ogni riferimento materiale a questi messaggi, ne rimarrebbe solo il vuoto. Questa contraddizione della teologia si vede anche nel Faust, dove la salvezza celeste è incerta tra dubbio e simbolo.Corpo, Anima e la Speranza nella Trasfigurazione
Considerare la trascendenza come qualcosa di concreto e definito mostra mancanza di immaginazione e tradisce la vera essenza dello spirito. Negare ogni possibilità di redenzione nel mondo reale porterebbe a divinizzare l’individuo limitato. La separazione tra corpo e anima, che riflette la divisione del lavoro, alimenta l’adorazione della mente e la frustrazione materiale. La speranza, invece, è legata alla trasformazione del corpo, un aspetto che la metafisica ignora, finendo nello spiritismo. La differenza tra teologia e spiritismo sta solo nella maggiore importanza storica che diamo all’idea di spirito.Critica all’Idealismo e Ritorno alla Concretezza
L’idealismo, nel costruire un’idea di coscienza superiore, si allontana dall’esperienza del singolo individuo. Così facendo, finisce per creare un’idea di individualità astratta che si manifesta nel tempo e nello spazio. Parlare di paradiso e inferno come luoghi fisici è ormai superato e rende l’idea di immortalità qualcosa di spettrale e inconsistente. La dottrina cristiana, con la resurrezione del corpo, era più coerente dal punto di vista metafisico. La conoscenza ci porta verso l’idea di una fine totale, cosa inaccettabile per la metafisica. Chi dice di credere in Dio, in realtà, non può crederci fino in fondo. La possibilità del divino è mantenuta viva proprio da chi non crede. Anche solo pensare alla speranza può sminuirla. La storia, nel suo processo di allontanamento dai miti, finisce per distruggere se stessa, tornando al mito, a una realtà chiusa e limitata. La metafisica si ritrova in questa contraddizione, minacciata da ogni lato di essere falsa.La Dialettica Hegeliana e i Limiti dell’Identità
La dialettica di Hegel, pur riprendendo l’idea di una prova dell’esistenza di Dio, fallisce perché annulla le differenze nell’unità, imprigionando la trascendenza nella realtà dello spirito. L’illuminismo, distruggendo l’idea di trascendente, lo nasconde, concentrandolo in qualcosa di estremamente altro e lontano. La metafisica si riduce così a difendere una posizione vaga e indefinita, oppure sopravvive in ciò che è piccolo e semplice, sfidando la ragione arrogante. Il positivismo nega anche questa metafisica umile, rinunciando all’idea stessa di verità. Wittgenstein capisce questa situazione e invita al silenzio.L’Esperienza della Trascendenza e la Promessa di un Mondo Migliore
L’esperienza che il pensiero libero dai condizionamenti può raggiungere la trascendenza, aspirando a un mondo senza sofferenza, è ciò che resiste all’eliminazione dei miti. Questo tendere verso l’Altro non si può misurare scientificamente, ma è ciò che motiva la nostra esperienza di cambiamento. Il mondo, pur essendo profondamente terreno, mostra delle fratture in cui le promesse non mantenute di un Altro si fanno sentire. Ogni felicità che proviamo sulla terra è solo un pezzetto di una felicità completa che ci viene negata. La direzione della storia indica ciò che la riflessione sull’essere trascura. L’idea di trascendenza non è reale, ma il fatto che possiamo pensarla suggerisce una spinta verso di essa. La metafisica non può rinascere nel modo tradizionale, ma forse può emergere se realizziamo ciò che è pensato nel suo simbolo, anticipato dall’arte.Il Ruolo dell’Arte e la Nega della Vanità
L’arte, pur essendo apparenza, trova la sua forza irresistibile in ciò che non è apparenza, affermando che non tutto è vano e senza significato. La luce che illumina il mondo è un riflesso della trascendenza, qualcosa che non può essere cancellato dalla resistenza al mondo pratico e funzionale. Nell’apparenza si intravede la promessa di ciò che non appare. La metafisica, come conoscenza dell’assoluto, non ha bisogno di costruire un sistema di sapere assoluto idealistico. La dialettica, pur criticando l’idea di assolutezza, non deve diventare assoluta essa stessa. La dialettica dovrebbe negare la coscienza non dialettica perché limitata, ma così facendo rischia di fare da tramite concettuale tra spirito condizionato e incondizionato, rimanendo legata al pensiero condizionato.L’Assoluto Hegeliano e la Ricerca dell’Altro Incommensurabile
L’assoluto di Hegel, che è una versione laica del divino, rimane legato all’idea umana di finito. Se il pensiero cerca l’Altro che non si può misurare, rischia di rifugiarsi in dogmi rigidi. La metafisica dipende dalla possibilità di superare questo problema. La dialettica, che critica l’accecamento generale, deve criticare anche se stessa, riconoscendo la propria tendenza all’assolutezza. Questa riflessione su se stessa elimina l’illusione di un sapere assoluto, mostrando di essere negazione della negazione. La dialettica è consapevolezza del proprio accecamento, non la sua eliminazione. La sua forza per superare i limiti viene dalla realtà concreta, sperando di superarne la costrizione, che è anche apparenza illusoria. L’assoluto metafisico è il non identico che emerge quando si dissolve la forzatura dell’identità.La Dialettica Negativa, Kant e il Mistero dell’Assoluto
La dialettica negativa non si ferma in se stessa, ma mantiene viva una forma di speranza. Kant accenna a questo con l’idea della cosa in sé trascendente, che sta al di là dei meccanismi che identificano e definiscono. I successori di Kant, considerando questa costrizione come assoluta, hanno rafforzato i limiti. Kant stesso, definendo la cosa in sé come comprensibile con l’intelletto, l’ha avvicinata al soggetto assoluto, cedendo al principio di identità. L’avvicinamento progressivo alla cosa trascendente la allontana dalla coscienza. Le definizioni dell’assoluto sono antropomorfismi, cioè modi umani di rappresentare qualcosa che è oltre l’umano. L’assoluto, quando lo spirito cerca di avvicinarlo, svanisce. Eliminare ogni antropomorfismo coinciderebbe con l’identità assoluta. Il mistero smentisce il dominio della natura, ricordandoci l’impotenza del suo potere.La Micrologia come Rifugio della Metafisica e il Desiderio come Motore del Pensiero
L’illuminismo lascia poche verità metafisiche di valore. Ciò che viene rifiutato e messo da parte diventa sempre più piccolo e insignificante, per questo la metafisica si rifugia nello studio delle piccole cose, la micrologia. Nessun assoluto può essere espresso se non con parole e concetti terreni, ma né la realtà terrena né la sua totalità possono essere divinizzate. La metafisica non è possibile né come ragionamento logico sull’essere, né come un Altro completamente separato. Essa è possibile solo come un insieme di segni da interpretare nella realtà, usando gli elementi del mondo terreno per creare configurazioni che si uniscono in una forma di scrittura. La metafisica deve saper desiderare. Il pensiero contiene in sé il bisogno, che è ciò che lo mette in moto. Il bisogno nel pensiero vuole essere negato dal pensiero stesso per realizzarsi pienamente, sopravvivendo in questa negazione. Anche i più piccoli dettagli del mondo diventano importanti per l’assoluto, perché l’attenzione micrologica rompe l’identità rigida della realtà, rivelando l’inganno della sua semplice apparenza. Questo tipo di pensiero si unisce alla metafisica nel momento in cui essa sembra fallire.Se il capitolo critica la metafisica tradizionale per la sua astrattezza, come definisce concretamente la “trascendenza” che propone, e come si distingue questa trascendenza da ciò che critica?
Il capitolo sembra oscillare tra una critica della metafisica tradizionale e un tentativo di recuperare una forma di trascendenza. Tuttavia, la natura di questa “trascendenza” alternativa rimane nebulosa. Per comprendere meglio la proposta del capitolo, sarebbe utile esplorare più a fondo il concetto di “trascendenza immanente” o “trascendenza nel mondano”, approfondendo autori come Adorno, che ha sviluppato una critica della metafisica tradizionale e una dialettica negativa, o pensatori che si sono confrontati con la secolarizzazione e la ricerca di significato al di là delle strutture religiose tradizionali. Approfondire la filosofia della religione contemporanea potrebbe fornire ulteriori strumenti per chiarire la distinzione tra la trascendenza criticata e quella auspicata dal capitolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]