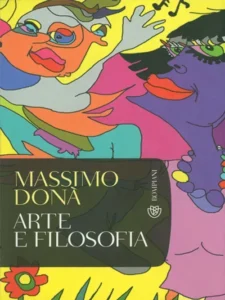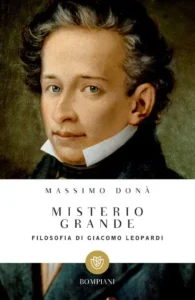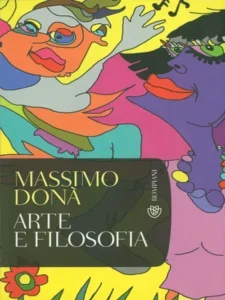Contenuti del libro
Informazioni
“Di un’ingannevole bellezza Le ”cose” dell’arte” di Massimo Donà è un viaggio affascinante che scava nel profondo di cosa siano l’arte e la realtà, partendo dal “mondo rovesciato” del Barocco, dove figure come “Don Chisciotte” e la “fiaba barocca” ci mostrano una realtà piena di “doppiezza e incertezza”, un vero e proprio “teatro del niente” dove le cose non sono mai come sembrano e la verità si nasconde in uno sguardo obliquo. Il libro esplora come questa visione si ritrovi nell'”arte contemporanea”, analizzando artisti come “Duchamp” e “Manzoni”, che con i loro “ready-made” e “achromes” ci portano a riflettere sulla “bellezza ingannevole”, che non sta nelle forme perfette ma forse nel “nulla”, e sull'”indifferenza” come modo per vedere le cose nella loro pura “datità”, senza maschere o significati imposti. È un percorso che mette in discussione l'”irrealtà del reale”, cercando una “forma magica” che riveli l’essenza inspiegabile delle cose, anche attraverso la metafora della “cornice del dubbio” che definisce e allo stesso tempo sfida l’opera d’arte. In fondo, il libro ci invita a vedere l’arte non come qualcosa che rappresenta o comunica, ma come pura “esistenza”, un “essere” in costante “divenire”, che ci svela la misteriosa autonomia delle “cose” e la nostra stessa, radicale “alterità”.Riassunto Breve
Il Barocco segna un cambiamento profondo, spostando l’attenzione dall’armonia a una visione del mondo caratterizzata da doppiezza e incertezza. L’arte diventa teatrale e sperimenta grande libertà, rifiutando la prospettiva centrale e usando l’anamorfosi per mostrare come la verità si riveli solo da uno sguardo obliquo. Ogni cosa punta all’assoluta singolarità che sfugge ai concetti universali. Don Chisciotte incarna questa mentalità, diviso tra intelligenza e follia, agendo in un mondo che appare bisognoso di trasformazione e dove le cose negano ciò che sembrano. La sua libertà è incondizionata, sfida le leggi logiche e vede la verità riflessa nella finzione del teatro. La fiaba barocca, come quella di Basile, mescola noto e ignoto, possibile e impossibile, rivelando la duplicità della realtà e la prossimità di opposti. Usa il lontano per mettere a fuoco il quotidiano e mostra la bellezza nascosta nell’orrido, sfidando le categorie universali con l’immaginazione. Anche autori recenti come Buzzati riprendono l’elemento fiabesco per mostrare il mistero dell’esistenza; un fatto apparentemente impossibile, come una goccia d’acqua che sale le scale, rivela l’unicità irriducibile delle cose, sfidando l’ordine logico e mostrando che il mistero sta nel semplice, ingiustificabile fatto di esistere individualmente. Il mondo si presenta come una rappresentazione teatrale, un gioco di finzioni dove le azioni non producono effetti reali. L’arte crea un riflesso rovesciato della realtà, svelando la sua natura ingannevole e inconsistente. In questo mondo capovolto, l’impossibile diventa possibile, mettendo in discussione la logica comune e le identità definite. L’artista cerca di infondere “vita” o “unità” nell’opera, andando oltre la tecnica, portando a un risultato che, agli occhi di chi cerca la bellezza nelle parti determinate, appare come un “niente”. La bellezza non risiede nelle caratteristiche specifiche, ma in qualcosa di indeterminato, un “niente”, che evoca un’unità non concettuale. Il piacere estetico non dipende dall’interesse o dal gusto legato alle qualità determinate, ma da una sorta di indifferenza verso l’esistenza dell’oggetto stesso. L’arte moderna, come il ready-made di Duchamp, mostra questa indifferenza, suggerendo che il valore non sta nella forma o nell’abilità, ma in ciò che nega tali aspetti, rivelando un’unità o un “niente” sottostante. Un protagonista di romanzo sceglie di abbandonare l’agire, portando a uno stato di indifferenza, simile a quella cercata da artisti come Duchamp. Si tratta di svuotarsi, non credere, non desiderare, non giudicare, diventando un puro osservatore del mondo. Questa condizione permette di vedere l’esistenza delle cose senza le maschere imposte da valori ed emozioni. La realtà appare come è sempre stata. Davanti a un albero, non c’è niente da capire, solo da guardare; l’albero è solo un albero e non offre messaggi. L’indifferenza implica l’apprendimento della solitudine, della pazienza, del silenzio. Bisogna disabituarsi a sperare e intraprendere. Si impara la trasparenza, l’immobilità, l’inesistenza. L’atto creativo o qualsiasi azione non è più funzionale a valori esterni o alla comunicazione. I ready-made di Duchamp nascono senza uno scopo preciso, come un gioco. L’indifferente lascia le sue azioni in un terreno neutro, non funzionale. Questo stato di indifferenza, pur potendo sembrare felicità, è illusorio; non si impara nulla, non accade nessun miracolo, non rende diversi. L’artista, come lo studente o lo scrivano di Melville, non ha preferenze, ignorando bello e brutto. Diventa uno specchio indifferente delle singolarità del mondo, che non possono essere ricondotte a forme unitarie o universali. L’arte per secoli ha cercato la bellezza come valore salvifico, nascondendo la natura del “bello in sé” platonico, che non ha a che fare con qualcosa di gratificante o utile. Toccare il fondo, come la bellezza, non significa niente. Ogni espressione artistica riconduce sempre e solo al “niente”. La realtà non esiste sulla terra, è solo una rappresentazione mentale comune. L’artista, con capacità eccezionali, ha una visione più perfetta dell’esistente. Il classicismo nell’arte è la capacità di ridurre l’apparenza delle cose al loro scheletro, al segno della loro esistenza inspiegabile, eliminando le forme inutili per mostrare il contorno essenziale, l’evidenza del fenomeno che non appartiene a questo mondo. Nelle grandi opere, la forma è evidente e irreale, si fonde con l’atmosfera circostante, perdendo la durezza delle cose reali. La vera forma è inafferrabile, una “forma magica” che non si spiega con la ragione scientifica, ma provoca soddisfazione e porta al silenzio. Il mistero dell’esistere si trova nell’oggetto stesso. L’arte metafisica “santifica” la realtà, separando le cose dal contesto utilitaristico che ne offusca il mistero, sopprimendo il senso logico. L’arte non cerca un altro mondo immateriale, ma scopre nel vuoto la bellezza insensata della materia. L’artista separa la cosa dalla sua atmosfera, mostrando la cosa come se fosse vista per la prima volta. Questo rivela il lato metafisico della realtà fenomenica, un “negativo” che non è un altro significato, ma l’insensatezza stessa. L’arte è un ponte tra il senso comune e l’insensatezza dell’essere, tra il positivo dei significati e un negativo che si separa da essi. La grande arte classica separa questi opposti assoluti, che sono irreali e impossibili, ma la cui separazione rivela evidenza e irrealtà. L’arte magica spinge il noto verso l’ignoto, legandosi alla dimensione inconscia. Esiste l’idea di un modo diverso di agire sul mondo, non basato sulla causa fisica, ma su una connessione profonda tra le cose, un “nexus metaphysicus”, che nasce dal sentire interiore della potenza della volontà. André Breton, con il Surrealismo, riprende questa prospettiva, vedendo l’arte come una pratica magica capace di rivelare un aspetto nascosto della realtà. L’arte magica si fonda sull’immaginazione e sull’inconscio, superando la logica razionale. Ogni potenza è magia, espressione di un incondizionato che non segue la ragione. Questo punto di vista vede gli opposti non come contraddittori, ma come aspetti del medesimo. L’arte autentica attinge a questa dimensione, mostrando che le cose non sono semplicemente ciò che appaiono secondo la percezione comune. La bellezza stessa è una manifestazione di questa magia. Non dipende da regole o canoni fissi e spesso si presenta in modo strano o inatteso. La bellezza inganna, perché pur apparendo come una qualità delle cose, rivela che esse non sono ciò che dicono di essere. Mostra l’individualità di un oggetto, dove il suo concetto si unisce alla sua esistenza, riflettendo una struttura simile a quella attribuita a Dio. Una cosa bella è doppia, esiste e non esiste allo stesso tempo, sfidando il principio di non contraddizione. L’arte, attraverso la bellezza, svela la natura illusoria e ingannevole del mondo. L’arte contemporanea si confronta con la necessità di ritrovare la sua struttura fondamentale, mantenendo un bisogno essenziale di una “cornice” per essere riconosciuta come espressione artistica. Questa cornice non è solo fisica, ma include lo spazio espositivo o la disposizione mentale di chi guarda. Il gesto di Duchamp, che ha trasformato oggetti comuni in opere d’arte spostandoli in un contesto artistico, dimostra che l’artisticità può derivare dall’atto di circoscrivere e isolare l’oggetto. Non è il contenuto o la qualità intrinseca a renderlo arte, ma il confine che lo definisce e lo separa dal quotidiano. L’artista agisce come un “corniciaio”, creando lo spazio che rende possibile l’esperienza estetica, uno spazio che, in termini di contenuto predeterminato, è sostanzialmente vuoto. Tuttavia, l’arte autentica sembra anche resistere a questa definizione. L’opera d’arte è intollerante verso qualsiasi limite, come se si facesse incorniciare solo per dimostrare di non potersi lasciare confinare. Lo spazio dell’arte appare indefinibile, quasi senza luogo, e sembra confutare la sua stessa delimitazione. Questa natura indefinita si manifesta come un dubbio radicale sull’oggetto stesso. L’arte non offre significati fissi, ma si presenta come una domanda su se stessa e sulla realtà. È questa “cosa interrogante” che stimola la riflessione e la ricerca. L’indeterminazione dell’arte, la sua capacità di avere infiniti significati senza averne uno determinato, rivela una verità paradossale e inafferrabile. Questa condizione riflette anche l’indeterminazione dell’essere umano. L’arte, nella sua essenza indefinibile e priva di funzione pratica, mantiene una sua perfezione legata alla sua sacra inqualificabilità. L’analisi della realtà scompone ciò che sembra esistere in parti indipendenti, mostrando che l’oggetto non è un’unità ma una somma, investigando l’inesistente, poiché l’analisi dimostra che le cose non esistono come entità singole, ma come un infinito di legami, dove il “nulla” è anche “qualcosa”. L’arte contemporanea cerca una nuova identità, distaccandosi dalle forme estetiche tradizionali e dalla funzionalità quotidiana. Non rinuncia a pretendere un suo statuto, ma lo cerca anche nella sua negazione, insistendo sulla necessità di legittimazione. Rifiuta le limitazioni imposte dalla fruizione comune e non vuole essere semplicemente un bell’oggetto o soddisfare bisogni, neanche quelli legati al piacere. Il suo scopo è offrire un “altro sguardo” sul mondo. L’artista de-situa materiali e oggetti, mostrandoli per indicare una possibilità che il loro uso comune ha rimosso. L’arte non è una rappresentazione o un significato, ma la semplice possibilità di vedere il mondo in modo diverso. Non offre conforto o piacere, né si lega al senso, che è tipico dell’esistenza oggettuale assoggettata a scopi pratici. L’artisticità si trova dove lo sguardo si fa pura contemplazione, diretto alla pura “datità” di ciò che è dato, non a partire da noi, ma da un “altro”. Questo sguardo si conforma all’alterità, fondamento non oggettivabile dell’esperienza. L’arte permette di incontrare un “Altro” che non è un oggetto, ma la nostra stessa “esser-altri” radicale, la nostra datità originaria. Questo incontro destabilizza l’identità soggettiva, rendendo l’Io “contemplabile”. La nostra natura desiderante non è una scelta, ma una condizione data. L’opera d’arte imita questa natura, presentandosi come mera esistenza, pura “datità” che rifiuta il senso definito. La sua forza è nel farsi semplicemente presente, come un “non-oggetto” che sfugge al significato soggettivo. L’artista cerca una “proporzione necessaria”, una necessità non logica ma legata all’inseità, al “sacro”. L’arte realizza una libertà che non è esclusa dalla necessità. L’artista trasforma ciò che è progettabile in “nuda cosa”, guidandola verso una dimensione improgettabile. L’esperienza estetica contemporanea è l’esperienza della pura presenza, dell’esserci risolto nel qui e ora, che esiste “da sé”. Questo porta a una metamorfosi che rende l’esistenza “impropria”, disumana. L’arte abita l’immarcescibile “presente”, inteso nella sua gratuita sacralità, rivelando l’esistenza autonoma delle cose. Il mito colloca gli eventi in un tempo originario e sacro, creando un ordine cosmico dove i fenomeni quotidiani assumono un valore diverso e le leggi comuni vengono rimosse. Esiste una vicinanza tra il racconto “Una goccia” di Buzzati e l’approccio artistico di Piero Manzoni. Buzzati considera la goccia semplicemente una goccia, rifiutando interpretazioni metaforiche. Allo stesso modo, Manzoni presenta le sue superfici bianche (“achromes”) come integralmente incolori e neutre, al di fuori di ogni fenomeno pittorico. Una superficie bianca è solo una superficie bianca. Manzoni esclude ogni intervento “superfluo” e interpretativo dalla sua arte. Non vuole comporre o “esprimersi”, ma raggiungere una “integrale libertà”. L’arte non deve porsi problemi di forma, spazio o colore. Le sue linee non delimitano spazi, ma sono considerate “pura filosofia”. Per Manzoni, l’artista deve “essere”, non “dire” qualcosa. Un’opera vale solo in quanto “è”, come essere totale. Questo si allinea con la lezione di Dada e Surrealismo nel rifiutare la vocazione espressiva dell’arte. Non ha senso “alludere, esprimere, rappresentare”. Questi sono problemi “inesistenti”. Il valore di un quadro non dipende dalla composizione o dal colore, ma da una trasformazione integrale. L’artista libera gli oggetti e il mondo dalle significazioni, portando alla luce il loro puro “essere”. Questo essere totale è puro divenire. Manzoni comprende che essere e divenire non sono opposti; l’essere, in quanto puro, è divenire. L’esistenza è fatta di ciò che non è più o non è ancora. L’obiettivo dell’arte è far emergere questo divenire, il “non essere che sempre e solamente c’è”, superando le “vuote finzioni” che fissano la vita in forme rigide e creano una falsa permanenza. L’arte sfida la convinzione che l’essenziale sia il permanente e l’universale, mentre il mutevole sia inessenziale. Ciò che deve “volare” è l’esistenza stessa, nella sua dinamicità e inafferrabilità. “Non c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è solo da vivere”. Manzoni cerca di disintegrare i fenomeni per scoprire i loro “moti più intimi”. Vuole ridurre il fenomeno a una “monade” dove le distinzioni scompaiono, diventando “puro divenire”, “movimento puro”. Questo libera le “immagini prime”, le emozioni più intime che indicano una vera Realtà. L’arte cerca il fondamento da cui originano le mitologie, un puro movimento, energia, le immagini mobili dell'”inizio”. L’arte è una “commedia dell’arte”, un “teatro”, che cerca il “vivo germe della umana totalità”, dove ogni forma determinata si disintegra. Questa totalità è legata all'”Ab-grund”, un abisso di senso e apertura. L’opera nasce dall’inconscio, manifestando una “negazione” della propria parzialità. Queste immagini sono “mitologemi primordiali” che rivelano un senso inedito della totalità, non quantitativo ma qualitativo. La totalità è il non-essere-parziale della parte. Questo rivela un'”indifferenza” dove le distinzioni si dissolvono, mettendo in discussione l’attribuzione di valore e la “finzione” della bellezza. Nel “Manifesto contro niente”, Manzoni afferma che “una macchina è bella quasi quanto nessuna macchina”, mostrando che essere e niente non si contrappongono. La bellezza può illuminare sia ciò che è sia ciò che è nulla. “Qualche cosa è quasi niente”. Ciò che non esiste (arte, metafisica) sostiene ciò che esiste.Riassunto Lungo
1. La meraviglia dell’individuo nel mondo rovesciato
Il Barocco cambia profondamente l’arte e il modo di pensare. Non cerca più l’armonia del Rinascimento, ma vede il mondo pieno di doppiezza e incertezza. L’arte diventa come un teatro, pensiamo ai quadri di Caravaggio. C’è molta libertà nel creare le opere, si lascia perdere la prospettiva centrale. Si usa l’anamorfosi per mostrare che la verità si vede bene solo guardando le cose da un punto di vista particolare, non diretto.L’unicità delle cose
Ogni cosa prende forme curve, mostrando che è unica e non si lascia definire da regole generali che valgono per tutti.Don Chisciotte, eroe barocco
Don Chisciotte è un perfetto esempio di questa mentalità barocca. È un personaggio diviso: dice cose intelligenti, ma agisce in modo folle. È un “savio-pazzo” che mescola idee opposte. Le sue azioni non cercano un risultato sicuro, ma sono una risposta a un mondo che sembra aver bisogno di cambiare, un mondo dove le cose non sono quello che sembrano. Vede la verità nello specchio del teatro, nella finzione che mostra il mondo “alla rovescia”.Libertà e individualità
La sua libertà non ha limiti, va contro le regole della logica. Cerca di far tornare un’epoca passata, un’età dell’oro. Agisce solo per il piacere di affrontare imprese difficili e per il gusto della follia senza un vero motivo. Per lui, il mondo è pieno di persone uniche, che non si possono imprigionare in definizioni generali.Le fiabe barocche e la realtà
Le fiabe barocche, come quelle scritte da Basile, sono un modo per esplorare questo tipo di mondo. Mescolano cose che conosciamo con cose sconosciute, il possibile con l’impossibile. Creano un universo fantastico che è come uno specchio che deforma la realtà. Questo specchio mostra la doppiezza delle cose e quanto siano vicini concetti opposti come la vita e la morte.La fiaba non è solo per bambini
La fiaba non è pensata solo per i bambini. Usa mondi lontani per farci guardare meglio la vita di tutti i giorni. Mostra la bellezza che si nasconde anche nelle cose spaventose o brutte. Con la forza dell’immaginazione, mette in discussione le idee generali e mostra la forza dell’individuo che non si lascia imprigionare nelle definizioni. Il bosco, dove ci si può perdere e le cose cambiano forma, diventa un simbolo di rinascita e libertà per l’individuo.Il mistero nel quotidiano con Buzzati
Anche in tempi più vicini a noi, scrittori come Buzzati usano elementi delle fiabe per far vedere il mistero che c’è nell’esistenza. Un fatto che sembra semplice ma è impossibile, come una goccia d’acqua che sale le scale da sola, ci mostra quanto le cose siano uniche e non si possano ridurre a spiegazioni semplici.La vera impossibilità
Questo evento che non si può spiegare, che spesso accade di notte, crea confusione e paura. Mette in crisi il nostro modo di pensare logico e le spiegazioni che usiamo di solito. Non è una storia con un significato nascosto (un’allegoria), ma è la realtà stessa che si presenta in un modo che non riusciamo a capire del tutto. La vera impossibilità non è l’evento strano o eccezionale. È il semplice fatto che qualcosa di unico esista, anche se le nostre regole dicono che non dovrebbe essere reale. Questo mostra che il mistero è proprio lì, nel semplice, ingiustificabile fatto che ogni cosa esiste in modo unico.Ma l’esistenza unica di una cosa è davvero una “vera impossibilità” nel senso logico o scientifico?
Il capitolo conclude definendo la “vera impossibilità” come il semplice fatto che qualcosa di unico esista, anche se le nostre regole non lo prevedono. Questa definizione, sebbene suggestiva nell’ambito di una poetica del mistero e dell’eccezione, rischia di generare confusione concettuale. Le nozioni comuni di impossibilità si riferiscono solitamente a ciò che viola le leggi della logica (una contraddizione) o le leggi fisiche stabilite. L’unicità di un ente, per quanto sorprendente o inspiegabile dalle regole generali, non è di per sé una violazione logica o fisica. Per chiarire questa distinzione e comprendere meglio il rapporto tra unicità, eccezione e impossibilità, sarebbe utile approfondire gli studi di filosofia della logica e di metafisica. Autori come Aristotele o pensatori contemporanei che si occupano di ontologia e della natura dell’esistenza potrebbero offrire strumenti concettuali più precisi. Anche un confronto con la filosofia della scienza, che indaga la natura delle leggi e delle eccezioni, potrebbe essere illuminante.2. Il Teatro del Niente e la Bellezza Rovesciata
Il mondo si mostra come una grande rappresentazione teatrale, un gioco dove le azioni sembrano non avere conseguenze reali. L’arte, proprio come la magia di Prospero nella Tempesta, crea uno specchio della realtà che la ribalta, rivelando quanto sia fatta di apparenze e inconsistente. È un mondo capovolto, simile a quello di Alice, dove le cose non sono mai come sembrano e l’impossibile diventa possibile, mettendo in discussione la logica normale e le identità che crediamo definite.La ricerca dell’artista e il “niente” nell’opera
L’artista cerca di dare “vita” o “unità” alla sua creazione, andando oltre la semplice tecnica e la copia delle forme visibili. Questo sforzo porta a un risultato che, per chi cerca la bellezza nelle singole parti definite, appare come un “niente”, una massa confusa, proprio come la tela finale dipinta da Frenhofer.La bellezza oltre la forma e l’indifferenza estetica
La vera bellezza non si trova nelle caratteristiche specifiche o nell’esistenza concreta di un oggetto, ma in qualcosa di indefinito, un “niente”, che suggerisce un’unità che non si può afferrare con il pensiero logico. Il piacere che proviamo di fronte all’arte non nasce dall’interesse o dal gusto per le qualità precise dell’oggetto, ma da una sorta di indifferenza verso la sua esistenza materiale. L’arte più recente, come il ready-made di Duchamp, esprime bene questa indifferenza, suggerendo che il valore non sta nella forma o nell’abilità tecnica, ma in ciò che nega questi aspetti, rivelando un’unità profonda o un “niente” che sta alla base di tutto.Ma se la bellezza e l’unità profonda risiedono in un “niente” indefinito e nell’indifferenza verso l’esistenza materiale, come si concilia questo con l’esperienza concreta dell’arte e con la stessa ricerca dell’artista che cerca di dare “vita” e “unità” alla sua creazione, spesso attraverso forme e materiali specifici?
Il capitolo propone un’idea affascinante ma che solleva interrogativi sulla sua coerenza interna e sulla sua applicabilità. Affermare che la bellezza e un’unità profonda risiedano in un “niente” indefinito e che il piacere estetico nasca dall’indifferenza verso l’esistenza materiale dell’opera richiede un approfondimento significativo. Per esplorare la validità di tale prospettiva e comprendere come si possa passare dalla negazione della forma a una “unità” fondamentale, è indispensabile confrontarsi con le grandi questioni dell’estetica filosofica e della metafisica. Autori che hanno indagato il rapporto tra essere e nulla, come Hegel o Heidegger, o filosofi dell’arte che hanno analizzato le avanguardie e l’arte concettuale, possono offrire le chiavi di lettura per valutare la tenuta logica di queste tesi e colmare le lacune argomentative.3. La Quiete dell’Indifferenza
Un protagonista di romanzo decide di allontanarsi dalle azioni e dai progetti tipici della vita di oggi. Questa scelta lo porta a uno stato di indifferenza. È uno stato simile a quello cercato da artisti come Duchamp. Significa svuotarsi, smettere di credere, non desiderare più, non giudicare. Si diventa così un puro osservatore del mondo che ci circonda.Cosa Significa l’Indifferenza
Questa condizione permette di vedere l’esistenza delle cose per come sono davvero, senza le finzioni create da valori o emozioni. La realtà appare nella sua forma originale, non cambiata dal nostro sguardo. Il protagonista del romanzo scopre di non voler più sentire o vedere. Cerca l’immobilità e il silenzio. Da qui nasce un desiderio profondo di calma, un nucleo di indifferenza che vuole restare nascosto dagli occhi degli altri. È un modo per essere presenti senza intervenire, osservando la vita scorrere senza esserne travolti.Imparare a Essere Indifferenti
L’indifferenza richiede di imparare a stare da soli, ad avere pazienza e a fare silenzio dentro di sé. Bisogna perdere l’abitudine a sperare in qualcosa e a iniziare nuovi progetti. Si impara a essere trasparenti, immobili, quasi inesistenti. Si arriva a guardare gli altri come fossero oggetti inanimati, come pietre. Ogni azione, anche quella creativa, non serve più a raggiungere obiettivi esterni o a comunicare qualcosa. L’atto di fare diventa fine a se stesso, senza un significato più grande.Vedere le Cose per Come Sono
Prendiamo l’esempio di un albero. Davanti a un albero, non c’è niente da capire. C’è solo da guardare. L’albero è semplicemente un albero. Non ci offre messaggi nascosti o insegnamenti morali. Le cose, come le opere d’arte, non ci chiedono niente. Sono diverse dagli animali domestici, che invece hanno bisogno di attenzioni e affetto. Non si può possedere un albero. Si può solo desiderare di essere come lui: semplice, immobile e presente nella sua essenza.Indifferenza e Creazione Artistica
Anche le opere di Duchamp, come i suoi famosi ready-made, nascono senza uno scopo preciso. Sono create quasi per gioco, non per rivoluzionare il mondo dell’arte o per trasmettere significati profondi. Chi vive nell’indifferenza lascia che le sue azioni si collochino in uno spazio neutro. Non sono azioni fatte per uno scopo pratico o per ottenere un risultato. Sono gesti che esistono per il solo fatto di esistere.L’Osservatore Indifferente
L’artista, proprio come il protagonista studente o lo scrivano Bartleby nel racconto di Melville, non ha preferenze. Non distingue tra bello e brutto, tra ciò che è familiare e ciò che sorprende. Diventa come uno specchio che riflette in modo neutro le particolarità del mondo. Queste particolarità sono uniche e non possono essere ricondotte a forme generali o universali. L’indifferente accoglie ogni cosa senza giudizio, mostrandola nella sua singolarità.La Natura dell’Indifferenza
Questo stato di indifferenza può sembrare una forma di felicità o serenità. Tuttavia, è una sensazione illusoria. Stare da soli o essere indifferenti non porta a imparare nulla di nuovo. Non accade nessun evento straordinario o miracoloso. L’indifferenza, in realtà, non cambia la persona che la vive. Non la rende diversa da prima, nonostante la percezione di un cambiamento interiore.Per secoli, l’arte ha cercato la bellezza, considerandola un valore capace di salvare o elevare. Però, questa ricerca ha spesso nascosto la vera natura del “bello in sé”, come lo intendeva Platone. Questa bellezza pura non ha niente a che fare con qualcosa che ci gratifica o che ci è utile. Arrivare al fondo delle cose, toccare la bellezza o la trascendenza, in questo stato, non significa niente. Ogni forma di espressione artistica, alla fine, riporta sempre e solo al “niente”.
Ma se l’arte contemporanea rifiuta bellezza, piacere e significato, non rischia forse l’irrilevanza o di diventare un esercizio autoreferenziale compreso solo da pochi?
Il capitolo propone una visione molto specifica e potenzialmente limitata di cosa sia e cosa cerchi l’arte contemporanea, quasi ignorando la sua enorme varietà e le diverse funzioni che può assumere al di là della “pura presenza” o della rivelazione dei “legami”. Per comprendere meglio il dibattito su questi temi, è fondamentale esplorare le diverse teorie dell’arte contemporanea e il suo rapporto con la società, il significato e l’esperienza del fruitore. Approfondire autori come Arthur Danto e altri teorici dell’arte contemporanea può offrire prospettive più ampie e sfaccettate.8. L’Essere che Diviene nell’Arte
Il mito pone gli eventi in un tempo sacro e originario, creando un ordine del cosmo dove i fatti di ogni giorno cambiano valore e le regole normali non valgono più.Esiste una vicinanza tra il racconto “Una goccia” di Buzzati e il modo di fare arte di Piero Manzoni. Buzzati vede la goccia solo come una goccia, senza cercare significati nascosti o simbolici. Allo stesso modo, Manzoni mostra le sue superfici bianche, chiamate “achromes”, come completamente senza colore e neutre, al di fuori di ogni idea di pittura. Una superficie bianca è, semplicemente, una superficie bianca.L’Arte che “È”, non che “Dice”
Manzoni toglie dalla sua arte ogni cosa che considera “di troppo” o che serve a interpretare. Non vuole creare composizioni o “esprimere” qualcosa, ma arrivare a una “libertà totale”. L’arte, per lui, non deve preoccuparsi di forme, spazi o colori. Le sue linee, anche quelle molto lunghe o che sembrano “infinite”, non servono a definire spazi, ma sono viste come “pura filosofia”.L’Essere come Divenire Puro
Per Manzoni, l’artista deve “essere”, non “dire” qualcosa. Un’opera d’arte ha valore solo perché “è”, come un essere completo. Questa idea si collega a movimenti come Dada e Surrealismo, che rifiutavano l’idea che l’arte dovesse esprimere qualcosa. Non ha senso “alludere, esprimere, rappresentare”. Questi sono problemi che, per Manzoni, “non esistono”. Il valore di un quadro non dipende da come è composto o dai colori usati, ma da un cambiamento profondo e totale. L’artista libera gli oggetti e il mondo dai significati che gli diamo, facendo emergere il loro puro “essere”. Questo essere totale è un continuo trasformarsi, un puro divenire. Manzoni capisce che essere e divenire non sono uno contro l’altro; l’essere, nella sua purezza, è divenire. L’esistenza è fatta di ciò che non c’è più o che non c’è ancora.Rivelare il Movimento Intimo dell’Esistenza
Lo scopo dell’arte è far vedere questo divenire, quel “non essere che sempre e solamente c’è”, superando le “finzioni vuote” che bloccano la vita in forme rigide e creano l’illusione che le cose siano permanenti. L’arte mette in discussione l’idea che ciò che è importante sia permanente e universale, mentre ciò che cambia sia senza valore. Ciò che deve “volare” è l’esistenza stessa, nel suo essere dinamico e impossibile da afferrare. “Non c’è nulla da dire: c’è solo da essere, c’è solo da vivere”. Manzoni, anche se influenzato da artisti come Fontana, il Surrealismo e Dada, cerca di scomporre i fenomeni per scoprire i loro “moti più intimi”. Vuole ridurre ogni fenomeno a una specie di “unità minima” dove le differenze spariscono, diventando “puro divenire”, “movimento puro”.L’Arte come Ricerca delle Origini
Questo processo fa emergere le “immagini prime”, le emozioni più profonde che mostrano una vera Realtà. L’arte cerca la base da cui nascono i miti, un movimento puro, energia, le immagini che si muovono dell'”inizio”. L’arte è come una “commedia dell’arte”, un “teatro”, che cerca il “vivo germe della umana totalità”, dove ogni forma definita si dissolve. Questa totalità è legata all'”Ab-grund”, un abisso che è fonte di significato e apertura. L’opera nasce dall’inconscio, mostrando una specie di “negazione” del suo essere solo una parte. Queste immagini sono “mitologemi primordiali” che rivelano un senso nuovo e totale, non basato sulla quantità ma sulla qualità. La totalità è il non-essere-parziale della parte.Dissoluzione delle Distinzioni e la “Finzione” della Bellezza
Questo svela un'”indifferenza” dove le differenze si annullano, mettendo in discussione il modo in cui diamo valore alle cose e l’idea che la bellezza sia una “finzione”. Nel “Manifesto contro niente”, Manzoni dice che “una macchina è bella quasi quanto nessuna macchina”, mostrando che l’essere e il niente non sono l’uno contro l’altro. La bellezza può illuminare sia ciò che esiste sia ciò che è nulla. “Qualche cosa è quasi niente”. Ciò che non esiste, come l’arte o la metafisica, sostiene ciò che esiste.Se l’arte di Manzoni, come descritta nel capitolo, rifiuta ogni forma di “dire” o “esprimere”, come può contemporaneamente aspirare a “rivelare il movimento intimo dell’esistenza” o far emergere “immagini prime”?
Il capitolo presenta l’arte di Manzoni come un’arte che si limita a “essere”, spogliata di ogni intento comunicativo o interpretativo. Tuttavia, l’argomentazione prosegue attribuendo a quest’arte la capacità di svelare verità profonde sull’esistenza e le sue origini. Questa apparente contraddizione necessita di un’indagine più approfondita su cosa significhi “rivelare” nel contesto di un’arte che non “dice”. Per comprendere meglio questa dinamica, può essere utile esplorare le filosofie che trattano il rapporto tra essere e apparenza, e le teorie estetiche che analizzano le avanguardie storiche e il loro rapporto con il significato. Approfondire autori come Heidegger, o studiosi che hanno analizzato criticamente il lavoro di Manzoni e il contesto dell’arte concettuale, può fornire strumenti per affrontare questa questione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]