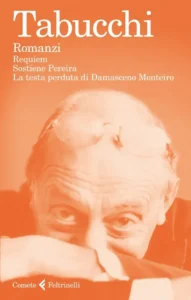1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “Di tutto resta un poco. Letteratura e cinema” di Antonio Tabucchi è un viaggio affascinante nel cuore della scrittura e della visione cinematografica, un’esplorazione che parte da un profondo amore per le parole e per le immagini che prendono vita sullo schermo. Tabucchi, con la sua consueta lucidità e passione, ci guida attraverso un percorso che intreccia le riflessioni sulla letteratura del Novecento, da Pessoa a Borges, da Montale a Pasolini, con un occhio attento al cinema, da Almodóvar a Fellini. Il libro non è solo una raccolta di saggi, ma un vero e proprio dialogo tra diverse forme d’arte, dove i temi centrali come il tempo, la memoria, l’identità e la fragilità della democrazia emergono con forza. Attraverso le pagine, si incontrano autori e registi che hanno saputo cogliere le sfumature dell’animo umano, le contraddizioni della storia e la magia del linguaggio, offrendo prospettive uniche sulla realtà, spesso ambientate in luoghi lontani e suggestivi, dalle isole remote alle città europee. È un invito a riscoprire il potere della letteratura e del cinema come specchi della nostra esistenza, capaci di rivelare verità nascoste e di lasciare un segno indelebile, quel “poco” che resta di tutto.Riassunto Breve
La letteratura è vista come una forma di conoscenza che va oltre la logica, capace di esplorare dimensioni intuitive e di rivelare aspetti nascosti della realtà, mettendo in discussione le verità assolute e indagando le zone d’ombra della vita e della storia. Il rapporto tra letteratura e tempo è centrale, con un’attenzione particolare al “male di vivere” e al senso di estraneità che caratterizzano il Novecento, temi espressi da autori come Pessoa, Montale, Gadda e Pasolini, spesso legati a uno scollamento tra tempo individuale e storico. La letteratura possiede la capacità di “comprensione tardiva” o “anticipata”, intuendo o elaborando eventi e sentimenti in modo non lineare, legando passato e futuro, e generando riflessione. Essa non è solo intrattenimento, ma uno strumento per comprendere la complessità del mondo e agire come coscienza critica, lavorando negli “interstizi” della scienza per offrire una visione più completa della vita.La dicotomia tra luna e sole nella cultura e nella poesia viene reinterpretata, con il Futurismo di Marinetti che celebra la modernità e la luce artificiale. Parallelamente, si osserva un ritorno a forme di pensiero regressivo e alla giustificazione di pratiche come la tortura in nome della sicurezza, minacciando la fragilità della democrazia. Il concetto di “Saudade” nella cultura portoghese, legato alla nostalgia e all’attesa, mostra come la memoria del passato e l’aspirazione a un ideale plasmino l’identità culturale e politica.La letteratura del Novecento esplora la natura sfuggente del sogno e la complessità dell’identità, intrecciandole con la lingua e l’esperienza culturale. Arthur Schnitzler indaga la dimensione onirica, collegandosi alle teorie freudiane sull’inconscio. Rudyard Kipling illustra come lingua e ambiente culturale plasmino l’identità, mentre Vicente Aleixandre mostra come la vita interiore e la salute influenzino la produzione artistica, esplorando la metamorfosi del reale.Jorge Luis Borges privilegia l’idea rispetto all’oggetto concreto, trasformando la realtà in metafora della condizione umana e anticipando concetti scientifici moderni. La sua opera riflette un mondo sempre più complesso e seriale, dove la realtà stessa è messa in discussione, con un rifiuto dell’identità personale e una narrativa incentrata su temi come il tempo circolare e il labirinto. Carlos Drummond de Andrade esprime una paura della modernità e della disumanizzazione, mentre João Guimarães Rosa esplora l’infanzia e la condizione umana attraverso paesaggi remoti, trasformando la letteratura in un’esperienza che va oltre la comprensione razionale.Mercè Rodoreda cattura la Guerra Civile Spagnola attraverso l’assenza, mentre Guglielmo Petroni racconta la resistenza interiore di fronte all’abiezione. Julio Cortázar vede nelle parole un legame quasi magico con il linguaggio, creando un universo in cui il “fantastico” è una questione filosofica sulla natura della realtà, esplorando realtà parallele e l’essenza delle cose.Il Novecento è segnato da eventi traumatici come lo sterminio degli ebrei, e “Se questo è un uomo” di Primo Levi affronta la possibilità di fare letteratura su Auschwitz, trasformando il tempo in luogo e rappresentando l’orrore come “propedeutica del niente”. Manuel Puig cattura il clima sociale dell’America Latina attraverso storie private, utilizzando il “feuilleton” e il cattivo gusto per stimolare la riflessione critica. José Luandino Vieira scrive in “musseque”, una lingua creata dal sottoproletariato angolano, riflettendo la creatività e la resistenza.Il romanzo “Il delfino” di José Cardoso Pires analizza la stagnazione del tempo e della storia in un Portogallo rurale, con la morte che assume una dimensione esistenziale e storica. Bernard Comment critica la “stupidità” della modernità nell’arte, che porta all’omologazione e alla “pornografia” intellettuale. Fabrizio De André viene analizzato come autore di testi poetici autonomi, capace di rinnovare la tradizione letteraria italiana attraverso forme metriche antiche adattate a temi moderni.La letteratura riflette la complessità della realtà attraverso diverse prospettive. In “Nel museo di Reims” di Daniele Del Giudice, si analizza la percezione e la menzogna, mettendo in discussione la possibilità di una verità oggettiva. Norman Manea affronta temi di esilio, identità e memoria storica, con la lingua come unico spazio di appartenenza. La poesia di Alexandre O’Neill è una voce critica e disincantata contro il regime salazarista, smontando miti e retoriche con un linguaggio diretto e ironico.Il corpo e la voce umana sono collegati all’espressione emotiva e alla percezione di sé, con diverse prospettive storiche sul corpo. Il giornalismo è uno strumento di riflessione per gli scrittori, come dimostrano García Márquez, Borges e Pasolini. Mario Vargas Llosa unisce vocazione letteraria e attività giornalistica per analizzare la realtà e difendere valori. La letteratura è difesa contro la sua presunta “morte”, e Manuel Vázquez Montalbán è omaggiato come scrittore legato alla sua Barcellona.L’autofiction trasforma la vita in letteratura, esplorando l’io nell’opera. Enrique Vila-Matas indaga la scrittura concentrandosi sul “non scrivere”, creando un “club della letteratura del No”. Il silenzio è visto come una scelta, una forma di vita, e le ragioni del silenzio sono esplorate in autori come Juan Rulfo e Petronio. La figura del poeta è quella di un essere senza identità fissa, capace di incarnare tutto e niente. La letteratura è definita da Mallarmé come qualcosa che va oltre il semplice narrare, e la riflessione di Rimbaud sull’arte come “sciocchezza necessaria” dà sapore e senso alla vita. Il cinema di Fellini e il film “La dolce vita” hanno segnato una svolta, rivelando ipocrisia e vuoto.Il cinema di Almodóvar esplora la condizione umana come intreccio di sogno, teatro e circo, con il clown che rappresenta la dualità dell’uomo. Il travestimento e l’androginia sfumano i confini di genere, mentre la voce assume un ruolo magico e le canzoni sono riti che celebrano desideri. L’arte è vista come la vera biografia dell’artista, e Marilyn Monroe è un’icona complessa che nascondeva un’anima intellettuale e poetica.Il romanzo di Romana Petri ambientato nelle Azzorre racconta la storia di una madre che rievoca la vita del figlio e della famiglia, con il capofamiglia che rifiuta il progresso e il mondo. Il romanzo di Athos Bigongiali esplora la figura di Roger David Casement, patriota irlandese, attraverso la narrazione della donna che lo amò. Bruno Schulz trasforma la sua città natale in uno scenario cosmico, con la sua opera che dimostra come la cultura umanistica possa essere un antidoto all’ignoranza.L’Italia è descritta come un paese in cui “nulla cambia”, con gli eventi del G8 di Genova nel 2001 che rivelano la natura del sistema. La letteratura assume il ruolo di testimone della realtà, analizzando le storture della società italiana. “Ça change quoi” di Roberto Ferrucci esplora il “cuore di tenebra” della “Cosa”, identificata con un fascismo eterno. “Cicoria” di Alfonso Casella anticipa la trasformazione dell’Italia in un “soggetto patologico”, con una società definita “mucillagine”. “Ogni promessa” di Andrea Bajani esplora la complessità della coscienza umana, collegandola alle teorie neuroscientifiche e affrontando il peso del passato.Il panorama letterario italiano contemporaneo è vivace, con scrittori che rinnovano il genere, distaccandosi dalle formule tradizionali. Questo dinamismo si contrappone a un contesto culturale nazionale percepito come statico. “Dove eravate tutti” di Paolo Di Paolo cattura lo “Zeitgeist” attuale, riflettendo sull’Italia come una “nave da crociera” alla deriva, un’epoca di vuoto e malinconia. Luciana Stegagno Picchio, studiosa di letteratura portoghese, promuove un approccio comparatista alla letteratura. L’intelligenza di Elvira Sellerio è associata all’eleganza e a una profonda connessione con la cultura della Scuola siciliana.Andrea Zanzotto è descritto come un tramite tra la Terra e la Luna, capace di cogliere suoni e voci profonde. Antonio Tabucchi riflette sul Principio di Heisenberg e sull’idea di “caso” o “destino”, sottolineando come la vita sia fatta di incontri inspiegabili. La misurazione del tempo, attraverso metafore legate agli orologi di Breguet, diventa un simbolo del modo in cui il tempo viene percepito e gestito.Il progetto di raccogliere saggi sulla letteratura nasce dal desiderio di Antonio Tabucchi di concentrarsi su scritti che avessero una maggiore durata nel tempo, esplorando la letteratura come forma di conoscenza e mezzo per interrogare la vita. La raccolta include riflessioni su figure letterarie come Pessoa, Borges, Drummond de Andrade e Cortázar, e temi come la “saudade”. Il libro si articola in diverse sezioni tematiche, creando un canone di letture significative che mostrano come la letteratura possa fungere da specchio per riconoscersi e comprendere il mondo. L’opera finale, “Residuo”, sottolinea come, nonostante tutto, di ogni cosa rimanga sempre un poco.Riassunto Lungo
1. Il Tempo, la Letteratura e il Dubbio
La Letteratura come Forma di Conoscenza
La letteratura offre una forma di conoscenza che va oltre la logica. È capace di esplorare dimensioni intuitive e di rivelare aspetti nascosti della realtà. Invece di limitarsi a inventare, la letteratura scopre, proponendo una prospettiva diversa da quella abituale e mettendo in discussione le verità considerate assolute. La sua funzione è quella di indagare le zone d’ombra e le contraddizioni della vita e della storia, andando a cercare ciò che viene omesso.Letteratura e Inquietudine nel Novecento
Il testo analizza il rapporto tra letteratura e tempo, mettendo in luce come l’inquietudine, il “male di vivere” e il senso di estraneità siano temi molto presenti nel Novecento. Autori come Pessoa, Montale, Gadda e Pasolini sono citati come esempi di come la letteratura abbia saputo cogliere e rappresentare questo disagio esistenziale. Questo sentimento è spesso legato a una differenza tra il tempo vissuto personalmente e il tempo storico.La Comprensione del Tempo: Anticipazione e Ritardo
Viene esplorato il concetto di “comprensione tardiva” o “anticipata”. Si tratta della capacità di alcuni scrittori di intuire o elaborare eventi e sentimenti prima che accadano o molto tempo dopo. Questa forma di comprensione, che lega passato e futuro in modo non lineare, è considerata una fonte di alta letteratura. È in grado di generare turbamento e una riflessione profonda. Esempi come Cervantes, Joyce, Gadda e Pasolini dimostrano come esperienze personali o contesti storici abbiano influenzato questa capacità di visione.La Letteratura come Strumento Critico
In questo senso, la letteratura non è solo intrattenimento, ma uno strumento essenziale per comprendere la complessità del mondo. Serve a porre domande e ad agire come coscienza critica. La letteratura lavora negli “interstizi” della scienza, offrendo una visione più sottile e completa della vita. Questa visione è necessaria per correggere la distanza tra la semplicità dei fatti e la complessità dell’esistenza umana.Se la letteratura “scopre” e “indaga le zone d’ombra” andando oltre la logica, come possiamo validare o contestare le sue “verità” che sfidano la razionalità, e non rischia questo approccio di trasformarsi in un relativismo assoluto dove ogni interpretazione è legittima, privandoci di un terreno comune di comprensione?
Il capitolo suggerisce che la letteratura offra una forma di conoscenza “oltre la logica”, capace di esplorare dimensioni intuitive e rivelare aspetti nascosti della realtà. Tuttavia, questa affermazione solleva interrogativi sulla verificabilità e sulla potenziale soggettività estrema di tale conoscenza. Per esplorare queste questioni, sarebbe utile approfondire la filosofia della conoscenza, in particolare le correnti che si occupano dell’epistemologia delle arti e delle scienze umane. La lettura di opere che analizzano il rapporto tra interpretazione, verità e soggettività, come quelle di Paul Ricœur o Umberto Eco, potrebbe fornire strumenti critici per comprendere meglio come la letteratura possa essere sia uno strumento di scoperta che un potenziale veicolo di ambiguità. Si potrebbe anche considerare l’impatto della psicologia cognitiva sulla percezione e sull’elaborazione delle narrazioni, per capire come le nostre strutture mentali interagiscano con le “intuizioni” letterarie.La Luna, il Sole e la Fragilità della Democrazia
Dicotomia tra Luna e Sole nella Cultura
La cultura e la poesia hanno spesso esplorato il rapporto tra la luna e il sole. La luna, tradizionalmente legata alla notte, al sogno e al mistero, è stata vista come un simbolo di ambiguità e immortalità. Questo contrasta con il sole, che rappresenta il vigore e la vita. Questa differenza è stata reinterpretata nel corso della storia, trovando un’espressione particolare nel Futurismo di Marinetti. Egli celebrava la velocità e la modernità, arrivando a proporre l’eliminazione del “chiaro di luna” a favore di un futuro dominato dalla luce artificiale e dalla macchina.La Democrazia Sotto Minaccia
Parallelamente, si osserva una preoccupante tendenza, emersa soprattutto dopo l’11 settembre 2001, verso un ritorno a forme di pensiero regressive. Questa tendenza porta alla giustificazione di pratiche come la tortura in nome della sicurezza. La democrazia è un sistema perfettibile, che può evolversi ma anche involvere. La sua fragilità si manifesta quando i principi fondamentali vengono compromessi, anche nella lotta al terrorismo. Esempi come Abu Ghraib e Guantanamo evidenziano questa vulnerabilità. La mancanza di leggi chiare contro la tortura, come accade in Italia, e l’impunità dei responsabili minacciano la salute stessa della democrazia.Il Concetto di “Saudade”
Infine, il concetto di “Saudade” nella cultura portoghese merita attenzione. Questo sentimento complesso e intraducibile è legato alla nostalgia, alla malinconia, ma anche all’attesa di un futuro migliore. Esplorato attraverso la letteratura portoghese, mostra come la memoria del passato e l’aspirazione a un ideale possano plasmare l’identità culturale e politica di una nazione. Questo evidenzia la continua tensione tra ciò che è stato e ciò che si desidera.È davvero una “fragilità” della democrazia quella che si manifesta con la tortura, o piuttosto una sua intrinseca capacità di adattamento, anche a costo di rinnegare i propri principi fondanti, di fronte a minacce percepite come esistenziali?
Il capitolo collega la dicotomia culturale tra Luna e Sole, reinterpretata dal Futurismo, alla fragilità democratica emersa dopo l’11 settembre, citando esempi come Abu Ghraib e Guantanamo. Tuttavia, la connessione tra la celebrazione futurista della macchina e della luce artificiale e la regressione del pensiero democratico appare piuttosto tenue e non sufficientemente argomentata. Manca un’analisi approfondita di come la retorica futurista, o più in generale un certo approccio alla modernità, possa aver creato un terreno fertile per la giustificazione di pratiche autoritarie. Inoltre, l’introduzione del concetto di “Saudade” sembra scollegata dal resto del capitolo, sebbene si cerchi di collegarla alla tensione tra passato e futuro. Per comprendere meglio la fragilità democratica e le sue cause profonde, sarebbe utile esplorare le teorie sulla crisi dello stato di diritto e sul rapporto tra sicurezza e libertà, magari approfondendo il pensiero di pensatori come Hannah Arendt o Carl Schmitt, che hanno analizzato le tensioni tra ordine e libertà, e le dinamiche del potere in situazioni di emergenza. Sarebbe altresì utile indagare più a fondo le radici culturali e psicologiche che portano alla giustificazione di pratiche estreme in nome della sicurezza, andando oltre la semplice constatazione di una “regressione”.La Trama dei Sogni e la Ricerca dell’Identità nella Letteratura del Novecento
L’Esplorazione del Sogno e l’Inconscio
La letteratura del Novecento si addentra nella natura sfuggente del sogno e nella complessità dell’identità, spesso intrecciando questi temi con l’uso della lingua e l’esperienza culturale. Arthur Schnitzler, con la sua novella “Doppio sogno”, analizza la dimensione onirica come uno spazio misterioso e indecifrabile, dove la logica della veglia viene meno. Questo approccio si lega alle teorie di Sigmund Freud sull’interpretazione dei sogni, che vedeva nell’inconscio la chiave per comprendere il significato nascosto delle nostre esperienze oniriche. Freud stesso, nel suo lavoro, trasforma la narrazione dei sogni in una forma letteraria, rendendo “romanzesco” ciò che appartiene a una materia diversa dalla realtà cosciente.Lingua, Cultura e Identità: Il Caso Kipling
Rudyard Kipling offre un esempio di come la lingua e l’ambiente culturale plasmino l’identità e la scrittura. Cresciuto in India e poi educato in Inghilterra, Kipling ha imparato a pensare e sognare in indostano, per poi scrivere in inglese. La sua opera, caratterizzata da uno stile limpido e un forte senso del reale, cattura l’essenza del mondo coloniale e l’avventura, pur rimanendo ancorato a una visione ottocentesca. La sua capacità di osservare e descrivere il mondo, trasformando la realtà in favola, lo rende un esempio di come l’esperienza personale si rifletta nella creazione letteraria.La Poesia come Metamorfosi del Reale: Vicente Aleixandre
Vicente Aleixandre rappresenta un altro esempio di come la vita interiore e la salute influenzino la produzione artistica. La sua poesia, profondamente legata alla sua biografia spirituale e vissuta in una sorta di ritiro, esplora la metamorfosi del reale attraverso immagini potenti e un’eleganza formale che attinge al Surrealismo e alla tradizione poetica spagnola. La sua opera, pur mantenendo una certa distanza, riflette una lotta interiore tra l’avanguardia e un bisogno di misura e controllo, evidenziando come la poesia possa essere una forma di vittoria su se stessi.Un Quadro Complessivo dell’Animo Umano
Questi autori, nel loro insieme, dimostrano come la letteratura del Novecento abbia affrontato la complessità dell’animo umano, il potere dei sogni e l’influenza delle esperienze culturali e linguistiche sull’identità. L’indagine sulla psiche, la capacità di trasformare la realtà attraverso la lingua e la ricerca di un equilibrio interiore sono elementi centrali nella produzione letteraria di questo periodo.Se la percezione della realtà di Zanzotto è un “squarciare” per scoprirne il retroscena e la visione di Tabucchi è guidata da un “caso” o “destino” quasi inspiegabile, come conciliare queste visioni con la precisione meccanica e l’ubiquità temporale suggerite dalle metafore dell’orologeria di Breguet, senza cadere in un determinismo poetico o in un fatalismo scientifico?
Il capitolo presenta affascinanti paralleli tra l’opera di poeti e pensatori, ma la connessione tra la percezione “elettrica” e “squarciante” di Zanzotto, l’idea di “caso” e “appuntamenti” di Tabucchi, e le metafore temporali dell’orologeria di Breguet potrebbe beneficiare di un’ulteriore elaborazione. Si potrebbe approfondire come la poesia possa effettivamente “squarciare” la realtà e se l’intuizione di Tabucchi sul “caso” sia una forma di riconoscimento di pattern complessi o una vera e propria forza esterna. Per esplorare queste dinamiche, sarebbe utile consultare studi sulla filosofia del tempo, la teoria della complessità e la poetica ermetica. Autori come Gilles Deleuze, con le sue riflessioni sul tempo e sulla differenza, o Italo Calvino, con la sua esplorazione delle strutture narrative e del caso, potrebbero offrire spunti preziosi per comprendere meglio come questi diversi approcci alla realtà e al tempo possano intrecciarsi.7. La Letteratura Come Specchio del Mondo
L’idea alla base del progetto
Il desiderio di Antonio Tabucchi era quello di raccogliere saggi che avessero una profondità tale da resistere al tempo, distinguendosi da scritti più legati all’attualità o a recensioni rapide. Questo intento si è tradotto nella scelta di testi che vedono la letteratura non solo come forma di intrattenimento, ma come uno strumento fondamentale per conoscere, per interrogare la vita e le esperienze, e per dare voce a pensatori e autori importanti.Figure e temi esplorati
La raccolta offre riflessioni su personalità letterarie di spicco, tra cui Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Carlos Drummond de Andrade e Julio Cortázar. Attraverso l’analisi delle loro opere, si indaga il loro contributo unico e l’impatto che hanno avuto sul panorama letterario. Vengono inoltre approfonditi temi ricorrenti come la “saudade”, un sentimento di nostalgia e malinconia, spesso associato all’opera di Pessoa, e il desiderio in tutte le sue sfaccettature.Struttura e sezioni del libro
Il libro è organizzato in diverse sezioni tematiche per guidare il lettore attraverso i vari argomenti trattati.- Orizzonti: Presenta saggi che introducono la visione personale dell’autore sulla letteratura.
- Scrittori: Dedicata all’analisi approfondita di autori specifici.
- Amici: Raccoglie testi dedicati a persone vicine all’autore.
- Cinema: Esplora il legame e le intersezioni tra il mondo della letteratura e quello del cinema.
- Scrittori di oggi: Contiene recensioni e riflessioni su autori contemporanei.
- Commiati: Include testi in memoria di figure importanti che sono venute a mancare.
- Conclusione: Un pezzo finale che offre una riflessione sul tempo che passa e sulla memoria.
Il valore della letteratura come specchio
La selezione dei testi, frutto di un’attenta revisione e approvazione da parte di Antonio Tabucchi stesso, mira a creare un percorso di lettura significativo. L’obiettivo è mostrare come la letteratura possa agire come uno specchio in cui riconoscersi e attraverso cui comprendere meglio il mondo, specialmente nei momenti in cui le altre vie sembrano chiuse. L’opera finale, intitolata “Residuo” e ispirata da una poesia di Drummond de Andrade tradotta da Tabucchi, lascia un messaggio potente: nonostante tutto, di ogni esperienza, di ogni vita, rimane sempre una piccola parte, un residuo prezioso.Se la letteratura è uno specchio del mondo e uno strumento per interrogare la vita, come può la selezione di saggi, approvata da un singolo autore, garantire una visione oggettiva e completa di tali interrogativi, evitando la cristallizzazione di prospettive parziali o l’esclusione di voci dissenzienti?
Il capitolo afferma che il desiderio di Antonio Tabucchi era quello di raccogliere saggi con una profondità tale da resistere al tempo, distinguendosi da scritti legati all’attualità. Tuttavia, l’idea che la letteratura possa essere uno strumento fondamentale per conoscere e interrogare la vita, specialmente quando “le altre vie sembrano chiuse”, solleva interrogativi sulla potenziale autoreferenzialità di una selezione curata da una singola figura, per quanto autorevole. Per approfondire la comprensione di questo aspetto, sarebbe utile esplorare la critica letteraria che analizza il ruolo del curatore e la costruzione del canone. La lettura di autori che hanno discusso la natura della critica, come Roland Barthes o Edward Said, potrebbe offrire spunti interessanti. Inoltre, un’analisi comparativa di diverse antologie curate da autori con visioni differenti potrebbe evidenziare come la scelta dei testi influenzi la percezione del “mondo” e della “vita” che la letteratura riflette.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]