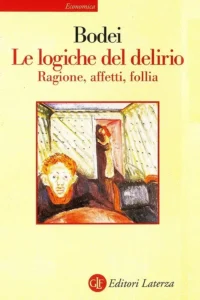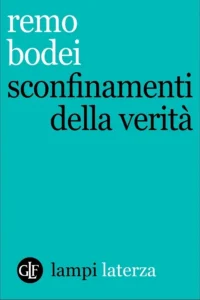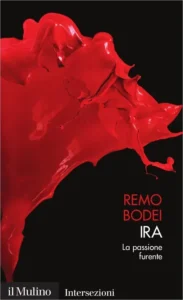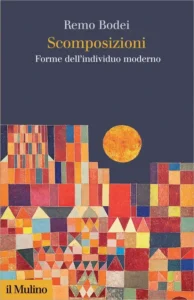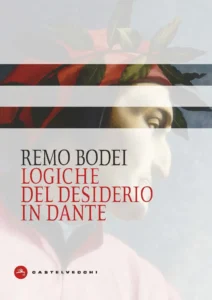1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze” di Remo Bodei ti fa riflettere su una domanda fondamentale: cos’è davvero la nostra `identità personale`? Il libro ripercorre come è cambiata l’idea dell’`io` e della `coscienza` nel tempo, partendo dai filosofi che cercavano di definirla, passando per la `psicologia` che ha mostrato la nostra `frammentazione` interna, fino ad arrivare alle sfide enormi poste dalla `massa` e dai `totalitarismi` del Novecento, che hanno cercato di annullare l’individuo nel “Noi” collettivo. Bodei esplora come il nostro `sé` sia sempre in bilico, influenzato da forze interne (come la `volontà` o il `corpo`) ed esterne (la società, la politica, la tecnologia), e come oggi, tra `narcisismo` e `patchwork` di identità, sia ancora più difficile mantenere un punto fermo. È un viaggio affascinante attraverso la storia del pensiero che ti fa capire quanto sia fragile ma allo stesso tempo cruciale la lotta per la nostra `autonomia` in un mondo che cerca costantemente di definirci o disperderci.Riassunto Breve
L’identità personale, vista inizialmente come un soggetto di coscienza e volontà stabile nel tempo grazie a memoria e consapevolezza, incontra presto difficoltà nel dimostrare la sua persistenza, portando a concezioni dove l’io è un insieme di percezioni effimere o un’entità inconoscibile. Questa visione viene ribaltata dall’idea di una volontà impersonale e cieca come nucleo dell’essere, dove l’individuo e la coscienza sono manifestazioni transitorie e l’identità si basa sulla volontà stessa, manifestata dal corpo, con l’intelletto visto come uno strumento al servizio della volontà. Parallelamente, studi scientifici di fine Ottocento descrivono la personalità come un aggregato instabile, una “colonia” di elementi psichici, dove l’unità della coscienza è una costruzione precaria che richiede energia per resistere alla disgregazione; la ragione e la percezione corretta sono il risultato di un continuo lavoro di repressione e coordinamento, mostrando un io fragile e potenzialmente scisso, non più padrone di sé ma dipendente dal corpo. L’idea tradizionale di un io unico è superata, rivelando un io composto da una pluralità di elementi, un “arcipelago di forze”, dove l’unità percepita è un equilibrio precario, una “coalizione” di io minori; le malattie mentali non sono rotture di un’unità originale, ma manifestazioni di questa molteplicità costitutiva, radicata nel corpo e nelle sue funzioni fisiologiche. Questa prospettiva è approfondita dall’idea che il corpo sia una “grande ragione” di molteplici forze e “anime”, con l’io cosciente come semplificazione superficiale, un “baricentro” mobile di forze in lotta; la forza individuale sta nel coordinare queste forze, non nel sopprimerle, contrapponendo l'”uomo superiore” che accetta la propria pluralità all'”uomo del gregge” che la teme, cercando rifugio nell’uguaglianza. La dottrina dell’eterno ritorno diventa uno strumento per l’uomo superiore per affermare la vita e disciplinare la molteplicità dell’io. La coscienza individuale sperimenta una costante dispersione, vivendo proiettata verso l’esterno e confondendo stati interni fluidi con la stabilità apparente delle cose, trattando la coscienza come un oggetto dividendo il tempo linearmente; la vera dimensione è la durata, un cambiamento qualitativo continuo, e la personalità si sviluppa per scelte che implicano dissociazione, con abbozzi di io passati che possono riemergere tramite la memoria involontaria, rivelando un “vero io” nascosto sotto le personalità successive, un’essenza che l’arte può aiutare a decifrare. La società impone un’identità fissa, un “spontaneo artificio” fragile e arbitrario, contro il flusso caotico della vita; di fronte a questa frammentazione, si può conformarsi, creare realtà alternative con l’immaginazione, o cercare la dissoluzione dell’io diventando “nessuno”, rinunciando all’identità fissa e fondendosi con la natura, trovando pace nel lasciarsi andare al divenire senza il peso dell’io. La modernità modifica l’identità, con l’individuo che si definisce attraverso combinazioni uniche di cerchie sociali, guadagnando libertà ma rischiando isolamento, cercando significato fuori dalla routine. In contrasto, l’emergere delle masse è percepito come una minaccia, descritte come entità irrazionali dove la coscienza individuale si annulla, guidate da impulsi emotivi e istintivi, manipolabili da capi che usano miti e suggestione; i miti sono visti come strumenti potenti per mobilitare l’azione collettiva, contrapponendosi al pensiero critico. Questo contesto di crisi dell’individuo favorisce l’ascesa dei totalitarismi, che mirano a creare un “uomo nuovo” integrato nello Stato, considerato un assoluto etico dove la vera libertà è l’adesione alla volontà collettiva (“In fondo all’Io c’è un Noi”), basandosi sulla fede nel capo e sulla creazione di miti artificiali, assorbendo l’individuo nella totalità organizzata; l’obbedienza di massa non è solo paura, ma sollievo dal peso della responsabilità. Con la caduta dei totalitarismi, l’individuo affronta un difficile apprendistato in società democratiche che, enfatizzando la mediazione, non soddisfano il bisogno di comunità, lasciando isolati. Nonostante l’io sia descritto come debole o illusorio, dipendente da forze anonime come corpo, inconscio o strutture sociali, mantiene una funzione critica e innovativa. Nelle società contemporanee si osserva un diffuso “narcisismo di massa”, dove l’identità è “modulare” o “patchwork”, facilmente assemblabile, un “io mongolfiera” ripiegato su se stesso, insofferente agli impegni, riflettendo il tramonto delle grandi speranze collettive, con l’identità basata sulla presentazione e sul consumo. La coscienza individuale è costantemente influenzata da tecniche di controllo e biotecnologie che modificano la soggettività, rendendo l’identità plasmabile. L’identità personale si forma nell’interazione tra individuo e comunità, Io e Noi, una sintesi di fattori fisici, sociali e storici; la memoria individuale dipende da quadri sociali collettivi, l’io non esiste senza un Noi, e il Noi è composto da molteplici Io. Comprendere l’identità richiede modelli che tengano conto della sua complessità: come sovrapposizione di sé passati, punto di equilibrio mobile, e coesistenza di dimensioni reali e virtuali; l’identità è una costruzione continua, un equilibrio precario tra continuità e discontinuità, tra consapevolezza di sé e forze anonime. La sfida attuale è costruire un’identità forte e libera in un mondo pluralistico e globalizzato, resistendo sia a un Noi oppressivo sia a un Io isolato e frammentato, confrontandosi con la realtà globale e le sofferenze altrui per ampliare la coscienza, agendo autonomamente e introducendo obiettivi etici incondizionati nonostante i condizionamenti.Riassunto Lungo
1. La Fragile Costruzione dell’Io
L’identità personale è un concetto complesso. Secondo Locke, l’identità si fonda sulla consapevolezza di sé che si mantiene nel tempo grazie alla memoria e alla cura del proprio futuro. Mantenere questa consapevolezza richiede uno sforzo costante per non dimenticare idee e ricordi, che altrimenti svaniscono. L’identità di una “persona”, intesa come soggetto cosciente, si distingue da quella del corpo e si basa sulla continuità della coscienza, non sulla sostanza dell’anima. Tuttavia, questa idea incontra delle difficoltà nel dimostrare che l’io sia sempre lo stesso. Questo porta a visioni diverse, come quella di Hume, che vede l’io come un insieme mutevole di percezioni, quasi un teatro di immagini che appaiono e scompaiono, o quella di Kant, che considera l’io trascendentale come qualcosa che esiste ma che non possiamo conoscere veramente.La Volontà come Fondamento dell’Essere
Schopenhauer propone una visione radicalmente diversa. Per lui, la vera essenza di ogni cosa è una volontà impersonale e cieca. L’individuo e la coscienza sono solo manifestazioni superficiali e passeggere di questa volontà universale. L’identità personale non dipende dalla coscienza o dalla memoria, ma dall’identità di questa volontà, che si rende visibile attraverso il corpo. L’intelletto e la coscienza sono visti quasi come un “parassita” del corpo, semplici strumenti che la volontà usa per i propri scopi principali, come sopravvivere e riprodursi. L’idea di essere un individuo separato è un’illusione, da cui ci si può liberare solo rinunciando ai desideri legati alla volontà.La Prospettiva Scientifica di Fine ‘800
Nello stesso periodo, alla fine dell’Ottocento, studi scientifici nel campo della biologia cellulare (citologia) e della psicologia che studia le malattie mentali (psicologia patologica), portano avanti idee simili. Scienziati come Taine, Ribot, Janet e Binet descrivono la personalità non come un’unità solida, ma come un insieme instabile, quasi una “colonia” di diversi elementi psichici. La coscienza che ci appare unita è in realtà una costruzione fragile che richiede molta energia per mantenere l’equilibrio e resistere alle forze che tendono a disgregarla, come le allucinazioni e i deliri. Questi stati, considerati patologici, vengono visti come espressioni di livelli più primitivi e in un certo senso normali della psiche. La capacità di ragionare e percepire correttamente la realtà non è innata, ma è il risultato di un lavoro continuo per controllare e coordinare le immagini mentali. L’io, in questa prospettiva, appare debole, facilmente vulnerabile e potenzialmente diviso, non più padrone di sé. È piuttosto un “ospite” nella propria mente, la cui unità dipende strettamente dal buon funzionamento del corpo.Il capitolo presenta visioni storiche dell’io, ma cosa ci dicono la scienza e la filosofia oggi sull’identità personale?
Il capitolo offre un’interessante panoramica di come l’identità sia stata concepita in passato, passando da prospettive filosofiche a quelle scientifiche di fine Ottocento. Tuttavia, il dibattito sull’io è tutt’altro che concluso e le scoperte più recenti in campi come le neuroscienze e la psicologia cognitiva hanno profondamente modificato la nostra comprensione. Limitarsi a queste visioni storiche rischia di lasciare il lettore con un quadro incompleto e potenzialmente superato. Per colmare questa lacuna e comprendere le sfide attuali, è fondamentale esplorare le ricerche contemporanee. Si consiglia di approfondire la filosofia della mente, le neuroscienze cognitive e la psicologia dell’identità. Autori come Antonio Damasio o Daniel Dennett offrono prospettive moderne che integrano dati scientifici con riflessioni filosofiche, mostrando come l’io sia visto oggi non solo come un problema metafisico o una costruzione fragile, ma anche come un fenomeno emergente dall’attività cerebrale e dalle interazioni sociali.2. L’io, un arcipelago di forze
L’idea tradizionale di un io unico e stabile non regge all’analisi. Già alla fine dell’Ottocento, studi di psicologia e psicopatologia, portati avanti da studiosi come Ribot, Janet e Binet, mostrano che l’io è fatto di tanti elementi diversi, quasi una collezione di “io” più piccoli. L’unità che sentiamo non è qualcosa che abbiamo dalla nascita, ma un equilibrio delicato, una specie di “accordo” in cui un io principale guida gli altri.La molteplicità dell’io e la malattia mentale
Le malattie della mente, come i problemi di personalità, volontà o memoria, non sono la rottura di un’unità che c’era prima, ma dimostrano che l’io è per sua natura molteplice. Quando l’io principale diventa debole, gli altri “io” nascosti possono riemergere, facendo vedere che l’essere frammentati è una possibilità sempre presente. Questa visione si basa sull’idea che la coscienza e la personalità siano legate al corpo e alle sue funzioni, come il “senso del corpo”.La visione di Nietzsche: il corpo come “grande ragione”
Nietzsche approfondisce questa prospettiva. Per lui, il corpo è una “grande ragione” formata da tante forze diverse e “anime”. L’io che siamo consapevoli di avere è solo una semplificazione, un punto di equilibrio che si sposta continuamente tra queste forze in conflitto. La volontà non è una sola capacità, ma un insieme di tanti atti di volontà. La forza di una persona sta nella sua capacità di mettere insieme queste forze, non nel cercare di eliminarle.L’uomo superiore contro l’uomo del gregge
Nietzsche mette a confronto due tipi di persone: l’uomo superiore e l’uomo del gregge. L’uomo superiore sa essere allo stesso tempo “gregge e pastore” di sé stesso. Accetta di essere fatto di tante parti diverse e che ci siano conflitti dentro di sé, perché questo lo aiuta a crescere. L’uomo del gregge, invece, ha paura di essere diverso dagli altri e cerca sicurezza nell’essere uguale a tutti, spinto dal risentimento.L’eterno ritorno come strumento di affermazione
La dottrina dell’eterno ritorno diventa per l’uomo superiore uno strumento potente per dire “sì” alla vita e dare un senso a tutto ciò che accade. Significa accettare e volere che ogni momento si ripeta per sempre. In questo modo, l’uomo superiore trasforma ciò che è stato (“così fu”) in ciò che ha voluto che fosse (“così volli che fosse”). Questo atto di volontà aiuta a dare ordine alla molteplicità dell’io, creando un’identità forte e capace di cambiare, che resiste al declino e all’appiattimento che, secondo Nietzsche, sono favoriti da idee basate sull’uguaglianza come la democrazia e il socialismo.Questa visione dell’io, radicata in studi di fine Ottocento e in una specifica interpretazione di Nietzsche, non rischia di ignorare decenni di scoperte scientifiche e filosofiche sulla mente umana?
Il capitolo, pur attingendo a fonti storiche significative, presenta una visione dell’io che si basa su studi di fine Ottocento e su una specifica lettura filosofica. Questa prospettiva, sebbene affascinante, potrebbe non essere sufficiente a cogliere la complessità del tema alla luce delle scoperte più recenti in ambito scientifico e filosofico. Per approfondire e integrare questa visione, sarebbe utile esplorare i contributi delle neuroscienze cognitive e della filosofia della mente contemporanea. Autori come Antonio Damasio o Thomas Metzinger offrono prospettive moderne sul rapporto tra corpo, coscienza e costruzione del sé che vanno oltre le pur importanti intuizioni storiche citate.3. Il Sé Frammentato e il Flusso della Vita
Sentiamo spesso la coscienza individuale dispersa, proiettata verso l’esterno. Percepire una versione sbiadita del proprio io, modellata dallo spazio e dalla necessità di agire, deriva dalla confusione tra i nostri stati interni fluidi e la stabilità apparente delle cose esterne. Crediamo in un io fisso su cui scorrerebbero gli stati psichici e dividiamo il tempo interiore in parti uguali, come facciamo con il tempo esteriore, trasformando così la coscienza in un oggetto.La vera natura della coscienza: la durata
La vera dimensione della coscienza è la durata, un cambiamento continuo, qualitativo e imprevedibile. La personalità si costruisce attraverso scelte che implicano l’abbandono di altre possibilità, una crescita che non aggiunge pezzi, ma si ramifica. Il passato non scompare del tutto; parti di noi stessi che abbiamo lasciato indietro possono riemergere.Ritrovare gli io passati: la memoria involontaria
Per recuperare questi diversi io passati, esiste la memoria involontaria. Questa riporta alla luce momenti dimenticati, spesso grazie a sensazioni inattese, come il sapore di un dolce o la vista di un oggetto. Questi ricordi non sono semplici copie del passato, ma risvegliano gli io di allora che si uniscono all’io di oggi, creando una sensazione di felicità e di essere fuori dal tempo lineare. Questa esperienza rivela un’essenza più profonda, un “vero io” nascosto sotto le diverse personalità che abbiamo assunto. L’arte può aiutarci a comprendere queste impressioni, viste come segni o simboli che nascondono verità interiori.L’identità imposta dalla società
La società richiede un’identità stabile, legata a un nome e a un ruolo, per garantire responsabilità e coerenza. Questa costruzione dell’io sociale è un “artificio” spontaneo, ma fragile e non sempre corrispondente alla realtà. La vita è un flusso caotico che può travolgere queste forme costruite. Di fronte a questa frammentazione, si può reagire in modi diversi: adattandosi alle aspettative sociali, creando realtà alternative con l’immaginazione (come la geografia), o cercando di sciogliere completamente l’io.La scelta di essere ‘nessuno’
Decidere di diventare “nessuno” significa rinunciare all’identità fissa e alle immagini che gli altri hanno di noi. Questo porta a una forma di depersonalizzazione, un abbandono dell’idea di essere un individuo separato. Si può cercare rifugio nella fusione con la natura, nel lasciarsi andare al divenire senza la fatica di costruire un sé coerente. La vita appare come un flusso continuo, un nascere e morire istante per istante, dove si può trovare pace rinunciando alla coscienza e alla memoria, osservando il mondo che si manifesta senza il peso di avere un io.Come può l'”io mongolfiera”, descritto come ripiegato su sé stesso e insofferente ai legami, esistere se il capitolo afferma che l’identità si forma sempre e solo nella dinamica tra “Io” e “Noi”?
Il capitolo descrive un tipo di identità moderna, l'”io mongolfiera”, che sembra contraddire la premessa fondamentale che l’identità si costruisce nell’interazione con il gruppo. Questa apparente discrasia meriterebbe maggiore chiarezza: l'”io mongolfiera” è una patologia dell’identità, un fallimento della relazione “Io/Noi”, o una sua nuova, e forse impoverita, manifestazione? Per esplorare questa complessità, è consigliabile approfondire gli studi sulla sociologia dell’identità e sulla psicologia sociale, leggendo autori che hanno analizzato le trasformazioni del legame sociale nell’epoca contemporanea.6. L’individuo tra folla e frammentazione
La mente della folla alla fine dell’Ottocento
Alla fine dell’Ottocento, si iniziò a studiare come funziona la mente delle persone quando sono in gruppo, nella folla. Pensatori come Gustave Le Bon notarono che l’individuo, una volta immerso nella folla, tende a perdere la capacità di pensare con la propria testa. Diventa facilmente influenzabile e agisce più d’istinto, guidato da emozioni che si diffondono rapidamente per imitazione tra le persone. Queste idee furono lette anche da figure politiche come Mussolini e Hitler. Si capì che le masse potevano essere guidate da leader capaci di capire e usare queste dinamiche emotive. Georges Sorel, un altro pensatore, sottolineò la grande forza dei miti: non sono verità basate sulla logica, ma immagini o storie così potenti da spingere intere collettività ad agire, spesso andando contro il ragionamento critico.Come i totalitarismi hanno usato queste idee
Questa sensazione che l’individuo fosse in crisi e che la società stesse andando in declino creò il terreno fertile per la nascita dei regimi totalitari. Movimenti come il fascismo, guidati da figure come Mussolini e il filosofo Gentile, volevano che ogni persona diventasse un “io totale”, completamente fuso con lo Stato. Lo Stato era visto come l’unica cosa che contava, un valore assoluto. Questi regimi imponevano una struttura rigida con qualcuno al comando (una gerarchia) e dicevano che era giusto sacrificare la propria vita o i propri desideri per il bene del gruppo o della nazione. Il loro potere si basava sul fatto che la gente credesse ciecamente nel leader e nelle storie o nei simboli creati apposta dal regime (miti artificiali). In questi sistemi, la singola persona non aveva valore in sé, ma era sacrificabile per quello che veniva considerato il bene superiore, cioè il bene del tutto.L’individuo oggi: frammentato ma alla ricerca di sé
Oggi, il modo in cui capiamo chi siamo, la nostra identità personale, viene spesso descritto come qualcosa che cambia continuamente e fatto di tanti pezzi diversi, come una coperta fatta di ritagli (“patchwork”), senza un centro solido. Questo succede anche perché abbiamo perso i vecchi punti fermi che c’erano una volta, come la famiglia tradizionale, la religione o la comunità stretta. Questa mancanza di punti di riferimento può portare a problemi come l’eccessivo amore per sé stessi (narcisismo) o la sensazione di essere staccati dalla realtà (disturbi dissociativi). Anche se le forze del gruppo e della società ci influenzano molto e rendere difficile capire bene chi siamo, c’è sempre dentro di noi una lotta. Da un lato sentiamo il forte bisogno di sentirsi parte di un gruppo, di appartenere a qualcosa. Dall’altro, cerchiamo sempre di essere liberi di pensare con la nostra testa e di decidere da soli, di mantenere la nostra autonomia e la nostra capacità di giudizio individuale.Ma davvero la nascita dei totalitarismi si spiega solo con la “mente della folla” e la “crisi dell’individuo”, ignorando il peso di guerre, crisi economiche e fallimenti politici?
Il capitolo lega strettamente le teorie sulla psicologia delle masse e la percezione di una crisi individuale all’ascesa dei regimi totalitari. Tuttavia, questa prospettiva rischia di trascurare il complesso intreccio di fattori storici, economici e politici che hanno creato il terreno fertile per tali fenomeni nel XX secolo. Per comprendere appieno le origini dei totalitarismi, è fondamentale integrare l’analisi psicologica con lo studio approfondito della storia del periodo tra le due guerre mondiali, delle dinamiche socio-economiche e delle specifiche crisi politiche che hanno afflitto l’Europa. Approfondire autori come Hannah Arendt o studiare la storia economica e politica del primo Novecento può offrire una visione più completa e sfaccettata.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]