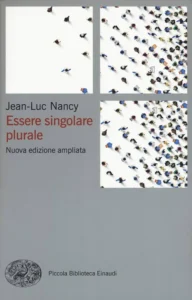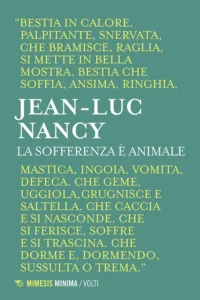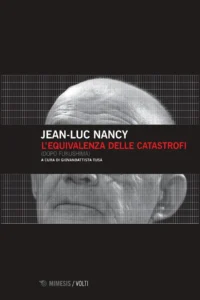Contenuti del libro
Informazioni
“Decostruzione del cristianesimo. L’adorazione” di Jean-Luc Nancy è un libro che ti prende e ti fa vedere il mondo e il pensiero in modo diverso. Non è una storia con personaggi o luoghi precisi, ma un’esplorazione filosofica profonda. Il tema centrale è l’esistenza stessa, vista come un dono fortuito, senza un motivo o un creatore definito. Il senso non è qualcosa di nascosto, ma si crea nei rapporti tra tutte le cose, un gioco infinito di rinvii. Di fronte a questa fortuità e a questa apertura del mondo, Nancy propone l’adorazione non come preghiera a un dio, ma come un saluto, un riconoscimento fiero e umile di essere qui, un’attenzione al senso che si manifesta nel rapporto. Il libro analizza come il cristianesimo ha plasmato il pensiero occidentale, anche quello ateo o basato sulla ragione, e come i suoi concetti chiave, come l’idea di Dio come rapporto (la Trinità) o l’Incarnazione, possano essere ripensati in questa prospettiva di decostruzione. I “protagonisti” sono concetti come l’esistenza, il senso, l’adorazione, il rapporto, e le virtù teologali viste come forze che ci spingono verso l’infinito. I “luoghi” sono più che altro spazi concettuali: il mondo come apertura, lo spazio del rapporto tra gli esseri, e la storia del pensiero occidentale influenzato dal cristianesimo. È un testo che ti invita a pensare al mistero e alla sospensione della credenza come modi per accedere a una verità che non si può afferrare del tutto, ma che si manifesta continuamente.Riassunto Breve
L’esistenza del mondo non dipende da una necessità, ma è un evento fortuito, un incontro casuale e passeggero, come una rottura improvvisa del nulla che crea un’apertura. Le cose esistono senza una ragione precisa, tenute insieme solo dal vuoto. Il senso non è qualcosa di esterno o un fine ultimo, ma nasce dalla rete infinita di legami e rinvii tra tutto ciò che esiste. Il mondo è questa totalità di rinvii, e non rimanda a nient’altro. Questa mancanza di un senso finale non è un difetto, ma permette il gioco continuo delle relazioni tra le cose. Adorare è una risposta a questo senso infinito. Non è una teoria, ma un modo di essere, un movimento del corpo e del pensiero che si apre all’infinito del senso, all’eccedenza del mondo che è un dono senza chi lo dona. Adorare significa stare in rapporto con questo “niente” che è l’origine senza ragione, mantenendo un atteggiamento umile. È anche una forma di saluto, un riconoscere l’esistenza degli altri e del mondo, senza cercare salvezza o ridurre tutto a scopi pratici. È un’attenzione al movimento del senso, un’apertura verso il mondo che è qui, completamente aperto, straordinario nella sua normalità. La sua casualità e la mancanza di un fine non sono limiti, ma un’eccedenza che va oltre ogni aspettativa. La civiltà attuale, nata in gran parte dal cristianesimo, ha cercato stabilità. Il cristianesimo ha visto la morte come parte della vita, aprendo all’immortalità *dentro* l’esistenza. L’idea di essere nel mondo ma non *del* mondo crea una faglia, un’apertura nel mondo stesso. Il senso si manifesta qui, anche se viene da “fuori”. Questo porta il cristianesimo a trasformarsi, diventando base per un mondo senza Dio. L’ateismo qui non nega Dio semplicemente, ma capisce che il “Dio” cristiano, inteso come rapporto, tende a svuotare il posto del fondamento ultimo. Anche la ragione moderna, cercando di sostituire Dio, si trova senza un fondamento certo. È importante riconoscere e lasciare vuoto questo posto. La civiltà di oggi, basata su scienza e legge, sembra chiusa, ma ha una spinta interna verso l’aperto. L’apertura non è un luogo fuori, ma una dimensione del mondo, dove il senso non si può misurare. È un “noi tra noi”, dove “noi” include tutto. La ragione si apre quando si ripensa il cristianesimo, accettando l’inspiegabile e il caso. Il male è rifiutare questa casualità. L’esistenza è un segno casuale del rapporto tra tutti. Il senso è una rivelazione continua, un lampo. Il mistero è questa evidenza, il lampo che mostra il mondo e i rapporti. Le virtù come fede, speranza, amore non sono regole morali, ma forze, slanci verso l’infinito. L’essere è impulso, movimento. I misteri cristiani mostrano Dio come rapporto, il senso nel corpo, la salvezza nel rapporto. Il peccato è rifiutare il rapporto. L’amore dà valore infinito a ogni esistenza. La fede è fiducia nell’ignoto. La speranza è attesa di ciò che deve ancora venire nel presente. Adorare è la gioia di esistere, un saluto alla casualità dell’esistenza. Distruggere l’illusione di un Dio esterno porta a non sapere cosa c’è al suo posto. Adorare accoglie questa ignoranza: non c’è un “posto di Dio”, il fuori si apre nel mondo. Si è spinti a dare valore infinito all’esistenza, un valore che appare nel rapporto tra tutti. Adorare è uno slancio libero, un canto che va oltre le parole, salutando l’esistenza che arriva tremando. Adorare non è stare fermi o sottomessi, ma un movimento continuo, una tensione verso l’infinito che non si ferma in una soddisfazione (che porta all’idolatria), ma rilancia sempre. È un atto fiero. Questa tensione si lega al linguaggio. Adorare va oltre il silenzio tornando alle parole, non per nominare un dio lontano, ma per avvicinarsi a ciò che nel linguaggio apre il senso senza dirlo. Il linguaggio viene da un “fuori” e si rivolge a esso, aprendo mondo e uomo. Gli “dei” sono linguaggio, nomi, appelli. Adorare crea il suo “oggetto” mettendo in rapporto le esistenze con il “niente” da cui vengono, creando il mondo come rete di rapporti. Esistere è esporsi attraverso il rapporto. Non c’è un “essere” fisso, ma un insieme di atti che formano i rapporti. Adorare è scegliere di esistere, rivolgendosi a questo “niente” che è l’infinito presente, un fuori assoluto. La vera intimità è sempre con un altro, un rapporto che tocca il limite e porta fuori di sé, verso un altrove assoluto. Questo toccare è “spirituale”. Adorare è l’intimità di questo trasporto. Il soggetto non è chiuso in sé, ma è esso stesso rapporto, un’unità che si muove nella sua diversità. Adorare è un’esclamazione, un saluto all’incommensurabile che non indica un essere, ma il saluto stesso. È passione per l’esistenza che è tante cose diverse eppure unica. Adorare si rivolge alla distanza che rende possibile ogni vicinanza. È un rapporto con qualcosa che non esiste come oggetto da raggiungere, ma crea un’apertura, un passaggio. Questo include accettare la fragilità e la morte. La fede, diversa dalla semplice credenza, è fiducia in ciò che va oltre la ragione e la rappresentazione, come la morte. Anche se l'”io” scompare nella morte, i rapporti non muoiono. La sensibilità può sentire la continuazione dei rapporti con i morti, un incontro in un luogo inatteso. L’uomo è la somma dei suoi rapporti, e il pensiero si apre all’incommensurabile, all’innominabile, che è la spinta stessa dell’esistenza. Esiste una condizione tra fede, sapere e credenza, sospesa e incerta, ma reale. È un “credere senza credere”, un legarsi a un “come se”. Si sa che un altro mondo non c’è, ma si sceglie di credere o si lascia spazio a qualcosa di non impossibile, un modo nuovo di dare senso, o forse solo il desiderio di credere. Questa non è una credenza debole, ma una forza che non si basa su una finta conoscenza. Apre alla possibilità di relazionarsi con ciò che sembra impossibile. Questo modo di essere si vede leggendo storie. Si crede a una storia pur sapendo che non è vera o credibile. Questo succede perché si accetta l’invito della finzione, che chiede di mostrare una verità che non si può mostrare direttamente. Nella finzione, la verità si mostra proprio perché non si può rappresentare. L’infinito trova un limite, appare nel finito. Quando l’Adorazione scompare, resta la sua promessa di lasciare le vecchie superstizioni. Si dice che l’epoca attuale sia fallita. Nessuna figura scenderà dal cielo per salvare. Questo è già successo perché questa figura esiste ed è amata.Riassunto Lungo
1. Il Dono Fortuito del Mondo
Il mondo esiste non per una ragione necessaria, ma per puro caso. Questo non significa che sia insignificante, ma che la sua presenza è un evento improvviso e passeggero, un incontro fortunato che appare e poi scompare. Le vite si trovano nel mondo senza un motivo stabilito, legate tra loro solo dallo spazio vuoto che le circonda.Il Senso come Rete di Legami
Il significato delle cose si manifesta come una rete di collegamenti tra tutto ciò che esiste. Un “mondo” è l’insieme di questi collegamenti, ma il mondo in sé non rimanda a nient’altro. Non c’è un significato ultimo e definitivo. Questa mancanza di un fine ultimo non è un difetto, ma piuttosto l’affermazione di un gioco infinito di rimandi tra le cose.L’Adorazione come Risposta all’Esistenza
Una possibile risposta a questo infinito gioco di significati è l’adorazione. Non è una teoria astratta, ma un’azione concreta legata al pensiero. Pensare è un movimento che ci apre all’infinito dei significati, esponendoci all’enorme ricchezza dell’esistenza. Questa ricchezza è il mondo stesso, un dono che non ha un donatore, un evento simile a una rottura casuale nel nulla, un’apertura. Adorare significa mantenere un legame con questo “niente” che è all’origine dell’apertura, mantenendo un atteggiamento di umiltà.L’Adorazione come Saluto e Attenzione
Adorare è anche un modo di rivolgersi all’altro e al mondo, un saluto che ne riconosce l’esistenza, senza cercare una salvezza o ridurre tutto a scopi pratici. È un’attenzione costante al modo in cui il senso si muove, un’apertura completa al mondo che è qui, presente e accessibile. La sua natura casuale e la mancanza di uno scopo prefissato non indicano una mancanza, ma piuttosto una ricchezza che va oltre ogni aspettativa.Perché l’adorazione, tradizionalmente legata a un fine ultimo o a un donatore, è presentata come la risposta adeguata a un’esistenza casuale e senza scopo?
Il capitolo propone l’adorazione come risposta privilegiata all’esistenza casuale e priva di scopo, ridefinendo il termine in modo non convenzionale. Questa scelta argomentativa solleva interrogativi sulla sua giustificazione e sulla sua relazione con le concezioni più comuni di adorazione. Per approfondire le possibili risposte filosofiche all’assenza di un fine ultimo e comprendere meglio il contesto di tale proposta, è utile esplorare la filosofia esistenzialista e autori come Sartre o Camus, o la fenomenologia con autori come Heidegger, che affrontano temi legati al senso e all’esistenza nel mondo.2. L’apertura del senso nel mondo
La civiltà che oggi chiamiamo globale, un tempo detta occidentale, si è costruita in gran parte sul cristianesimo. Questo non è stato solo un sistema di fede, ma un elemento che ha plasmato il diritto, le città e il pensiero razionale. Ha cercato di offrire stabilità e senso dopo che la certezza nella presenza degli dei era venuta meno. Mentre le culture antiche vedevano la morte come una fine definitiva o un passaggio a un’altra dimensione, il cristianesimo ha proposto la morte come una verità fondamentale della vita stessa. Ha aperto la possibilità dell’immortalità non come un prolungamento, ma come un modo di vivere nel tempo che è già fuori dal tempo.L’essere nel mondo e il senso
Questa idea di esistere nel mondo pur non appartenendo completamente ad esso è un punto cruciale. Non si tratta di credere in un altro mondo separato dalla realtà presente, ma di riconoscere un’apertura, una sorta di frattura o faglia all’interno del mondo stesso. Il senso profondo delle cose non ha la sua origine dentro il mondo, ma si rende visibile e si manifesta proprio qui, nel mezzo della nostra esistenza. Questo dinamismo interno porta il cristianesimo verso una sorta di auto-superamento e verso la secolarizzazione, gettando le basi per un mondo che, apparentemente, può fare a meno di Dio. L’ateismo, in questa prospettiva, non è una semplice negazione, ma la comprensione che l’essenza stessa del “Dio” cristiano tende a dissolvere la sua posizione esterna o superiore.Un Dio “con” e il fondamento assente
Il Dio di cui si parla non è un essere posto fuori o sopra il mondo, ma è il legame, il “con” che unisce ogni cosa. La nozione di Trinità, ad esempio, cerca di esprimere proprio questa natura profondamente relazionale del divino. In questa visione, il mondo non poggia su un fondamento esterno preesistente, ma emerge dal nulla, come un dono senza un donatore identificabile. La Ragione moderna ha spesso cercato di occupare il posto lasciato vuoto, proponendosi come nuovo principio fondante. Tuttavia, anche questa Ragione, intesa come causa ultima e certa, si rivela priva di un appoggio sicuro. Il punto cruciale diventa allora riconoscere e mantenere consapevolmente vuoto questo spazio del fondamento ultimo.La distinzione tra regni e le sue tensioni
Il monoteismo, in generale, ha introdotto una netta separazione tra la sfera terrena e quella divina. Nel contesto cristiano, questo ha generato una tensione storica complessa tra l’autorità della Chiesa e i poteri politici mondani, una dinamica che ha segnato profondamente la storia occidentale. Questa distinzione ha anche contribuito a un rapporto difficile con il popolo ebrao, talvolta visto come custode di quella separazione dei regni che il cristianesimo stesso ha cercato di superare o negare. L’islam, d’altro canto, ha affrontato e gestito il rapporto tra la sfera religiosa e quella profana in modi differenti rispetto al cristianesimo, mostrando un modello alternativo di organizzazione sociale e spirituale.L’apertura nella civiltà attuale
La civiltà in cui viviamo oggi, pur basata su pilastri come la razionalità scientifica e il diritto, sembra a tratti ripiegata su sé stessa, chiusa nei propri confini. Eppure, al suo interno, esiste una spinta profonda verso l’aperto, una dimensione che non è un luogo esterno da raggiungere. Questa apertura è piuttosto una qualità intrinseca del mondo stesso, un punto di incontro tra la dimensione verticale del senso e quella orizzontale dell’esistenza quotidiana. È qui che il senso si manifesta, irriducibile a qualsiasi tentativo di misurarlo o definirlo completamente. È come un “uno” che accoglie il molteplice senza cercare di uniformarlo, simile alla singolarità unica di ogni singola esistenza. Il pensiero di un “Dio” che è primariamente “con” si trasforma nel riconoscimento fondamentale di un “noi tra noi”, dove il termine “noi” abbraccia e include tutti gli enti che esistono. La rivelazione, in questa luce, non è una dottrina rigida da accettare, ma un appello costante che attende una risposta da parte nostra. L’arte e la letteratura, con le loro forme espressive, sono modi potenti per manifestare questo “con”, creando nuovo senso attraverso l’interruzione dei vecchi schemi e miti.È plausibile sostenere che l’ateismo sia una naturale evoluzione interna del cristianesimo?
Il capitolo presenta questa tesi come una comprensione quasi necessaria dell’essenza divina. Tuttavia, questa è una specifica interpretazione teologica e filosofica, non universalmente accettata, che rischia di semplificare eccessivamente le complesse cause storiche, sociali e intellettuali della secolarizzazione e dell’ateismo. Per approfondire le molteplici prospettive su questo tema, è utile esplorare la sociologia della religione e la filosofia della religione. Autori come Charles Taylor o i dibattiti sulla “morte di Dio” possono offrire contesti differenti.3. La forza del rapporto e il mistero del senso
Ripensare il cristianesimo, liberandolo da regole e credenze rigide, apre la strada a una nuova comprensione. Questa apertura non cerca risposte finali, ma accetta che la ricerca del senso è infinita e si confronta con ciò che non si può spiegare o che accade per caso. Il male, in questa visione, nasce dal rifiuto di questa casualità, dal tentativo di imporre un ordine prestabilito. L’esistenza stessa è vista come un segno fortuito, un incontro casuale tra tutti gli esseri che insieme danno forma al mondo. Questo senso non è nascosto da qualche parte in attesa di essere scoperto, ma è una rivelazione continua, un’illuminazione improvvisa che mostra ciò che è già qui, presente nel mondo.Non È Secolarizzazione
È importante distinguere questa apertura dalla secolarizzazione. La secolarizzazione spesso sposta idee religiose in contesti non religiosi, ma a volte ne perde il significato più profondo. Qui non si tratta di adattare concetti, ma di accogliere una spinta fondamentale dell’esperienza umana: quella tipica dell’uomo moderno che non accetta nulla come ovvio o garantito. Questa spinta è una ricerca autentica, un desiderio di comprendere che non si accontenta di risposte predefinite. È un movimento interiore che porta l’individuo a esplorare il mondo e la propria esistenza con occhi sempre nuovi.
I Grandi Temi Cristiani Ripensati
Anche i concetti centrali del cristianesimo, come la Trinità, l’Incarnazione e la Resurrezione, vengono ripensati. La Trinità non descrive un essere solitario, ma un ‘Dio’ inteso come puro rapporto, come relazione. L’Incarnazione e la Resurrezione suggeriscono che il senso non arriva da un luogo esterno, ma si manifesta qui, nel corpo, nella vita concreta e mortale. Il corpo diventa il luogo in cui lo spirito si manifesta. La salvezza, quindi, non consiste nel fuggire dal mondo, ma si trova proprio dentro le relazioni che si creano. È un riconoscere la responsabilità di dare senso, un ‘saluto’ all’esistenza. Il peccato, in quest’ottica, non è una colpa da espiare, ma il rifiuto di entrare in questo rapporto, una chiusura di fronte alla necessità di creare attivamente il senso. Il perdono, a sua volta, serve a mantenere viva questa possibilità di dare e trovare senso.
La Finzione come Esempio La Scomparsa dell’Adorazione Affermare che ciò che chiamiamo “dei” sia in realtà il linguaggio stesso non è una mossa retorica che elude la questione fondamentale dell’oggetto dell’adorazione?
Il capitolo propone una definizione radicale di “dei” come linguaggio. Questa mossa, sebbene suggestiva, non è adeguatamente argomentata e rischia di rendere vaga la natura dell’oggetto dell’adorazione, che il testo lega all’infinito e a un “niente” assoluto. Si crea una potenziale lacuna logica nel definire l’oggetto di un atto così centrale come l’adorazione. Per approfondire questa tematica e confrontarsi con la definizione proposta, sarebbe utile esplorare la filosofia del linguaggio (ad esempio, autori come Ludwig Wittgenstein o Martin Heidegger), la filosofia della religione (confrontandosi con pensatori come Søren Kierkegaard o Emmanuel Levinas) e la metafisica, in particolare le riflessioni sul concetto di “niente” e infinito. 5. La Sospensione della Credenza
C’è un modo di sentire che si trova a metà tra la fede, il sapere e la credenza. È una condizione sospesa e incerta, ma è un modo autentico di sentire le cose. Si può descrivere come un ‘credere senza credere’ o come una negazione che si lega a un ‘come se’. Anche sapendo che un altro mondo non esiste, si può scegliere di credere o di lasciare aperta la possibilità che qualcosa di non impossibile esista. È un modo per dare un senso nuovo alle cose, o forse semplicemente per seguire il desiderio di credere e permettere di entrare in relazione con ciò che a prima vista sembra impossibile. Questa condizione non è segno di una credenza debole; al contrario, è una forza che non ha bisogno di basarsi su una finta conoscenza per esistere.Su quali basi il capitolo afferma che l’atto di salvezza è già compiuto da una figura che esiste ed è oggetto di amore, e come si lega questo alla “sospensione della credenza”?
Il capitolo introduce un’affermazione teologica molto specifica riguardo a una figura salvifica già esistente e all’atto di redenzione già compiuto, senza fornire un chiaro nesso logico o argomentativo che la colleghi alla precedente discussione sulla “sospensione della credenza” nella finzione. Questo salto concettuale lascia una lacuna significativa. Per comprendere meglio le possibili basi di tale affermazione e il suo rapporto con i diversi modi di “sentire” o “credere”, sarebbe utile esplorare testi di filosofia della religione, teologia e studi sul rapporto tra fede, dubbio e narrazione. Autori come Søren Kierkegaard o pensatori contemporanei che affrontano il tema della credenza e della sua sospensione in contesti non strettamente razionali potrebbero offrire spunti per colmare questa lacuna argomentativa.
Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]