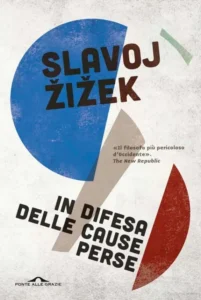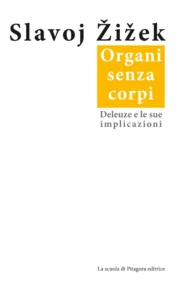1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Dalla tragedia alla farsa. Ideologia della crisi e superamento del capitalismo” di Slavoj Žižek ti sbatte in faccia la realtà post-crisi finanziaria 2008, dicendo chiaro e tondo che il liberismo è morto, non una ma due volte, e che il modo in cui hanno salvato le banche, non la gente, è un fallimento morale pazzesco. Žižek scava nell’ideologia che ci fa credere che il capitalismo sia naturale e che il mercato sia libero, quando in realtà è tutto deciso dalla politica e i profitti sono privati ma le perdite, come quelle della crisi, vengono socializzate, una specie di “socialismo per i ricchi”. Il libro non si ferma qui, analizza come la paura del “Prossimo”, tipo gli immigrati, venga usata politicamente e come il liberalismo stesso, pur parlando di libertà, generi reazioni fondamentaliste. Ma il punto forte, secondo me, è quando dice che risorse essenziali come cibo, acqua o l’ambiente non possono essere trattate come semplici merci e che la vera lotta oggi è contro la privatizzazione di ciò che è “comune” e l’esclusione sociale che ne deriva, creando una nuova forma di proletariato. Žižek propone un’ipotesi comunista diversa dal passato, basata proprio su chi è escluso, perché il capitalismo di oggi si rivoluziona continuamente e non basta aspettare che cada da solo; serve un atto di volontà per cambiare rotta. È un libro che ti fa pensare a fondo sul nostro sistema e su dove stiamo andando.Riassunto Breve
La crisi finanziaria recente e altri eventi mostrano la fine del liberismo come idea politica ed economica. Dopo la crisi, i governi hanno aiutato le banche con molti soldi, ma non hanno fatto lo stesso per la povertà o i problemi ambientali. Questo evidenzia un fallimento morale del sistema. La crisi del 2008 non era inattesa; molti avevano avvertito dei rischi legati alla speculazione. Il mercato si basa sulla fiducia, non solo su fatti oggettivi, e i salvataggi bancari, anche se costosi, cercano di ripristinare questa fiducia. Questi salvataggi favoriscono i ricchi e i creditori, non i poveri o i debitori, mostrando che nel capitalismo i profitti sono privati ma le perdite possono diventare pubbliche. L’idea che aiutare la finanza aiuti l’economia reale è una giustificazione per salvare i grandi attori. Non esiste un mercato libero in senso assoluto; le sue regole sono sempre decise dalla politica. Le crisi economiche vengono usate per imporre riforme difficili, come indebolire i sindacati, presentandole come necessarie. L’ideologia capitalista si presenta come naturale ed efficiente, nascondendo le sue contraddizioni e la spinta alla crescita che confonde investimenti e speculazione. Dare la colpa a singole persone o errori serve a proteggere il sistema. L’ideologia oggi usa anche l’umanizzazione per distogliere l’attenzione dalle responsabilità sistemiche. La paura verso categorie di persone considerate “nocive”, come gli immigrati, porta a misure restrittive e a un tipo di razzismo giustificato come ragionevole. Figure politiche a volte uniscono un approccio liberale permissivo con il populismo. Il capitalismo attuale integra critiche passate, promuovendo autonomia e esperienza nel consumo. L’ideologia funziona come feticismo, nascondendo verità scomode, e si divide tra un atteggiamento cinico e uno populista. Il liberalismo, pur parlando di libertà, è debole e genera il fondamentalismo come reazione; il loro conflitto è un falso problema che nasconde questioni più profonde. Le crisi mostrano che il liberalismo, presentandosi come realismo, richiede violenza per proteggere il capitale a scapito delle vite umane. Serve una sinistra radicale per affrontare le crisi e salvare i valori liberali. Il Capitale ha un potere enorme, visibile nella risposta alla crisi finanziaria. Il denaro è una forza centrale. Le politiche di aggiustamento imposte da organizzazioni internazionali, come i tagli alla spesa pubblica, hanno effetti negativi sulla salute e la vita delle persone nei paesi che ricevono prestiti. La crisi alimentare globale non dipende solo da problemi interni ai paesi poveri, ma anche dalle politiche occidentali che li spingono a eliminare i sussidi agricoli e a concentrarsi sulle esportazioni, rendendoli dipendenti dalle importazioni di cibo. Questo porta all’acquisto di terre agricole da parte di grandi aziende per produrre per l’estero, rafforzando la dipendenza. La possibile scarsità di risorse fondamentali come cibo, acqua ed energia diventa un fattore importante nella politica globale. Queste risorse e servizi essenziali non possono essere trattati solo come merci e le decisioni su di essi non possono essere lasciate solo al mercato. Dopo i fallimenti dei modelli socialisti del Novecento, serve un nuovo inizio per l’idea comunista. Questa idea non è un sogno, ma una risposta ai problemi del capitalismo globale. Ci sono quattro problemi principali: la crisi ecologica, i problemi legati alla proprietà intellettuale, gli sviluppi nella biogenetica e le nuove forme di esclusione sociale. I primi tre riguardano la privatizzazione di ciò che è comune, la base condivisa della vita. Questa privatizzazione porta a escludere le persone da questa base. Il problema più importante è quello tra chi è incluso e chi è escluso dal sistema. Senza affrontare questo, gli altri problemi restano gestibili dal capitalismo. Oggi, chiunque rischi di perdere la propria base o sia escluso fa parte di questa situazione. Non si tratta di inserire gli esclusi nel sistema, ma di farli diventare la base per cambiare l’organizzazione politica. Il comunismo si distingue dal socialismo, che può stabilizzare il capitalismo senza risolvere l’esclusione fondamentale. Il comunismo si basa sull’idea universale che si trova in chi è escluso. Eventi storici mostrano come gli esclusi possano rappresentare gli ideali universali in modo più radicale di chi li ha pensati, rivelando i limiti delle idee dominanti. La lotta non cerca solo un’identità separata, ma vuole ridefinire le idee esistenti eliminando le loro esclusioni nascoste. Il capitalismo attuale è una sfida nuova per chi cerca un cambiamento. Si basa su un cambiamento continuo e si rinnova da solo. Questo rende difficile attaccare il sistema dall’esterno, perché il sistema stesso assorbe ciò che lo sfida. La democrazia parlamentare viene vista come qualcosa che rende le persone passive. Non dà potere reale, ma un ruolo formale, lasciando il potere allo Stato. La sua forma stessa implica un accordo con il capitalismo. Questo si vede quando il sistema democratico non riesce a esprimere la volontà popolare nei momenti di crisi. Il capitalismo oggi tende sempre più verso forme autoritarie, rompendo il legame storico con la democrazia. Un aspetto chiave è il passaggio dal profitto basato sullo sfruttamento del lavoro alla rendita, che deriva dalla privatizzazione della conoscenza collettiva e delle risorse naturali. Questo richiede un’autorità diretta per imporre le leggi che permettono di ottenere questa rendita, rafforzando lo Stato. La classe lavoratrice appare divisa, e l’unione delle sue parti è vista come necessaria per un cambiamento. Di fronte a questa situazione, aspettare che la storia o una necessità portino al cambiamento non funziona più. La direzione attuale della storia sembra portare alla catastrofe. L’unica via è un atto di pura volontà, una decisione di agire contro questa tendenza. Questo significa agire senza avere una conoscenza completa, ma con una sorta di fiducia nella possibilità di cambiare il destino. Non si aspetta un salvatore o un movimento predestinato, ma si riconosce che l’azione deve iniziare da chi sta aspettando.Riassunto Lungo
1. La Fine del Liberismo e una Nuova Idea
Dopo la crisi finanziaria, i governi hanno deciso di aiutare le banche con grandi somme di denaro per stabilizzare il sistema, ma non hanno trovato risorse simili per affrontare problemi urgenti come la povertà o le questioni ecologiche. Questa scelta mette in luce un fallimento morale della modernità. Due eventi recenti, l’attacco dell’11 settembre 2001 e la crisi finanziaria globale, segnano insieme la fine del liberismo. Se il primo evento è stato percepito come una tragedia, il secondo è visto quasi come una farsa, rivelando un problema profondo e interno all’ideologia liberista che ha contribuito a causare la crisi stessa. Per poter affrontare efficacemente i problemi del capitalismo globale, è indispensabile capire perché i tentativi fatti dalla sinistra nel Novecento non hanno avuto successo. Imparare da questi fallimenti passati è fondamentale per poter costruire una nuova proposta che miri alla liberazione dell’umanità, una proposta che qui viene chiamata comunista, ma con un significato particolare.Se il problema identificato nel capitolo è il fallimento del liberismo, perché la soluzione passa necessariamente per l’analisi dei fallimenti della sinistra del Novecento?
Il capitolo stabilisce un collegamento diretto tra la crisi del liberismo e la necessità di comprendere gli insuccessi dei tentativi della sinistra nel secolo scorso per costruire una “nuova idea”. Tuttavia, questa connessione cruciale non viene adeguatamente argomentata. Non è chiaro quali specifici fallimenti della sinistra siano rilevanti per affrontare le sfide attuali del capitalismo globale (crisi finanziarie, povertà, ecologia) e come l’analisi di tali insuccessi informi concretamente la proposta futura, specialmente considerando la sua etichetta controversa. Per rendere l’argomentazione più solida, sarebbe fondamentale esplorare in dettaglio le dinamiche storiche e teoriche che legano le critiche al liberismo contemporaneo alle lezioni (positive o negative) tratte dalle esperienze socialiste, comuniste e socialdemocratiche del XX secolo. Approfondire la storia del pensiero politico ed economico del Novecento, magari leggendo autori come Eric Hobsbawm o Slavoj Žižek, potrebbe aiutare a chiarire questo nesso logico e a fornire il contesto mancante.2. La Crisi Rivelatrice dell’Ideologia
La crisi finanziaria del 2008 non è arrivata all’improvviso. Molti avevano lanciato allarmi sui rischi della speculazione e sulla creazione di denaro virtuale, ma queste preoccupazioni non sono state ascoltate. Il modo in cui funzionano i mercati dipende molto dalla fiducia che gli operatori hanno l’uno nell’altro, non solo da calcoli precisi. Per questo, azioni come i piani di salvataggio possono funzionare se riescono a far tornare la fiducia, anche se dal punto di vista economico possono sembrare scelte discutibili.I Piani di Salvataggio e il Rischio Morale
I piani per salvare le grandi banche e istituzioni finanziarie si comportano un po’ come una forma di “socialismo”, ma che avvantaggia chi è già ricco e chi presta denaro, non chi è povero o ha debiti. Questo mette in luce un problema tipico del capitalismo: i guadagni restano privati, ma le perdite vengono fatte pagare a tutta la società. L’idea che l’economia reale, quella di tutti i giorni, dipenda dalla salute del mondo della finanza viene usata per giustificare perché è necessario salvare i grandi gruppi finanziari. Nel sistema capitalista, la circolazione del denaro e degli investimenti è fondamentale, non solo la produzione di beni concreti.Il Mercato non è Libero
Non esiste un vero mercato completamente libero da ogni influenza; le sue regole e il suo funzionamento sono sempre il risultato di scelte politiche. La vera domanda non è se lo Stato debba intervenire nell’economia, ma piuttosto in che modo debba farlo. Le difficoltà economiche vengono spesso sfruttate come una specie di “cura d’urto” per imporre cambiamenti radicali a favore del libero mercato, come indebolire i sindacati. Queste decisioni, di solito molto impopolari, vengono presentate come passi obbligati e necessari.L’Ideologia Capitalista e i suoi Inganni
Il sistema capitalista si presenta come qualcosa di naturale e basato solo sull’efficienza, cercando di nascondere il fatto di essere esso stesso un’ideologia. Questo modo di fare nasconde le contraddizioni che il sistema ha al suo interno e la sua spinta continua a crescere, che rende poco chiaro il confine tra investimenti seri e operazioni puramente speculative, come si è visto nel caso Madoff. Dare la colpa delle crisi solo all’avidità di singole persone o a errori isolati serve a proteggere il sistema nella sua interezza da critiche più profonde.Come l’Ideologia Nasconde la Verità
L’ideologia di oggi usa anche la “umanizzazione”. Consiste nel presentare persone o eventi problematici, come soldati o leader autoritari, mostrando i loro lati umani, le loro debolezze o i loro sentimenti. Questo serve a distogliere l’attenzione dalle responsabilità più grandi, quelle che riguardano il sistema o l’etica delle loro azioni. Questa strategia nasconde la verità morale che si trova nelle azioni che vengono compiute, non nelle storie personali che si raccontano per giustificarle.Davvero l’ideologia capitalista si difende ‘umanizzando’ soldati e leader autoritari, o il capitolo introduce un concetto di ‘umanizzazione’ che meriterebbe un legame più esplicito con la crisi finanziaria?
Il capitolo, pur offrendo una critica penetrante del sistema economico, introduce il concetto di “umanizzazione” come strumento ideologico con esempi (soldati, leader autoritari) che sembrano distanti dalla crisi finanziaria e dalla critica del capitalismo finanziario che costituiscono il cuore dell’argomentazione. Per comprendere meglio come questa specifica tattica ideologica si applichi al contesto economico, sarebbe utile approfondire gli studi su come le narrazioni mediatiche e culturali influenzano la percezione dei sistemi di potere e delle crisi. Discipline come la sociologia della cultura o la teoria critica dei media, e autori che hanno analizzato il rapporto tra potere, discorso e rappresentazione, come Bourdieu o Foucault, potrebbero fornire gli strumenti per colmare questa lacuna e rendere più stringente il legame tra la critica dell’ideologia capitalista e le sue specifiche manifestazioni culturali.3. Il Prossimo Tossico e l’Illusione Liberale
La paura del “soggetto nocivo” non riguarda solo i rapporti tra persone, ma si estende a gruppi sociali e politici intere, come immigrati o chi ha idee considerate estremiste. Si crede che il problema sia nella natura stessa dell’altro, nel suo desiderio profondo, e che le regole della società servano a controllare questa minaccia percepita. Questa paura si manifesta nella politica attraverso misure di emergenza e restrizioni, come successo ai pescatori accusati per aver salvato migranti. Questo modo di agire ricorda una forma di “razzismo ragionato”, dove si condanna il populismo più aggressivo ma si accettano decisioni che di fatto discriminano, giustificandole come necessarie. Figure politiche come Berlusconi mostrano come si possano unire una gestione liberale che sembra tollerante e un approccio populista, governando creando scoraggiamento e usando il potere dello Stato per scopi privati.Il Capitalismo Moderno e il Ruolo dell’Ideologia
Il capitalismo di oggi, a volte chiamato “postmoderno” o “culturale”, ha assorbito alcune critiche del ’68, promuovendo l’idea di autonomia personale e l’importanza delle esperienze, anche nel modo in cui consumiamo (pensiamo al caffè “equo” o ai viaggi che promettono di “migliorare le persone”). In questo contesto, l’ideologia funziona spesso come un “feticismo”, non come un “sintomo”. Il feticismo serve a nascondere una verità difficile da accettare (per esempio, usare l’idea dell’ebreo come un feticcio per non affrontare la lotta di classe), mentre il sintomo la fa emergere. La situazione ideologica attuale sembra divisa tra un feticismo cinico e permissivo e uno più vicino al fascismo e al populismo.Liberalismo, Fondamentalismo e False Lotte
Il liberalismo, pur parlando di libertà e uguaglianza, ha una sua debolezza interna che porta alla nascita del fondamentalismo come reazione. La lotta tra liberalismo e fondamentalismo è, in realtà, una finta battaglia che nasconde i problemi veri. Le crisi economiche, come quella finanziaria, mostrano il lato quasi utopico del liberalismo stesso: si presenta come realistico, ma per funzionare richiede una certa violenza verso l’esterno e mette gli interessi del capitale davanti alla vita delle persone. Per affrontare davvero le crisi e difendere i valori che il liberalismo dice di promuovere, serve un movimento politico di sinistra con idee radicali.Ma come possono gli “esclusi”, per definizione privi di voce e potere nel sistema attuale, trasformarsi nel motore di un cambiamento sociale e politico universale?
Il capitolo identifica correttamente la centralità del conflitto tra inclusi ed esclusi e propone questi ultimi come il soggetto rivoluzionario capace di realizzare principi universali. Tuttavia, l’argomentazione presenta una lacuna significativa: non viene spiegato in modo convincente come un gruppo definito dalla sua marginalità e dalla mancanza di accesso alle leve del potere possa acquisire l’organizzazione, la forza e la visione necessarie per operare una trasformazione così radicale e universale della società. La semplice constatazione della loro esistenza e della loro condizione non è sufficiente a spiegare il meccanismo del cambiamento. Per approfondire questa problematica e cercare risposte, è utile esplorare la teoria politica, in particolare le riflessioni sul potere, l’agenzia dei gruppi marginalizzati e le dinamiche dei movimenti sociali. Autori come Michel Foucault, Hannah Arendt o anche le analisi classiche di Karl Marx sul proletariato possono offrire spunti per comprendere meglio le sfide e le possibilità legate al ruolo politico degli esclusi.6. La sfida del capitale che si rivoluziona da sé
Il capitalismo di oggi pone una sfida nuova e difficile per chi vuole cambiare la società. A differenza dei sistemi del passato, il capitalismo cambia e si rinnova continuamente. Questo rende complicato opporsi al sistema dall’esterno, perché il capitalismo stesso è capace di assorbire e rielaborare le spinte al cambiamento.La democrazia parlamentare e i suoi limiti
La democrazia basata sul parlamento viene vista come qualcosa che rende le persone passive. Non dà un vero potere alla gente comune, ma la limita a un ruolo formale, lasciando che le decisioni importanti siano prese dall’apparato dello Stato. La sua stessa struttura implica un’accettazione di fondo del sistema capitalistico. Questo si nota soprattutto nei momenti di crisi, quando il sistema democratico sembra incapace di dare voce al reale desiderio di cambiamento delle persone.Nuove forme di potere: autoritarismo e rendita
Il capitalismo di oggi mostra una tendenza crescente verso forme di governo più autoritarie, come si può osservare in diversi paesi. Il legame che c’era in passato tra capitalismo e democrazia si sta spezzando. Un aspetto fondamentale di questo cambiamento è che il profitto non deriva più solo dallo sfruttamento del lavoro, ma sempre più dalla “rendita”. Questa rendita si ottiene privatizzando e mettendo a frutto il sapere collettivo (cioè le conoscenze e le idee che appartengono a tutti) e le risorse naturali. Per poter estrarre questa rendita, è necessaria un’autorità forte che imponga le leggi che lo permettono. Paradossalmente, questo rafforza il ruolo dello Stato.La divisione sociale
Chi lavora oggi appare diviso in diverse categorie: chi fa lavori intellettuali, chi lavori manuali, e chi è ai margini della società. Spesso queste parti sono in conflitto tra loro. Per poter ottenere un cambiamento, è necessario che queste diverse componenti riescano a trovare un’unità.La necessità di agire
Di fronte a questa situazione, non serve più aspettare che la storia o una qualche forza inevitabile porti al cambiamento. La direzione che la storia sembra prendere oggi va verso la catastrofe. L’unica via d’uscita è un atto di pura volontà, una decisione consapevole di agire contro questa tendenza storica. Questo significa agire anche senza avere una conoscenza completa di tutto, ma con una sorta di fiducia nella possibilità di cambiare il corso degli eventi. Non si tratta di aspettare un salvatore o un movimento destinato a vincere, ma di capire che l’azione deve iniziare proprio da chi sta aspettando.Ma davvero un semplice ‘atto di pura volontà’ basta a rovesciare un sistema che, come descritto, si rivoluziona da sé e tende all’autoritarismo?
Il capitolo analizza con lucidità la complessità del capitalismo contemporaneo e le sue tendenze autoritarie, ma la conclusione che la soluzione risieda in un “atto di pura volontà” sembra lasciare una lacuna argomentativa fondamentale: come si traduce questa volontà in azione efficace contro strutture di potere così radicate e dinamiche? Per approfondire questo nodo cruciale, sarebbe utile esplorare discipline come la scienza politica e la sociologia dei movimenti sociali, che studiano le strategie e le dinamiche del cambiamento collettivo. Autori come Gramsci o Foucault offrono strumenti concettuali per analizzare il potere non solo come imposizione, ma anche nelle sue relazioni e nelle possibilità di resistenza organizzata, andando oltre la semplice affermazione della volontà individuale o collettiva.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]