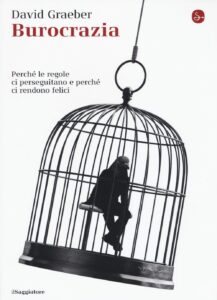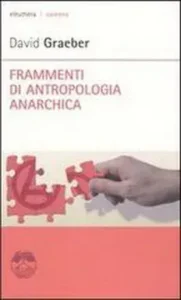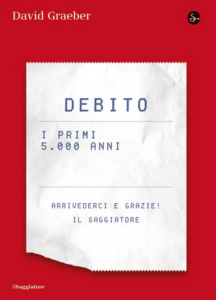1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Critica della democrazia occidentale” di David Graeber è un libro che ti fa mettere in discussione tutto quello che pensavi di sapere sulla democrazia. Non è la solita storia che inizia con l’antica Grecia e finisce con i sistemi politici moderni, presentati come un’invenzione puramente occidentale. Graeber smonta l’idea di una “tradizione occidentale” unica, come quella proposta da Huntington nel suo “scontro delle civiltà”, mostrando che concetti come individualismo o diritti umani non sono sempre stati centrali e non sono affatto universali. Il libro esplora come la democrazia, intesa come autogoverno comunitario e ricerca del consenso, sia esistita in varie forme in tutto il mondo, molto prima e spesso in modo più egualitario rispetto ad Atene. Ci racconta di come il termine “democrazia” fosse visto male dalle élite per secoli e di come l’ideale democratico sia emerso faticosamente, spesso grazie a movimenti popolari e non per merito di pensatori “occidentali”. Anzi, Graeber suggerisce che pratiche democratiche siano state influenzate da culture diverse, come quelle indigene in America o le comunità mercantili nell’Oceano Indiano, e che i poteri coloniali occidentali abbiano spesso tradito questi ideali. Infine, il libro affronta la crisi dello Stato moderno, visto come intrinsecamente non democratico a causa del suo monopolio della forza, e guarda a movimenti come gli Zapatisti in Messico come esempi di nuove forme di autogoverno comunitario che cercano di superare le contraddizioni della democrazia statale. È un viaggio affascinante nella storia delle idee politiche e delle pratic pratiche di autogestione, che ti spinge a pensare alla democrazia non come un prodotto finito da esportare, ma come un processo globale e in continua evoluzione.Riassunto Breve
L’idea di una “tradizione occidentale” coerente è problematica. Samuel P. Huntington, parlando di scontri tra civiltà, definisce l’Occidente in modo arbitrario, scegliendo alcune idee come l’individualismo o i diritti umani, che non sono sempre state centrali o universalmente accettate nemmeno in Occidente e che spesso sono rifiutate altrove. Usa “cultura” e “civiltà” in modo confuso, definendo l’Occidente con un mix di tradizioni, mentre altre civiltà sono definite principalmente dalla religione. Afferma che il pluralismo è tipico dell’Occidente, ignorando forme di pluralismo esistenti in molte società asiatiche. Questa visione riflette un vecchio modo di pensare che vede l’Occidente come dinamico e l’Oriente come fermo. La democrazia non è un’invenzione greca; comunità egualitarie con processi decisionali basati sul consenso esistevano in molte culture, spesso più egualitarie dell’antica Atene. Il consenso funziona dove non c’è un potere forte che impone le decisioni. La democrazia maggioritaria, invece, richiede sia uguaglianza nel voto sia un sistema che impone le decisioni con la forza. Nella storia, le élite occidentali vedevano la democrazia in modo negativo, associandola al caos e alla violenza popolare. I fondatori delle prime repubbliche moderne preferivano il modello romano e temevano la democrazia diretta. Solo nel XIX secolo, con l’allargamento dei diritti, il termine “democrazia” inizia a essere usato dai politici, ma spesso mantenendo un sistema basato sulla rappresentanza, non sulla partecipazione diretta. Il concetto di “civiltà occidentale” è emerso tardi, dopo la Prima guerra mondiale, per unire metropoli e colonie. Molti concetti considerati “occidentali”, come la scienza o i beni di consumo, sono in realtà il risultato di scambi e influenze globali. L’ideale democratico non è nato solo dalla tradizione occidentale, ma dall’incontro tra culture diverse. Le potenze europee, mentre si dichiaravano democratiche in patria, sostenevano regimi autoritari nelle colonie, tradendo gli ideali che dicevano di rappresentare. I movimenti di liberazione nelle colonie, invece, spesso si ispiravano a questi ideali. Esistono prove di pratiche democratiche in culture non occidentali, come le istituzioni degli Irochesi o le comunità mercantili nell’Oceano Indiano, che mostrano come l’idea di autogoverno non sia esclusiva di una singola tradizione. La democrazia emerge spesso in spazi fuori dal controllo dello Stato, dove le comunità devono organizzarsi. Lo Stato moderno, con il suo monopolio della forza, presenta una contraddizione intrinseca con l’ideale democratico; la sua legittimità si basa spesso su atti di violenza passati. La globalizzazione evidenzia i limiti delle strutture statali tradizionali. Movimenti come gli zapatisti mostrano nuove forme di democrazia basate sull’auto-organizzazione delle comunità e sul consenso, al di fuori del potere statale. Usano il termine “democrazia” attingendo a modelli comunitari e cercando alleati globali. La democrazia potrebbe trovare nuova forza negli spazi intermedi, dove le persone comuni gestiscono direttamente le proprie questioni, superando la sfiducia storica delle élite verso il popolo.Riassunto Lungo
Capitolo 1: L’incoerenza del concetto di «tradizione occidentale»
Samuel P. Huntington, nel suo saggio “Lo scontro delle civiltà”, sostiene che i conflitti globali post-guerra fredda si concentreranno sugli scontri tra tradizioni culturali. Propone l’idea di “umiltà culturale”, affermando che la cultura occidentale non è universale e che la democrazia è un concetto tipicamente occidentale da non imporre ad altre culture. A livello superficiale, la cultura occidentale ha influenzato il resto del mondo, ma a un livello più profondo le sue idee differiscono notevolmente da quelle di altre civiltà.La critica alla nozione di “tradizione occidentale”
Concetti come individualismo, liberalismo e diritti umani sono spesso poco compresi o rifiutati in culture islamiche, confuciane, giapponesi, indù e buddiste. Questi tentativi di diffusione generano reazioni contro l’“imperialismo dei diritti umani” e una riaffermazione dei valori indigeni. Huntington considera la tradizione occidentale come erede della civiltà classica, ma questo approccio è criticabile. La sua selezione di “idee occidentali” appare arbitraria; molti concetti sono evoluti nel tempo e altri sono stati accettati solo successivamente.L’analisi della nozione di “cultura” e “civiltà”
Un’analisi attenta rivela che Huntington usa “cultura” e “civiltà” in modo intercambiabile. Ogni civiltà ha una cultura composta da idee e valori, ma l’Occidente è definito attraverso un amalgama di tradizioni religiose e filosofiche. Al contrario, le altre civiltà sono definite principalmente attraverso la loro religione. Questo porta a incoerenze nella sua argomentazione. Huntington afferma che il pluralismo è una caratteristica distintiva dell’Occidente, dimenticando che molte società asiatiche hanno avuto forme di pluralismo religioso e sociale superiori.La critica all’orientalismo tradizionale
La tesi di Huntington riflette un orientalismo tradizionale: l’Occidente è dinamico mentre l’Oriente è visto come stagnante. Le ambiguità nei suoi concetti di cultura e civiltà complicano ulteriormente il discorso. La cultura può riferirsi sia a pratiche quotidiane sia a elaborazioni artistiche ed intellettuali sofisticate. Inoltre, l’individuo occidentale viene descritto come razionale e disincarnato, ma questo non riflette la realtà sociale degli esseri umani.La necessità di nuove categorie analitiche
Per affrontare questi temi in modo significativo è necessario sviluppare nuove categorie analitiche. L’idea di Occidente come entità coesa risulta problematica; storicamente le società sono state interconnesse piuttosto che isolate in civiltà distinte. L’emergere del “sistema nord-Atlantico” ha sostituito le economie precedenti del Mediterraneo e dell’Oceano Indiano, portando distruzione e schiavitù, ma anche forme nuove di cosmopolitismo. In sintesi, il capitolo mette in discussione le nozioni consolidate di Occidente e civiltà attraverso una critica alle argomentazioni di Huntington riguardo alla cultura e alla democrazia, evidenziando la necessità di riconsiderare queste categorie per comprendere meglio le interconnessioni storiche tra le diverse tradizioni culturali globali.Come può essere garantita l’oggettività e la completezza nell’analisi delle tradizioni culturali?
Il capitolo mette in luce le critiche alla nozione di “tradizione occidentale” e alla selezione arbitraria di idee occidentali, evidenziando la necessità di nuove categorie analitiche. Tuttavia, non affronta direttamente come garantire l’oggettività e la completezza nell’analisi delle tradizioni culturali. Per approfondire questo aspetto, è utile esplorare la filosofia della scienza, la sociologia della conoscenza e l’antropologia culturale. Studiare autori come Karl Popper, Thomas Kuhn e Clifford Geertz può offrire strumenti utili per comprendere meglio le sfide e le strategie per raggiungere l’oggettività nella ricerca sulle tradizioni culturali.Capitolo 2: La democrazia non è stata inventata
La storia della democrazia può essere scritta in modi diversi. Si può analizzare l’origine del termine “democrazia” nell’antica Grecia oppure esaminare le procedure egualitarie di consenso che caratterizzavano le assemblee di Atene. Comunemente, si presume che la democrazia sia un’invenzione greca, ma comunità egualitarie sono esistite in varie forme nel corso della storia, molte delle quali più egualitarie di quella ateniese. Queste comunità adottavano procedure decisionali che garantivano una partecipazione equa, spesso attraverso discussioni assembleari in cui ogni voce contava. Tuttavia, il voto era raramente utilizzato; si preferiva cercare il consenso.Il consenso come strumento di governo
Il consenso emerge in contesti dove non esiste un apparato coercitivo capace di imporre decisioni. In assenza di coercizione, il voto diventa una competizione pubblica potenzialmente dannosa per la coesione sociale. La ricerca del consenso implica compromesso e sintesi, consentendo decisioni accettabili per tutti i membri del gruppo, anche se non condivise da tutti. Una democrazia maggioritaria richiede due condizioni: l’uguaglianza nel processo decisionale e un sistema coercitivo capace di far rispettare le decisioni. Storicamente, queste condizioni non si sono presentate simultaneamente nelle società egualitarie, dove l’imposizione coercitiva era vista come incompatibile con l’idea di governo popolare.La democrazia nell’antica Grecia e a Roma
Nell’antica Grecia, la competizione era predominante in tutti gli aspetti della vita sociale e politica. Le decisioni politiche venivano prese attraverso un processo competitivo, spesso da una plebe armata. La tipologia di esercito influenzava il sistema politico: cavalleria portava a oligarchie, mentre fanterie più accessibili favorivano la democrazia. Le legioni romane applicavano pratiche democratiche simili, ma erano escluse dalla città di Roma per evitare conflitti interni. Machiavelli riprese questo concetto nel suo lavoro sulla repubblica democratica.La percezione della democrazia
Il termine “democrazia” originariamente aveva una connotazione negativa tra le élite aristocratiche, associandosi alla violenza popolare. La percezione della democrazia come tumulto ha avuto conseguenze storiche significative. Le élite hanno cercato di mantenere il controllo attraverso istituzioni che alimentavano l’idea che i processi decisionali popolari fossero intrinsecamente caotici e violenti. Ciò ha portato a sviluppi insurrezionali nel corso della storia. In Atene, il luogo pubblico principale era l’agorà, mentre a Roma il circo rappresentava un’opportunità per la plebe di partecipare a decisioni legate alla vita o alla morte dei gladiatori. Queste pratiche evidenziavano differenze fondamentali: l’agorà mirava a valorizzare la dignità del popolo, mentre il circo rappresentava un linciaggio regolamentato dallo Stato.La democrazia nel Medioevo e nell’età moderna
Le assemblee popolari medievali e i town meetings del New England presentavano procedure regolari e significative nella ricerca del consenso. Tuttavia, tali pratiche non sono riuscite a cambiare l’opinione delle élite riguardo alla governabilità popolare. Gli autori dei Federalist Papers consideravano la democrazia diretta instabile e rischiosa per i diritti delle minoranze. Solo quando il concetto di democrazia fu reinterpretato per includere la rappresentanza si ottenne una certa riabilitazione del termine tra i pensatori politici dell’epoca moderna.Come possiamo considerare che il concetto di democrazia sia evoluto nel tempo se le pratiche egualitarie di consenso risalgono a epoche precedenti?
Il capitolo afferma che la democrazia non è stata inventata, ma è evoluta nel tempo, tuttavia non spiega come sia possibile che le comunità più egualitarie abbiano adottato procedure decisionali senza l’uso del voto. Per approfondire l’argomento, è utile leggere Machiavelli e altri autori che hanno scritto sulla democrazia e sulla sua evoluzione nel tempo.Capitolo 3: Sull’emergere dell’ideale democratico
L’ideale democratico ha impiegato tempo per affermarsi nel sistema nord-atlantico. Nei primi trecento anni, la democrazia era vista negativamente, associata alla plebe e al caos, anche durante le Grandi Rivoluzioni. I fondatori delle prime costituzioni democratiche in Inghilterra, Francia e Stati Uniti rifiutavano l’etichetta di “democrazia”, considerando piuttosto la Repubblica romana come modello politico. Questi fondatori, influenzati dalla storia classica, temevano che la democrazia fosse instabile e incline alla tirannia. La Costituzione americana mirava a bilanciare poteri monarchici, aristocratici e democratici.La nascita della democrazia moderna
John Adams sosteneva che le società egualitarie non erano mai esistite e che la Costituzione romana rappresentava il miglior equilibrio tra gli elementi sociali. Questo ideale repubblicano è alla base delle costituzioni democratiche moderne, con molti conservatori americani che affermano che “l’America non è una democrazia, ma una repubblica”. Tuttavia, nel XIX secolo, il termine “democrazia” cominciò ad essere adottato quando i diritti si ampliarono e i politici cercarono il voto di agricoltori e lavoratori urbani. Andrew Jackson si definì democratico negli anni Venti del XIX secolo, portando anche altri partiti a seguire questa strada.L’evoluzione del concetto di democrazia
In Francia, i socialisti iniziarono a utilizzare il termine negli anni Trenta dello stesso secolo. Durante questo periodo, l’immagine di Atene cambiò da simbolo di caos a esempio di partecipazione pubblica. Tuttavia, questo cambiamento non implicava un vero abbraccio della democrazia diretta; i politici semplicemente sostituirono “repubblica” con “democrazia” senza alterarne il significato. Negli anni successivi, romanzieri e poeti lodarono la democrazia come ideale nobile, riflettendo un crescente sentimento popolare tra agricoltori e operai.La nozione di “civiltà occidentale”
L’ideale democratico si impose sulla tradizione letteraria e filosofica occidentale piuttosto che emergere da essa. Fino alla fine del XIX secolo, gli europei si identificavano come “europei”, non come “occidentali”. Solo negli anni Novanta del XIX secolo gli Stati Uniti vennero inclusi nella civiltà occidentale. Il concetto di “civiltà occidentale” emerse dopo la Prima guerra mondiale nelle università americane. Questo concetto tentava di unire metropoli e colonie sotto un’idea comune di superiorità morale e intellettuale, distaccandosi dall’idea di responsabilità civilizzatrice.Le ambiguità storiche
La tensione presente in termini come “scienza occidentale”, “libertà occidentali” o “beni di consumo occidentali” deriva dalle ambiguità storiche. Questi oggetti sono frutto di influenze globali; ad esempio, la scienza occidentale integra scoperte provenienti da vari continenti, i beni di consumo sono spesso prodotti utilizzando materiali globali, e le libertà occidentali riflettono una realtà complessa piuttosto che un’unica tradizione. Questa analisi evidenzia come l’ideale democratico sia stato plasmato da contesti storici specifici e interazioni culturali piuttosto che da una semplice evoluzione interna della tradizione occidentale.Non è irrazionale sostenere che la democrazia sia il risultato di un processo globale, escludendo completamente l’influenza delle istituzioni irochese sulla Costituzione americana?
Il capitolo analizzato non affronta adeguatamente la contraddizione tra la retorica democratica e le politiche coloniali repressive dei poteri europei. Inoltre, sembra che il dibattito sull’influenza delle istituzioni irochese sulla Costituzione americana sia ancora aperto. Per approfondire l’argomento, è utile esplorare la storia dei popoli indigeni e la loro influenza sulla formazione degli Stati moderni. Alcuni autori come Edward Said potrebbero offrire una prospettiva interessante sulla questione.Capitolo 5: La crisi dello Stato
Il capitolo analizza l’emergere di movimenti globali che cercano nuove forme di democrazia, con particolare riferimento agli zapatisti. Questi non rappresentano un fenomeno isolato, ma incarnano spazi di improvvisazione democratica in cui diverse comunità, con esperienze di autogoverno, si uniscono al di fuori del controllo statale. Gli zapatisti, parlando lingue maya e formando comunità multietniche nella Selva Lacandona, hanno influenzato movimenti sociali a livello globale, contribuendo alla creazione della rete People’s Global Action (PGA), che promuove principi di autonomia e democrazia diretta. La loro influenza si estende a vari gruppi e collettivi in tutto il mondo. Nonostante la loro ideologia si basi su una rifiuto dell’avanguardismo, gli zapatisti hanno avuto un impatto significativo anche per il modo in cui hanno reinterpretato il concetto di democrazia.La reinterpretazione della democrazia
Walter Mignolo sottolinea come gli zapatisti utilizzino il termine “democrazia” in modo diverso rispetto al governo messicano, attingendo ai modelli sociali dei Maya fondati sulla reciprocità e sui valori comunitari. Mignolo introduce il concetto di “border thinking”, suggerendo che questo approccio possa portare a un cosmopolitismo critico. Tuttavia, si osserva che gli zapatisti hanno scelto consapevolmente di adottare il termine “democrazia” per cercare alleati e stimolare un dibattito più ampio sulle forme di auto-organizzazione. Inoltre, si evidenzia che lo zapatismo non è semplicemente una continuazione delle pratiche tradizionali maya, ma un risultato di interazioni complesse con diverse influenze culturali e politiche.La contraddizione dello Stato democratico
Si discute anche della contraddizione intrinseca nello Stato democratico. Gli Stati sono visti come forme di violenza organizzata che non possono essere realmente democratizzate. La storia mostra che le disuguaglianze economiche richiedono apparati coercitivi per mantenere ordine e controllo. L’analisi del monopolio della forza da parte dello Stato rivela come le pretese democratiche siano spesso contraddittorie. La diffidenza verso le deliberazioni pubbliche è definita “agorafobia politica”, riflettendo una tradizione occidentale che ha sempre visto il popolo con sospetto. Anche i successi dello Stato liberale sono influenzati da questa diffidenza, poiché le garanzie democratiche vengono percepite come tentativi per controllare piuttosto che emancipare la popolazione.La legittimità degli ordini legali
La legittimità degli ordini legali è spesso basata su atti violenti precedenti, creando una tensione tra sovranità popolare e uso della forza. Questa tensione ha portato a gravi conflitti nel ventesimo secolo. In questo contesto, l’idea di una soluzione anarchica emerge come una risposta razionale alle contraddizioni dello Stato democratico. La globalizzazione ha amplificato queste problematiche, rendendo evidente l’inadeguatezza delle strutture decisionali tradizionali rispetto alle esigenze contemporanee. La proposta zapatista invita a ripensare la rivoluzione non come acquisizione del potere statale, ma come processo di auto-organizzazione delle comunità autonome.La democrazia popolare
In conclusione, la democrazia potrebbe riaffermarsi negli spazi intermedi del potere, dove le persone comuni possano gestire le proprie questioni meglio delle élite. Il cambiamento dipenderà dalla convinzione collettiva nella capacità della democrazia popolare e dalla volontà di superare le visioni distorte imposte dalle élite dominanti.Come possiamo considerare lo zapatismo un movimento realmente democratico, quando la sua ideologia si basa sul rifiuto dell’avanguardismo?
Il capitolo sembra sottovalutare la complessità della relazione tra avanguardismo e democrazia. Per comprendere meglio questa relazione, sarebbe utile approfondire il pensiero di Rosa Luxemburg, che ha scritto estensivamente su democrazia e potere. Inoltre, un’analisi più dettagliata delle pratiche politiche zapatiste potrebbe fornire maggiori informazioni su come funziona la loro idea di democrazia senza avanguardia.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]