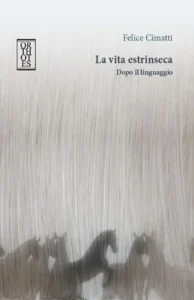Contenuti del libro
Informazioni
“Cose Per una filosofia del reale” di Felice Cimatti ci porta in un viaggio affascinante per capire il nostro rapporto con il mondo, un legame che, come scopriamo fin dal primo capitolo, è profondamente indissolubile. Cimatti ci sfida a pensare cosa siano le cose senza di noi, ma ci mostra subito quanto sia impossibile separare la nostra percezione dalla realtà stessa. Il libro esplora come il linguaggio, lungi dall’essere un semplice strumento, plasmi attivamente la nostra comprensione, trasformando le “cose” in “oggetti” e, a volte, perdendo di vista la loro essenza più profonda. Attraverso un dialogo con filosofi come Heidegger, Baudrillard, Sartre e Lacan, Cimatti ci guida attraverso concetti come il “corpo senza linguaggio” e la “Cosa” primordiale, quella realtà selvaggia che il linguaggio tende a nascondere. L’arte emerge come una possibile via d’uscita, un modo per confrontarsi con il “reale” al di là delle costruzioni linguistiche, un’immersione totale nel materiale che ci permette di diventare parte del mondo. Il libro non ha luoghi fisici specifici in cui è ambientato, ma si muove attraverso il pensiero e la riflessione filosofica, esplorando l’interiorità e la relazione tra mente, corpo e mondo. Non ci sono personaggi principali nel senso tradizionale, ma le voci dei grandi pensatori risuonano per guidarci nella comprensione di questa complessa filosofia del reale, un percorso che ci invita a ripensare il nostro posto nell’universo e la natura stessa dell’esistenza.Riassunto Breve
Il legame tra l’uomo e il mondo è così profondo da rendere impossibile separare la nostra percezione dalla realtà stessa. Ogni tentativo di descrivere il mondo “in sé”, senza l’intervento umano, è destinato a fallire perché il pensiero e il linguaggio sono intrinsecamente relazioni con il mondo. Le cose non esistono come entità isolate, ma sono parte di una rete complessa di connessioni. Il linguaggio, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel definire le cose, creando distinzioni e unità che non sono necessariamente presenti nella realtà. Heidegger sottolinea come l’essere umano, l’ “esserci”, sia separato dal mondo, vivendo in uno stato di angoscia per questa distanza. Questa separazione porta l’uomo a trasformare l’essere in “enti”, manipolabili attraverso il linguaggio e la tecnica, un processo che porta all’oblio dell’essere e alla distruzione del mondo. Sebbene Heidegger proponga una soluzione attraverso la poesia e un nuovo modo di pensare il linguaggio, questo approccio rimane ancorato all’umanesimo, mantenendo l’uomo al centro.Il linguaggio, secondo il “linguistic turn”, trasforma le cose in segni, facendoci perdere di vista la loro realtà materiale. Baudrillard suggerisce che le cose diventano proiezioni dei nostri pensieri e desideri, perdendo il loro valore intrinseco. Tuttavia, si può considerare uno “sguardo inumano” in cui le cose partecipano attivamente alla nostra percezione, come suggerito da Merleau-Ponty con l’idea di “carne”, dove la visibilità è una qualità intrinseca del mondo. L’esperienza della “nausea” di Sartre illustra la disumanizzazione delle cose, che rivelano la loro esistenza autonoma, portando l’individuo a diventare parte del mondo delle cose. L’arte, invece, può essere una via per avvicinarsi a un “oggetto assoluto”, libero dall’influenza umana, creando “cose” che sono parte integrante della realtà, non rappresentazioni. L’artista, diventando “cosa” e “mondo”, supera la distinzione tra soggetto e oggetto, liberandosi dalle convenzioni e assecondando la necessità della cosa. L’arte è l’irruzione del mondo nella nostra pseudo-*Umwelt* fatta di sembianti, un invito a confrontarci con la materia nella sua nuda esistenza. La “vita da cani”, uno stile “tardo” o “cinico”, rappresenta un modo di essere nel mondo che si distacca dalle convenzioni, diventando un “modo” del mondo stesso, un’impersonalità che porta a un “godimento” autistico.Il linguaggio non è solo uno strumento per descrivere la realtà, ma la plasma, creando una scissione fondamentale tra essenza ed esistenza, potenza e atto, e posizionando l’umanità in una situazione speciale rispetto al resto del mondo. Il linguaggio è intrinsecamente legato alla nostra capacità di pensare e comprendere il mondo, costruendo la realtà che percepiamo. La distinzione tra “cosa” e “oggetto” è cruciale: la cosa è qualcosa in cui ci sentiamo coinvolti, mentre l’oggetto è un ostacolo. Il consumismo riduce le cose a meri oggetti, indicatori di status o categorie razionali, perdendo la loro essenza. La semiologia mostra come i segni acquisiscano significato attraverso le relazioni, mentre la psicoanalisi, con Freud e Winnicott, esplora il legame tra corpo, oggetto ed esperienza del sé, dove la pulsione lega l’individuo al mondo degli oggetti in un processo continuo di trasformazione. Il linguaggio, pur dando forma al mondo, può anche nasconderlo, riducendo le cose a concetti astratti.Il corpo è intrinsecamente segnato dal linguaggio fin dall’inizio, e la soggettivazione avviene attraverso questa incarnazione del linguaggio nel corpo. La “forma-di-vita” è una vita che ha integrato la trascendenza del linguaggio, diventando sia umana che immanente. Anche gli animali sono immersi in un contesto che modella la loro esistenza, e la stretta interconnessione tra organismo e ambiente è fondamentale. La comprensione di questa relazione tra corpo e linguaggio è essenziale per cogliere la natura della soggettività e della vita stessa.Riassunto Lungo
Il Legame tra Uomo e Mondo: Una Prospettiva Filosofica
La Realtà al di là della Percezione Umana
È fondamentale comprendere la natura delle cose indipendentemente dalla nostra presenza. Tuttavia, è difficile separare la nostra percezione dal modo in cui viviamo e interpretiamo il mondo. Il realismo speculativo tenta di descrivere la realtà nella sua essenza, senza l’intervento umano. Questo sforzo è complesso, poiché ogni pensiero o espressione linguistica implica già una forma di relazione con ciò che ci circonda.Interconnessione e Ruolo del Linguaggio
L’idea che le cose esistano come entità isolate viene messa in discussione, sottolineando piuttosto la loro profonda interconnessione. Anche gli elementi più semplici, come una pietra, sono in realtà processi dinamici e parte di una vasta rete relazionale. Il linguaggio assume un ruolo cruciale nel definire le cose, creando distinzioni e unità che potrebbero non esistere intrinsecamente nella realtà.Heidegger e la Distanza tra Essere Umano e Mondo
Martin Heidegger analizza come l’essere umano, definito “esserci”, sia intrinsecamente separato dal mondo. Questa separazione genera uno stato di angoscia e colpa. L’essere umano trasforma l’essere in “enti”, ossia oggetti manipolabili, attraverso il linguaggio e la tecnica. Questo processo, noto come “metafisica”, porta all’oblio dell’essere e alla potenziale distruzione del mondo.La Proposta di Heidegger e le Sue Criticità
Heidegger propone una via di uscita attraverso la poesia e un nuovo approccio al linguaggio. In questa visione, l’essere umano diventa un “pastore dell’essere”, capace di ascoltare e dare voce al mondo. Nonostante ciò, questo approccio presenta delle debolezze. Rimane ancorato all’umanesimo, mantenendo l’uomo al centro. Inoltre, il linguaggio, sebbene visto come strumento di salvezza, è anche identificato come causa della frammentazione dell’essere. In definitiva, il tentativo di separare l’uomo dal mondo si rivela infruttuoso, evidenziando la profondità e l’inscindibilità del nostro legame con la realtà.Se il linguaggio è sia strumento di frammentazione che di salvezza, come può l’essere umano, definito “esserci” da Heidegger, sfuggire alla “metafisica” e all’oblio dell’essere senza ricadere in una visione antropocentrica o in un linguaggio che, per sua natura, categorizza e separa?
Il capitolo solleva un paradosso fondamentale nella proposta heideggeriana: il linguaggio, identificato come causa della separazione e della manipolazione del mondo, viene contemporaneamente indicato come via di uscita attraverso la poesia e l’ascolto dell’essere. Questa apparente contraddizione merita un’analisi più approfondita. Per comprendere meglio questa tensione, sarebbe utile esplorare le opere di Heidegger relative al concetto di “linguaggio” e “poesia”, nonché le critiche mosse da altri filosofi a questo approccio. Inoltre, discipline come la semiotica e la filosofia del linguaggio potrebbero fornire strumenti concettuali per dissezionare ulteriormente il ruolo del linguaggio nella nostra relazione con la realtà, indagando se esistano forme di espressione che trascendano la mera categorizzazione.Il Linguaggio e la Perdita della Realtà
Il Linguaggio come Trasformatore della Realtà
Il pensiero moderno, influenzato dal “linguistic turn”, tende a trasformare la realtà in segni. Questo processo rischia di allontanarci dalla vera essenza delle cose, facendoci perdere di vista la loro esistenza materiale. Secondo Baudrillard, gli oggetti diventano semplici proiezioni dei nostri pensieri e desideri. Non sono più visti per quello che sono, ma come strumenti che usiamo per comunicare o per definire noi stessi. Questa prospettiva ignora però la possibilità che le cose abbiano una loro vita e una loro realtà, indipendentemente da noi.Uno Sguardo Inumano sulle Cose
Invece di considerare le cose solo come oggetti passivi, possiamo immaginare uno “sguardo inumano”. In questa visione, le cose partecipano attivamente al modo in cui le percepiamo. Merleau-Ponty parla di “carne” per descrivere questa idea, suggerendo che la capacità di essere visti sia una qualità intrinseca del mondo stesso, non legata solo ai nostri occhi. Baudrillard va oltre, proponendo che l’arte possa essere una via per avvicinarsi a un “oggetto assoluto”, qualcosa di puro, libero dall’influenza umana.L’Estraneità delle Cose: L’Esperienza della “Nausea”
L’esperienza della “nausea” descritta da Sartre in La Nausea ci mostra come le cose familiari possano rivelare la loro esistenza autonoma. Oggetti di uso quotidiano, come una maniglia o un ciottolo, iniziano a sembrare estranei, causando un senso di spaesamento. In questo processo, l’individuo stesso può sentirsi parte del mondo delle cose, perdendo la propria identità. Le opere di Robbe-Grillet, con le loro descrizioni precise e quasi geometriche, cercano di “assassinare l’oggetto classico”, liberandolo da ogni significato umano o metafora.La Psicoanalisi e il Corpo Uno
La psicoanalisi, attraverso concetti come proiezione e introiezione, tende a interpretare il mondo attraverso la nostra mente, creando una separazione tra mente e corpo. Tuttavia, Freud stesso suggerisce che la psiche sia “estesa”, quasi come una “cosa”. Il “corpo uno”, in contrasto con il corpo diviso dalla psiche, è un corpo che esiste in modo puro, senza la mediazione del linguaggio o del significato. Questo corpo, libero da desideri e limiti, è un corpo che semplicemente “è”, come una cosa nella sua essenza più profonda.Il Concetto di “Das Ding” e la Liberazione dal Linguaggio
Lacan, riprendendo le idee di Freud, introduce il concetto di Das Ding, la “Cosa” selvaggia e difficile da afferrare, diversa dall’oggetto che conosciamo e nominamo (die Sache). Il linguaggio, creando significati e collegamenti, ci allontana da questa Cosa primordiale. L’unico modo per avvicinarsi a Das Ding è trasformare il linguaggio stesso in una cosa, attraverso la scrittura o il suono, come suggeriscono Joyce e Beckett. Questo permette di passare da un corpo “sintomo”, controllato dal linguaggio, a un “sinthomo”, un corpo che gode di sé, libero dal desiderio e dal significato. Il corpo uno, in quest’ottica, è un corpo che esiste pienamente, senza bisogno di essere interpretato o di un “Altro” che gli dia un senso.Se il linguaggio ci allontana dalla “Cosa” primordiale, come possiamo essere certi che la nostra interpretazione di essa, mediata dallo stesso linguaggio, sia effettivamente una liberazione e non un’ulteriore manipolazione?
Il capitolo suggerisce che la trasformazione del linguaggio in “cosa” attraverso la scrittura o il suono possa avvicinarci a Das Ding. Tuttavia, questa transizione non è priva di ambiguità: il rischio è che il tentativo di “oggettificare” il linguaggio per liberarsi dalla sua presa finisca per creare una nuova forma di prigionia concettuale. Per approfondire questa dialettica complessa, sarebbe utile esplorare le teorie sulla natura della significazione e sulla sua relazione con l’esperienza fenomenologica. Si consiglia di approfondire gli scritti di Ferdinand de Saussure per comprendere la natura arbitraria del segno linguistico e le opere di Maurice Blanchot, che indagano la relazione tra scrittura, silenzio e l’indicibile. Inoltre, un’analisi più dettagliata delle pratiche artistiche di Joyce e Beckett, citate nel capitolo, potrebbe fornire esempi concreti di come il linguaggio venga trattato come “cosa” e quali siano le implicazioni di tale operazione.1. L’Arte come Via al Reale, Oltre il Linguaggio
La Natura come Costruzione Linguistica
La natura che percepiamo è in realtà una creazione del nostro linguaggio. Il linguaggio ha il potere di definire e isolare parti del mondo, costruendo così una “natura” che ci appare familiare e ordinata. Questa natura è “addomesticata”, plasmata secondo le nostre regole e la nostra comprensione, il che garantisce la coerenza della nostra esperienza. Tuttavia, ciò che è veramente “reale”, ciò che esiste al di fuori di questa costruzione linguistica, sfugge a questa logica. Il linguaggio, pur creando la nostra realtà, lascia anche una sorta di “vuoto” nel reale, una mancanza intrinseca.L’Artista e il Confronto con il Reale
A differenza della scienza, che cerca di dare un senso al mondo, l’artista si confronta direttamente con il reale. L’artista non si limita a copiare la natura, ma “gioca con se stessa”, creando opere che sono parte integrante della realtà, non semplici rappresentazioni. Un’opera d’arte è una tautologia: è semplicemente ciò che è, una cosa tra le altre cose. In questo processo, l’artista diventa egli stesso “cosa” e “mondo”, superando la distinzione tra chi osserva e ciò che viene osservato. Questo implica un “divenire cosa”, un’immersione totale nel materiale e nel processo creativo, come dimostra l’esempio di Cézanne. L’artista non impone un significato alla cosa, ma ne asseconda la necessità, liberandosi dalle convenzioni e dalle aspettative predefinite.L’Arte come Realtà Immanente
L’arte, dunque, non è una rappresentazione del mondo, ma una sua componente intrinseca. L’artista, nel suo lavoro, non mira a conferire un significato, ma a far emergere la “necessità della cosa”, il suo essere pura cosa. Questo porta a un’uguaglianza ontologica tra l’artista e il mondo, dove l’essere umano si pone sullo stesso piano di un semplice pezzo di legno. L’arte si configura così come una forma di post-umanesimo, un modo di essere parte integrante del mondo, piuttosto che un suo osservatore esterno.Il Turbamento e l’Irruzione del Reale
Il “turbamento” che l’arte può suscitare nasce dal suo confronto con il reale, con quell'”eccesso” che rompe l’equilibrio del nostro Umwelt, il nostro mondo di significati già stabiliti. L’arte ci porta a incontrare il reale, quel “trauma” che non può essere completamente assimilato e che si nasconde dietro l’assenza di una rappresentazione chiara. Questo avviene quando un’immagine artistica cessa di essere un segno di qualcos’altro e diventa essa stessa una cosa, un “punctum” che ci colpisce, svuotando il significato e permettendo l’emergere della pura visibilità. L’arte rappresenta l’irruzione del mondo nella nostra pseudo-Umwelt fatta di apparenze, un invito a uscire dalla nostra rassicurante bolla linguistica per confrontarci con la materia nella sua nuda esistenza.La Vita Cinica e la Felicità del Divenire Mondo
La “vita da cani”, intesa come uno stile “tardo” o “cinico”, rappresenta un modo di esistere nel mondo che si distacca dalle convenzioni e dalle aspettative sociali. Questo stile non è più l’espressione di un singolo individuo, ma diventa un “modo” del mondo stesso, un’impersonalità che porta a un “godimento” autistico, non legato al desiderio di un altro. La vita cinica, in particolare, incarna la verità nel corpo, trasformando il linguaggio in una “cosa”. È una vita “vera” perché non si preoccupa del vero o del falso, concentrandosi sull’immanenza e sull’accettazione del proprio destino, come un cane che si fonde con il suo ambiente. Questa felicità, questo “cambiamento d’aspetto”, è una realizzazione improvvisa della coincidenza tra sé e il mondo, un “Mistico” che ci fa sentire a casa nel mondo, vedendolo come un “miracolo”. La felicità del cinico consiste nel suo divenire mondo, un processo che, pur partendo da una certa distanza, porta a una piena integrazione con la realtà.Se il consumismo è una “paura della complessità”, come si concilia questa affermazione con la tendenza umana a semplificare la realtà attraverso categorie e definizioni, un processo che il capitolo stesso riconosce come intrinseco al linguaggio?
Il capitolo presenta una dicotomia tra “cosa” e “oggetto” basata sul coinvolgimento affettivo, suggerendo che l’oggettivazione sia una fuga dalla complessità. Tuttavia, non chiarisce se questa semplificazione sia un difetto intrinseco alla cognizione umana o una specifica patologia legata al consumismo. Per approfondire, sarebbe utile esplorare le implicazioni della semiologia di Ferdinand de Saussure, che analizza come il linguaggio stesso crei significato attraverso la differenziazione e la categorizzazione, e le teorie di Jean Baudrillard sul simulacro e la società dei consumi, per comprendere se la riduzione a “oggetto” sia una corruzione del significato o una sua naturale evoluzione nel contesto contemporaneo.Il Corpo, il Linguaggio e la Vita
Il Corpo non è separato dal Linguaggio
Questo testo analizza come il corpo e il linguaggio siano strettamente legati, influenzandosi a vicenda. Si spiega che il corpo non esiste prima del linguaggio, ma è fin da subito modellato da esso. La domanda principale diventa quindi come il linguaggio possa diventare parte del corpo, permettendo a una persona di diventare un “io”.La “Forma-di-Vita”: una Vita Incarnata nel Linguaggio
Si parla della “forma-di-vita” come di una vita che non può essere distinta dalla sua stessa forma. È una vita che ha accolto la complessità del linguaggio, diventando così sia umana che parte del mondo reale. Questo modo di pensare si oppone all’idea di un corpo “vivo” che esisterebbe prima che una persona si riconosca come individuo, sostenendo invece che il corpo è sempre già influenzato dal linguaggio fin dall’inizio.Diverse Visioni Filosofiche sul Corpo e il Linguaggio
Per capire meglio come il linguaggio influenzi il modo in cui percepiamo, pensiamo e viviamo il nostro corpo, vengono considerate diverse idee di filosofi come Lacan, Deleuze, Foucault e Wittgenstein. Si sottolinea che il linguaggio non serve solo per comunicare, ma è fondamentale per creare la realtà e la nostra identità.Il Corpo Animale e il suo Rapporto con l’Ambiente
L’analisi si estende anche al mondo degli animali. Si discute quanto sia difficile definire concetti come le emozioni negli animali che non usano il nostro stesso linguaggio, e come anche loro possano essere ingannati da ciò che percepiscono. Viene evidenziato che l’organismo e l’ambiente sono strettamente collegati, suggerendo che anche gli animali vivono in un contesto che plasma la loro esistenza.Il Linguaggio come Base dell’Esperienza Corporea
Il testo sostiene che il corpo è inseparabile dal linguaggio. Capire questo legame è essenziale per comprendere la natura della nostra identità e della vita stessa. La vera sfida sta nel capire come il linguaggio possa realmente diventare parte del corpo, dando forma alla nostra esperienza personale.Se il linguaggio modella il corpo fin dalla sua origine, come possiamo distinguere un’esperienza corporea “autentica” da una mediata dal linguaggio, soprattutto considerando che anche gli animali, pur senza un linguaggio umano, sono influenzati dal loro ambiente e dalle loro percezioni?
Il capitolo postula una connessione indissolubile tra corpo e linguaggio, suggerendo che il primo è plasmato dal secondo fin dall’inizio. Tuttavia, questa tesi solleva interrogativi sulla natura della soggettività e della percezione, specialmente quando si estende al regno animale. L’affermazione che il corpo non esista prima del linguaggio, ma sia “fin da subito modellato da esso”, rischia di creare una dicotomia artificiale o, peggio, di negare una base biologica o esperienziale pre-linguistica all’esistenza. La difficoltà nel definire concetti come le emozioni negli animali, citata nel capitolo, potrebbe derivare non solo dalla mancanza di un linguaggio condiviso, ma da differenze intrinseche nelle loro forme di vita e nella loro interazione con il mondo. Per approfondire queste questioni, sarebbe utile esplorare le neuroscienze cognitive, la filosofia della mente e la biologia evoluzionistica, con particolare attenzione agli studi sull’etologia e sulla cognizione animale. Autori come Antonio Damasio, con le sue ricerche sulla coscienza e le emozioni, e Humberto Maturana, con il suo concetto di “autopoiesi” e la sua analisi del linguaggio come processo biologico, potrebbero offrire prospettive illuminanti per colmare le lacune argomentative del capitolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]