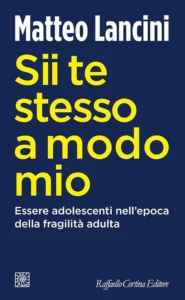1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Cosa serve ai nostri ragazzi. I nuovi adolescenti spiegati ai genitori, agli insegnanti, agli adulti” di Matteo Lancini non è il solito libro che punta il dito contro i giovani o internet. È più un tentativo di capire chi sono davvero i “nuovissimi” adolescenti di oggi, che crescono in un mondo “onlife” dove virtuale e reale si mescolano di continuo. Lancini spiega come cambiano le dinamiche familiari, con una “madre virtuale” sempre presente e genitori che faticano a tollerare la sofferenza dei figli, creando un’eccessiva “iper-protezione”. Il punto centrale è che questi ragazzi non sono tanto ribelli, ma spesso provano una profonda “delusione”, sentendosi inadeguati rispetto a ideali irraggiungibili. Questo disagio si manifesta in modi diversi dai vecchi schemi, come il “ritiro sociale” (hikikomori), l'”autolesionismo”, l’ansia o l’uso di sostanze, che diventano tentativi di gestire un dolore interno. Anche la scuola deve fare i conti con questa realtà, capendo che le vecchie regole non bastano più e che serve una “relazione educativa” autentica, “educazione digitale” e la capacità di insegnare a gestire il “fallimento”. Il libro è un invito agli adulti – genitori, insegnanti, chiunque – a guardare oltre gli stereotipi, a comprendere le vere ragioni dietro i comportamenti dei ragazzi e a costruire un ponte con loro, offrendo supporto e comprensione in un mondo complesso.Riassunto Breve
Gli adolescenti di oggi crescono in un mondo molto cambiato. La figura del padre tradizionale è meno presente, mentre la madre spesso usa lo smartphone per controllare tutto, limitando l’autonomia e il gioco fuori casa. Fin da piccoli, i ragazzi sono spinti verso la socializzazione e il successo, con i genitori che cercano di togliere ogni ostacolo dal loro percorso. Questo crea un’infanzia “iperprotetta” dove non si impara a gestire la sofferenza. La vita è sempre più un mix tra online e offline, e l’immagine che si dà diventa importantissima per tutti. Quando arriva l’adolescenza, che per natura porta cambiamenti nel corpo e nelle relazioni e richiede di affrontare la realtà, i ragazzi incontrano difficoltà. Spesso, dopo averli spinti a esprimersi da piccoli, gli adulti chiedono più controllo, incolpando facilmente smartphone o videogiochi per i problemi. Il punto principale per gli adolescenti di oggi non è la ribellione contro gli adulti, ma la delusione. Crescono con aspettative altissime su sé stessi, spesso impossibili da raggiungere, influenzati da un mondo che esalta immagine e successo. Si sentono inadeguati, non abbastanza bravi o popolari, e provano vergogna e rabbia che non riescono a esprimere. Questo disagio si manifesta attaccando sé stessi o il proprio corpo, con comportamenti come l’isolamento, i disturbi alimentari, l’autolesionismo, l’ansia o l’uso di sostanze. Questi non sono atti di trasgressione, ma modi per sopportare un dolore interiore o per farsi notare. Internet e i social media sono usati per cercare riconoscimento, ma anche per mostrare il proprio malessere. Gli adulti spesso non capiscono, usano vecchie spiegazioni o danno la colpa solo alla tecnologia, perdendo la fiducia dei ragazzi. La relazione con gli adulti, genitori o insegnanti, è fondamentale. I ragazzi cercano adulti autorevoli, che si prendano responsabilità e ascoltino, non che semplifichino tutto o si limitino a controllare. Le punizioni di una volta, come bocciare o togliere cose, non funzionano più, creano solo indifferenza. L’educazione oggi si basa sull’affetto e sulla relazione, spiegando perché le regole sono importanti e adattandole. Non si può controllare l’uso di internet, bisogna educare i ragazzi a usarlo bene, promuovendo la “saggezza digitale”. La scuola deve integrare la tecnologia, non vietarla, e insegnare l’educazione digitale, affettiva e sessuale. La scuola deve anche contrastare l’individualismo e la competizione. È urgente rispondere alla domanda dei ragazzi: “A cosa serve la scuola?”. Non hanno paura dell’adulto, cercano una relazione vera. Spesso c’è un malinteso, dove studenti e insegnanti si sentono poco capiti. Gli insegnanti devono avere passione e interesse sincero. La scuola deve preparare per lavori futuri incerti, puntando su pensiero critico, risolvere problemi, creatività e lavorare insieme. Deve aiutare i ragazzi a dare un senso agli errori e ai fallimenti, che sono parte della crescita, non qualcosa di cui vergognarsi. Voti bassi e bocciature spesso mostrano la difficoltà degli adulti, non la loro autorità, e spingono i ragazzi ad abbandonare la scuola. Servono valutazioni che guardino alla crescita personale e percorsi su misura per chi ha più difficoltà. Famiglia e scuola devono collaborare di più. I genitori non devono pensare solo al successo del proprio figlio, ma anche alle difficoltà degli altri, accettando che i ragazzi inciampino e sbaglino. Gli adulti devono interessarsi davvero alla vita dei ragazzi, anche online, e parlare di cose difficili come la tristezza o il suicidio. Il dolore e il fallimento non vanno nascosti, ma affrontati. Amare i figli per come sono, con le loro caratteristiche uniche, è importante. La scuola deve insegnare le competenze per il futuro e dare gli strumenti per costruire la propria identità, invece di sottolineare solo le mancanze o limitare l’uso della tecnologia senza educare. Bisogna investire nell’educazione digitale e preparare i giovani per il mondo che cambia.Riassunto Lungo
1. La Nuova Infanzia e le Contraddizioni Educative
Gli adolescenti di oggi, chiamati “nuovissimi”, crescono in un ambiente sociale ed educativo molto diverso dal passato. La nostra società vive una fusione costante tra vita online e offline, un’età definita “onlife”. In questo contesto, la visibilità e l’immagine che si proietta all’esterno diventano estremamente importanti per tutti, non solo per i giovani.Le Trasformazioni nella Genitorialità
Questo cambiamento nel contesto si riflette anche nel modo in cui i genitori accompagnano i figli. La figura paterna tradizionale sembra meno presente, mentre emerge una sorta di “madre virtuale” che usa lo smartphone per un controllo quasi costante sulla vita dei figli, monitorando le loro attività e i loro spostamenti. I genitori mostrano una grande difficoltà nell’accettare che i figli possano incontrare sofferenze, difficoltà o fallimenti. Spesso cercano di spianare ogni ostacolo sul loro cammino, creando modelli educativi che potremmo definire “iperideali”, dove non c’è spazio per il dolore come parte naturale della crescita.L’Impatto sull’Infanzia e l’Adolescenza
Questa sorveglianza e protezione eccessiva limitano l’autonomia dei ragazzi e la loro capacità di socializzare in modo spontaneo, come avveniva un tempo nei cortili o per strada. L’infanzia è caratterizzata da un’anticipazione delle esperienze tipiche di età successive e da una forte spinta verso la socializzazione e il successo, incoraggiati dai genitori fin da piccolissimi. Tuttavia, con l’arrivo dell’adolescenza, l’approccio educativo cambia: dal sostegno all’espressione si passa a richieste di maggiore sottomissione e controllo. Spesso, le difficoltà che i ragazzi incontrano in questa fase vengono attribuite all’uso di smartphone o videogiochi, cercando cause esterne anziché interne.Le Sfide Evolutive dell’Adolescenza
L’adolescenza porta con sé compiti importanti per la crescita personale. I ragazzi devono accettare i cambiamenti del proprio corpo e riorganizzare le loro relazioni con gli altri e con il mondo. Questi processi richiedono di confrontarsi con la realtà, e questo confronto può inevitabilmente generare sofferenza, soprattutto dopo un’infanzia vissuta in modo iper-protetto. In questa fase, diventa fondamentale per i giovani cercare e costruire la propria conoscenza, che include anche la comprensione delle proprie origini.Il Ruolo degli Adulti
La vera sfida per gli adulti che accompagnano i ragazzi è proprio questa: accettare la complessità del percorso di crescita e riconoscere che il dolore ha un suo ruolo in questo processo. È importante evitare di cercare sempre cause esterne per spiegare le difficoltà che i giovani incontrano, ma piuttosto aiutarli ad affrontare la realtà.Siamo sicuri che la “madre virtuale” e i genitori “iperideali” siano i soli colpevoli delle difficoltà dei “nuovissimi”, o il capitolo semplifica eccessivamente un fenomeno complesso?
Il capitolo identifica nello stile genitoriale contemporaneo una causa primaria delle difficoltà adolescenziali, concentrandosi su concetti come la “madre virtuale” e i genitori “iperideali”. Tuttavia, un’analisi più approfondita richiederebbe di considerare la molteplicità di fattori che influenzano lo sviluppo dei giovani nell’era “onlife”. Per ottenere una visione più completa, è fondamentale esplorare discipline come la sociologia, la psicologia dello sviluppo e gli studi sui media digitali, che offrono prospettive diverse sulle trasformazioni sociali e sul loro impatto sugli individui. Autori che hanno analizzato le dinamiche familiari nel contesto della società liquida o l’influenza della tecnologia sulle relazioni e sull’identità possono fornire spunti critici per valutare se la responsabilità delle difficoltà adolescenziali ricada esclusivamente sulla genitorialità o sia distribuita su un sistema più ampio di pressioni e cambiamenti.2. La delusione al posto della ribellione
L’adolescenza di oggi si vive in un modo diverso rispetto al passato. Gli adulti sono ancora figure di riferimento, ma i vecchi modi di educare, basati su regole strette e sul far sentire in colpa, non funzionano più bene. Questi metodi, che insegnavano il dovere e la colpa fin da piccoli, hanno creato nei ragazzi aspettative su sé stessi molto alte, spesso impossibili da raggiungere. Per questo, oggi, i ragazzi non sono più tanto ribelli contro gli adulti. Il loro problema principale è la delusione. Crescono con idee di come dovrebbero essere molto elevate, spesso impossibili da raggiungere. Questo succede perché la società dà molta importanza all’aspetto fisico, al successo e all’essere popolari. Per questo, i ragazzi si sentono non all’altezza, non abbastanza belli o conosciuti, provando vergogna e una rabbia nascosta per quello che percepiscono come fallimenti.Segnali di sofferenza e sessualità
Questa sensazione di non essere abbastanza si vede in modi diversi, spesso colpendo sé stessi o il proprio corpo. Per esempio, alcuni si isolano (hikikomori), altri hanno problemi con il cibo o si fanno del male (autolesionismo). Ci sono anche attacchi di ansia o panico e l’uso di droghe leggere. Questi non sono modi per sfidare le regole, ma tentativi di affrontare un dolore interiore troppo forte o di farsi notare. Anche internet e i social media diventano un luogo dove cercare accettazione o mostrare la propria sofferenza. Azioni come scambiare messaggi sessuali o fare cyberbullismo possono essere sforzi estremi per sentirsi importanti o non sembrare deboli. Questi comportamenti sono come dei “sintomi che curano”, modi veloci per cercare di non affondare nella sofferenza. Anche il modo di vivere la sessualità cambia. È meno legata ai vecchi riti di passaggio e più aperta e “fluida”. Questo è influenzato dal mondo digitale e da quello che i coetanei si aspettano.La difficoltà degli adulti e l’importanza di capire
Spesso gli adulti fanno fatica a capire questa situazione nuova. Vedono i comportamenti dei ragazzi con le idee di una volta, pensando che siano solo ribelli o poco informati. Oppure, semplificano troppo, per esempio dando la colpa solo a internet. Questo modo di fare non aiuta e fa perdere la fiducia dei ragazzi. Bisogna capire bene la differenza tra i comportamenti normali che i ragazzi hanno crescendo nel mondo digitale e i segnali di vera sofferenza. Per aiutare davvero, serve capire le emozioni profonde che spingono i ragazzi ad agire in certi modi e offrire loro un aiuto, invece di pensare solo a controllare o punire.Ma siamo sicuri che la delusione abbia davvero soppiantato la ribellione, o non è forse una forma di ribellione più subdola e rivolta verso sé stessi, anziché verso l’autorità esterna?
Il capitolo propone un’interessante distinzione tra la ribellione del passato e la delusione del presente, suggerendo che quest’ultima sia la cifra distintiva dell’adolescenza contemporanea. Tuttavia, questa netta separazione potrebbe semplificare eccessivamente un fenomeno complesso. La “delusione” descritta, con le sue manifestazioni di auto-sabotaggio e sofferenza interiore, non potrebbe essere interpretata come una reazione estrema e disfunzionale a un sistema di aspettative (sociali, familiari, personali) percepito come opprimente e ingiusto? In tal senso, il ritiro, l’autolesionismo o l’uso distorto dei social media potrebbero non essere solo sintomi di delusione, ma atti di protesta silenziosa o autodistruttiva contro un mondo che non riconoscono o in cui non si sentono accettati. Per approfondire questa prospettiva e comprendere meglio le dinamiche psicologiche e sociali che legano (o distinguono) ribellione e delusione nell’età adolescenziale, è utile esplorare i lavori di autori che si sono occupati di psicologia dello sviluppo, come Erik Erikson, e di sociologia della giovinezza, analizzando il rapporto tra individuo e società in contesti di rapido cambiamento culturale e tecnologico.3. La Relazione Educativa e la Scuola Oggi
In una società complessa, il legame tra adulti, che siano genitori o insegnanti, e adolescenti è di grande importanza. I ragazzi cercano adulti autorevoli, capaci di prendersi cura di loro sia sul piano affettivo che professionale. Non vogliono figure che semplificano la realtà o si limitano a controllare. Le nuove generazioni hanno bisogno di essere ascoltate e di ricevere un aiuto mirato, lontano dai soliti stereotipi e dalla paura che spesso si lega a internet. La vita è piena di sfide e non si risolve con ricette semplici o divieti. La crescita include anche momenti difficili e processi di separazione.Le punizioni di una volta, come togliere qualcosa, allontanare o bocciare a scuola, spesso non funzionano con gli adolescenti di oggi. Questi metodi portano i ragazzi a fare finta di niente o a disinteressarsi, invece di aiutarli a capire o a trovare la motivazione. L’educazione oggi si basa sull’importanza del legame affettivo. La relazione viene prima di tutto, e l’affetto serve a spiegare perché certe regole sono necessarie. Le regole funzionano meglio se vengono discusse e adattate all’età e alla persona. L’intervento educativo deve includere tutti.Il Ruolo della Scuola e l’Era Digitale
Controllare l’uso di internet da parte degli adolescenti è praticamente impossibile. È fondamentale, invece, guidarli e sostenerli nell’usare la rete in modo intelligente, promuovendo quella che si può chiamare saggezza digitale. La scuola dovrebbe integrare i dispositivi connessi nella vita di tutti i giorni degli studenti, invece di proibirli. Servono leggi e percorsi formativi adatti al nostro tempo digitale, che promuovano l’educazione su come usare la rete, ma anche l’educazione affettiva e sessuale. La scuola ha il compito di contrastare l’idea di essere soli e in competizione che spesso viene dai media e da internet. Nonostante sia un’istituzione complessa, è urgente rispondere alla domanda che molti adolescenti si fanno: “A cosa serve andare a scuola?”. I ragazzi non hanno paura degli adulti, ma desiderano costruire con loro un rapporto che abbia un senso. Spesso, tra studenti e insegnanti, c’è un malinteso: entrambi sentono di non essere capiti o apprezzati abbastanza. Gli insegnanti hanno bisogno di passione, preparazione e un interesse sincero verso i loro studenti. Gli adolescenti danno valore al rapporto con l’insegnante, cercando un adulto che li aiuti a capire chi sono. La scuola deve cambiare insieme alla società e preparare i ragazzi per lavori futuri che saranno diversi da quelli di oggi. Per questo, sono importanti capacità come pensare in modo critico, risolvere problemi, essere creativi e saper lavorare insieme agli altri.Valutazione e Accettazione del Fallimento
La scuola deve incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente, a costruire la conoscenza insieme e ad aiutarli a capire il valore delle loro esperienze, anche quando sbagliano. Imparare a gestire un fallimento è molto diverso dal sentirsi umiliati. I voti numerici e le bocciature, visti a volte come segno di serietà, in realtà contribuiscono a far abbandonare la scuola a molti ragazzi e alimentano la competizione. L’abbandono scolastico è un problema serio che riguarda soprattutto gli adolescenti maschi, e la scuola fa fatica ad adattarsi a come sono fatti e a cosa hanno bisogno. Dare un voto con un numero o bocciare un ragazzo sono segnali che mostrano la difficoltà degli adulti, non la loro autorevolezza. Valutare in modo diverso, guardando al percorso di crescita di ogni ragazzo e al rapporto che si crea, funziona meglio. Non si tratta di far passare tutti, ma di creare percorsi che includano ogni studente e gli offrano la possibilità di crescere. Le difficoltà di ognuno richiedono un aiuto personalizzato.L’Alleanza tra Famiglia e Scuola
La scuola e la famiglia devono unire le forze per educare i ragazzi. I genitori non dovrebbero pensare solo al successo del proprio figlio, ma interessarsi anche alle difficoltà degli altri bambini in classe, promuovendo l’idea che l’educazione è un compito di tutta la comunità. È fondamentale accettare e tollerare che i ragazzi possano inciampare e fare errori. Gli adulti dovrebbero essere come degli “influencer” positivi, interessandosi davvero alla vita degli adolescenti, compreso quello che fanno online. È importante chiedere loro come stanno vivendo questo periodo di cambiamento e affrontare argomenti difficili come la tristezza o, in casi estremi, il pensiero del suicidio. Il dolore e gli sbagli non vanno nascosti, ma accolti e discussi apertamente. Amare i figli per come sono, riconoscendo le loro qualità uniche, è un compito essenziale. La scuola deve concentrarsi sull’insegnare le capacità che serviranno in futuro, su come gestire gli errori e sul fornire gli strumenti per costruire la propria identità, invece di sottolineare solo quello che manca o di vietare l’uso di internet. È necessario investire nell’educazione all’uso del digitale e preparare i giovani per i lavori che verranno.[/membership]Ma davvero basta un “legame affettivo” per educare, o si rischia di smarrire il senso di responsabilità e i confini necessari alla crescita?
Il capitolo, pur evidenziando giustamente i limiti di metodi educativi obsoleti e l’importanza cruciale della relazione, rischia di sminuire eccessivamente il ruolo di confini chiari, regole condivise che prevedano anche conseguenze, e di una valutazione che, seppur non umiliante, offra un riscontro oggettivo sul percorso di apprendimento. Concentrarsi quasi esclusivamente sul “legame affettivo” potrebbe non preparare adeguatamente i ragazzi alle sfide di un mondo che richiede anche disciplina, resilienza di fronte al fallimento (non solo gestirlo, ma a volte subirlo e imparare), e la capacità di rispondere delle proprie azioni. Per approfondire questo delicato equilibrio tra supporto e struttura, è utile esplorare diverse teorie pedagogiche che integrano l’aspetto relazionale con la necessità di disciplina e responsabilità, e autori che hanno trattato la psicologia dello sviluppo e il ruolo dei limiti nella formazione del carattere.4. Un atlante di storie, idee e mondi
I volumi pubblicati offrono un vasto panorama di argomenti, esplorando un’ampia varietà di storie, idee e mondi.Storie dal Passato e Vite Straordinarie
Si indaga la storia da molte angolazioni diverse. Vengono raccontate le vicende del Sud Italia sotto i Borbone, la vita di tutti i giorni durante la Seconda Guerra Mondiale e i grandi conflitti come quelli tra Oriente e Occidente. Si approfondiscono anche battaglie specifiche, come quelle di Pavia o Canne. Un posto importante è dato alle biografie di persone che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura, da sovrani come Elisabetta e Carlo a figure come Napoleone, Mata Hari, Primo Levi, Giorgio Gaber, Oscar Wilde e Mary Shelley.Società, Politica e Questioni Attuali
Si affrontano temi sociali e politici molto attuali. Tra questi, si parla delle migrazioni, del concetto di identità, del dibattito sul genere e delle dinamiche del mondo del lavoro. Vengono esaminate anche la criminalità organizzata e l’evoluzione politica sia in Italia che in Europa.La Conoscenza tra Scienza e Cultura
Ampio spazio è dedicato al mondo della scienza e della tecnologia. Vengono trattati argomenti come l’intelligenza artificiale, la genetica, il funzionamento della mente umana, l’esplorazione dello spazio e il mondo delle piante (botanica). La cultura è esplorata in molte sue forme, dall’arte alla fotografia, dalla letteratura al cinema, dalla musica al design.Vita Personale, Luoghi e Riflessioni Umane
I volumi toccano anche aspetti più personali della vita, come le emozioni, l’esperienza dei viaggi, il cibo e il legame con la natura. Si esplorano luoghi specifici, dall’Italia all’Europa e oltre, attraverso percorsi storici o racconti legati a città precise. Infine, si riflette sulla condizione umana, affrontando temi universali come l’amore, la ricerca della felicità e le relazioni tra le persone.Ma cosa lega davvero la battaglia di Canne all’intelligenza artificiale, o Mata Hari al dibattito di genere?
Il capitolo elenca un’impressionante varietà di argomenti, ma la loro giustapposizione senza un esplicito filo conduttore o una tesi unificante lascia perplessi. Un semplice elenco, per quanto vasto, non costituisce di per sé un “atlante” coerente. Per comprendere come temi così diversi possano dialogare o essere inseriti in un quadro significativo, sarebbe utile esplorare approcci interdisciplinari o filosofie della storia che cercano connessioni profonde tra eventi, idee e fenomeni apparentemente distanti. Autori che hanno tentato grandi sintesi del sapere potrebbero offrire spunti su come costruire un ponte tra “storie, idee e mondi” così eterogenei.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]