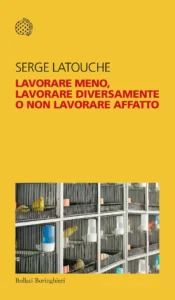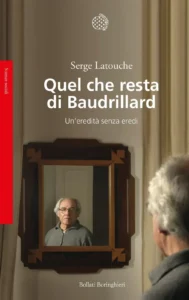Contenuti del libro
Informazioni
“Come reincantare il mondo. La decrescita e il sacro” di Serge Latouche ti sbatte in faccia un’idea forte: e se l’economia, con tutta la sua fissazione sulla crescita e il denaro, fosse diventata la nostra nuova religione? Latouche analizza come il culto del denaro e del progresso abbia preso il posto delle vecchie divinità, creando un sistema quasi sacro che ci spinge a crescere all’infinito, un po’ come un debito da ripagare. Questa “religione della crescita” ha portato a un profondo disincanto del mondo, banalizzando tutto e causando danni enormi all’ambiente, un tema che viene affrontato anche nel dibattito della Chiesa, confrontando le visioni di Benedetto XVI e Papa Francesco, specialmente nella sua enciclica Laudato Si’, che critica duramente il modello attuale e l’ecologia superficiale. Ma il libro non si ferma alla critica; propone la “decrescita” non solo come un’alternativa economica, ma come una vera e propria conversione, una nuova fede laica che ci permette di riscoprire una dimensione spirituale e di “reincantare il mondo” attraverso l’arte, la meraviglia e un diverso rapporto con la natura, uscendo dalla gabbia del PIL e del consumo sfrenato.Riassunto Breve
L’economia moderna, specialmente l’idea di crescita continua, funziona un po’ come una religione. Si usano parole che vengono dalla religione per parlare di soldi e mercati, come se le banche fossero chiese o la borsa un tempio. I soldi, il mercato e la crescita diventano cose da adorare, prendendo il posto delle vecchie divinità. Questa adorazione dei soldi non è nuova, ma oggi è diventata accettata, quasi “santa”, anche grazie a come si sono mescolate idee religiose e non religiose. I soldi, anche se sembrano solo pratici, prendono un valore quasi sacro, come nell’antica idea di adorare Mammona. Anche nelle religioni antiche c’erano regole economiche legate al debito e al perdono, mostrando un legame antico tra cose di valore e cose sacre. La spinta a crescere sempre di più è fondamentale in questa religione economica. Il sistema dei prestiti e degli interessi obbliga a una crescita continua per poter ripagare i debiti, creando un meccanismo che va avanti da solo. Questo sistema, che sembra un po’ crudele, è stato reso accettabile, soprattutto in Occidente, elevando la crescita a una specie di religione moderna. L’economia è diventata “santa” anche perché si sono usati valori che prima erano religiosi, come l’etica del lavoro e l’idea che accumulare ricchezze sia un segno positivo. L’economia è vista come una scienza che misura il valore in modo oggettivo, senza preoccuparsi troppo di questioni morali, lasciando al mercato il compito di decidere cosa vale. Nonostante ci siano tentativi di dare regole morali all’economia e un senso di insoddisfazione, questa “religione della crescita” continua a esistere, con i soldi visti come una divinità e l’economia come il suo culto principale, influenzando come pensiamo e cosa consideriamo reale oggi.La società di oggi, cercando di organizzarsi da sola, ha creato nuove regole rigide, facendole passare per cose naturali. L’Illuminismo voleva eliminare i vecchi idoli, ma ne ha creati di nuovi e molto forti: la Ragione, il Progresso, la Scienza, la Tecnica, lo Sviluppo e la Crescita economica. Queste idee sono diventate oggetti di fede, perché l’economia ha occupato un posto enorme nella nostra mente, quasi come la religione faceva una volta. Per chi crede in questo oggi, economia, progresso e crescita sono visti come cose fondamentali, buone e naturali. Si pensa che far crescere l’economia porti automaticamente benessere e giustizia per tutti. Il Progresso è diventato un modo per giustificare le difficoltà, prendendo il posto della religione. È legato a scienza e tecnica ed è il cuore della religione dell’economia. Credere nel progresso aiuta a realizzarlo. Il PIL (Prodotto Interno Lordo) per persona diventa la misura del progresso e del benessere, mescolando ricchezza materiale e morale. Aumentare il PIL diventa l’obiettivo morale più importante. Questa sacralizzazione della crescita economica ha reso normale fare cose dannose per le persone e l’ambiente, giustificandole in nome del progresso economico. Anche se ci sono sempre più critiche e meno fiducia nel progresso, si continua su questa strada perché non si vedono alternative. L’idea della decrescita emerge come una possibile rottura, ma richiede di ritrovare una dimensione spirituale, andando contro una società che ha fatto della crescita la sua nuova religione, svuotando il mondo di altri valori importanti.Anche la Chiesa Cattolica si confronta con questi temi. L’enciclica *Caritas in veritate* di Benedetto XVI parla di una “buona economia”, un “buon” profitto, una “buona” globalizzazione, come se solo le parti storte del sistema fossero sbagliate, non il sistema in sé. Questa enciclica mostra quanto l’economia abbia influenzato anche il pensiero del Papa, presentandola come qualcosa di indiscutibile e potenzialmente buono. Crescita e sviluppo sono centrali, anche se si parla di “sviluppo umano”, senza però criticare davvero il modello economico dominante. Globalizzazione e libero scambio sono visti in modo positivo. La carità sembra quasi messa in secondo piano, con l’economia che ha bisogno dell’etica solo per funzionare meglio. Si parla di responsabilità delle aziende e di “economia della carità”, cercando di mettere insieme logiche di mercato e valori cristiani. Invece, l’enciclica *Laudato si’* di Papa Francesco cambia molto, proponendo un’ecologia integrale che critica profondamente il sistema basato sulla produzione. Francesco denuncia la “cultura dello scarto” e i danni dell’economia, cercando le cause e proponendo soluzioni. Critica lo sfruttamento dell’ambiente, la perdita di specie e l’inquinamento, vedendo un sistema dove la tecnica, guidata dal profitto, domina. Critica la “religione della crescita” e smaschera il finto ambientalismo delle aziende. Suggerisce soluzioni vere che implicano un rallentamento della crescita, una “decrescita” in alcune parti del mondo, e un cambiamento nel modo di pensare delle persone. Anche se ci sono ancora punti poco chiari sullo “sviluppo sostenibile”, la *Laudato si’* è un passo importante verso una critica più forte del modello economico e un richiamo all’ecologia, molto diverso dall’approccio precedente.Il mondo moderno, come diceva Weber, ha perso la magia, sostituendo le spiegazioni magiche con quelle scientifiche. Ma la modernità ha creato una nuova magia, un’entusiasmo per scienza e tecnica, alimentando il mito che l’uomo possa controllare la natura senza limiti. Questo progresso, però, porta a una perdita di magia ancora più profonda: le cose meravigliose diventano banali a causa del sistema industriale e dello sfruttamento. L’abbondanza artificiale ci impedisce di stupirci della bellezza del mondo. La fede nel progresso è diventata parte della vita di tutti i giorni e una fiducia cieca nell’economia, più per abitudine che per scelta. Il fallimento di questa promessa di crescita, però, può farci aprire gli occhi. Le crisi del sistema economico possono essere occasioni per mettere in discussione questo modello. La società basata sulla crescita si basa su una fede quasi religiosa, che non accetta critiche razionali. Per realizzare la decrescita, serve una specie di cambiamento di mentalità di massa, un abbandono della religione dell’economia. Questo non significa trovare una nuova religione, ma riscoprire un lato spirituale e la capacità di meravigliarsi del mondo. La decrescita è vista come una saggezza, un modo per rendere il mondo di nuovo affascinante, non con nuove superstizioni, ma con l’arte, la poesia, l’estetica. Queste cose possono nutrire un senso di trascendenza, risvegliando emozioni profonde e la meraviglia che si prova da bambini. L’arte, opponendosi alla banalizzazione del mercato, è fondamentale per costruire una società della decrescita serena, riscoprendo un rispetto per il mondo e il valore intrinseco delle cose. La sfida è gestire questo nuovo modo di sentire in modo democratico, evitando che diventi una nuova forma di controllo.Le encicliche dei Papi affrontano il rapporto complicato tra economia ed ecologia. Si guarda come la Chiesa parla delle sfide ambientali e dello sviluppo economico. La *Caritas in Veritate* di Benedetto XVI propone l’idea di una “buona economia”, ma questa idea viene vista in modo critico, quasi come una contraddizione. L’insistere nel definire lo “sviluppo” come umano, integrale, autentico, mostra una difficoltà interna. Ci si chiede se questa visione riesca a mettere insieme la crescita economica e i limiti dell’ambiente. La critica si concentra sulla difficoltà di integrare davvero le preoccupazioni ambientali in un modello di sviluppo tradizionale. Con Papa Francesco e la *Laudato Si’*, sembra esserci un passo verso una “ecologia integrale”. Anche se non si usa la parola “decrescita”, c’è una critica forte a un ambientalismo superficiale e a un sistema mondiale che non è sostenibile. L’enciclica riconosce che bisogna affrontare le cause profonde della crisi ecologica, mettendo in discussione un modello di sviluppo basato solo sulla crescita economica illimitata. Si vede che la Chiesa si muove su un terreno difficile, cercando di promuovere lo sviluppo e allo stesso tempo proteggere l’ambiente. Il dibattito è se si possano mettere insieme le esigenze economiche e quelle ecologiche, e se le recenti encicliche mostrino un cambiamento verso una maggiore consapevolezza dei limiti del modello di crescita attuale. Resta da capire se questo cambiamento implichi un ripensamento profondo dell’idea stessa di sviluppo e un possibile passaggio a modelli economici più sostenibili e attenti al pianeta.La decrescita viene vista anche come un insieme di idee e credenze, non solo come un piano economico o politico. Si dice che la critica forte al modello di sviluppo attuale e all’ossessione per la crescita economica assomigli a una vera e propria fede. Questa visione del mondo mette in discussione i valori dominanti del consumismo e dell’accumulazione, proponendo un modo diverso di vedere le cose basato su principi etici. La decrescita, in questo senso, non è solo un insieme di proposte pratiche, ma un modo di vivere che richiede un cambiamento profondo. È un rifiuto delle idee fisse della società industriale avanzata e un’adesione a principi come la sobrietà, il vivere con quello che basta e la responsabilità verso l’ambiente. Questi principi non sono solo strumenti per usare meglio le risorse, ma regole morali che guidano le azioni delle persone e della società. In questo modo, la decrescita risponde a un bisogno di trovare un senso che c’è nelle società di oggi, offrendo una risposta alla crisi dei valori e alla perdita di orientamento. Propone una storia diversa rispetto al mito del progresso che va avanti all’infinito, suggerendo una speranza basata su un rapporto diverso con la natura, con gli altri e con il tempo. La capacità della decrescita di spingere le persone a impegnarsi e la sua dimensione utopica mostrano che è un fenomeno che va oltre la semplice logica economica, avvicinandosi a una forma di credenza non religiosa.Riassunto Lungo
1. L’Economia Sacra: Ascesa della Religione della Crescita
L’Economia come Religione
L’idea che l’economia possa essere considerata una religione all’inizio può sembrare strana. Tuttavia, se si analizza attentamente, si scopre che l’economia ha preso molte caratteristiche tipiche delle religioni. Nel linguaggio economico, si usano spesso metafore religiose: le banche diventano “chiese”, gli agenti di cambio sono visti come “sacerdoti” e la Borsa è considerata un “tempio”. In questa visione, il denaro, il mercato e la crescita economica diventano oggetti di vera e propria adorazione, quasi a sostituire le divinità tradizionali.L’Antico Culto della Ricchezza
Questo culto della ricchezza non è una novità dei nostri tempi, ma ha radici molto antiche. Nel corso della storia, si è trasformato dall’adorazione di oggetti preziosi usati come moneta, fino all’attuale venerazione del mercato. In passato, l’adorazione della ricchezza era vista negativamente, ma in epoca moderna è stata in un certo senso “santificata”, grazie a un complesso intreccio tra religione e idee che si oppongono alla religione.Il Denaro come Entità Sacra
Il denaro, che di per sé è qualcosa di materiale e non sacro, ha assunto nel tempo caratteristiche quasi sacre. Un esempio di questo è il culto di Mammona, una divinità associata all’avidità e alla ricchezza. Anche nelle religioni antiche, spesso si usavano logiche economiche, come il concetto di debito e riscatto, e si stabilivano tariffe diverse in base alla posizione sociale delle persone. Questo dimostra come l’idea di dare un valore economico alle cose sia presente da molto tempo, quasi una “monetizzazione” dei valori religiosi. Inoltre, la fiducia nel sistema economico e la fede religiosa si sono mescolate, rivelando un legame profondo tra ciò che è prezioso e ciò che è considerato sacro.La Crescita Economica come Imperativo Religioso
La necessità di una crescita economica continua è diventata un elemento fondamentale di questa “religione” dell’economia. Il sistema del credito, ad esempio, richiede una crescita costante per poter ripagare i debiti e gli interessi, creando un meccanismo che sembra non avere mai fine. Questo sistema, che a volte può sembrare quasi infernale per le sueLogiche stringenti, è stato in qualche modo accettato e persino “santificato”, soprattutto nei paesi occidentali, dove la crescita economica è diventata una sorta di religione moderna.La Santificazione dell’Economia Moderna
La “santificazione” dell’economia è avvenuta attraverso un processo in cui si è cercato di rendere meno negativa l’idea del denaro. Questo è stato fatto laicizzando alcuni valori tipici del protestantesimo e abbracciando l’utilitarismo, una filosofia che mette al centro l’utilità e il benessere materiale. In questo contesto, l’etica del lavoro, cioè l’importanza di lavorare duramente, e l’accumulo di ricchezza senza limiti sono diventati segni di approvazione divina. L’economia è stata elevata a “scienza del valore”, oggettivando il valore delle cose e liberandosi da preoccupazioni di tipo etico o morale. In questa visione, il mercato è diventato il giudice supremo del valore di ogni cosa.La Persistenza della “Religione della Crescita”
Nonostante i vari tentativi di introdurre principi morali nell’economia e il diffuso senso di insoddisfazione che si percepisce nella società, la “religione della crescita” continua a persistere. Il denaro è diventato una sorta di divinità e l’economia il suo culto ufficiale, influenzando profondamente il modo di pensare delle persone e definendo i limiti di ciò che consideriamo reale e possibile nel mondo contemporaneo.Ma è davvero utile ridurre l’economia moderna a una “religione”, o si tratta di una semplificazione eccessiva che rischia di oscurare le vere dinamiche sociali e i complessi problemi economici contemporanei?
Il capitolo presenta una prospettiva interessante sull’economia, ma l’analogia con la religione, sebbene suggestiva, potrebbe risultare limitante. Per comprendere appieno le dinamiche in gioco, sarebbe utile esplorare le origini storiche del pensiero economico e le sue trasformazioni nel tempo, magari approfondendo autori come Weber e Polanyi, che hanno analizzato il rapporto tra economia e società. Inoltre, una riflessione sulle diverse scuole di pensiero economico contemporanee, come l’economia comportamentale o l’economia ecologica, potrebbe offrire una visione più sfumata e completa del fenomeno descritto nel capitolo.2. La Nuova Fede Economica
La genesi della nuova fede economica
La società moderna, nel tentativo di auto-organizzarsi senza appoggi esterni, ha paradossalmente creato nuove forme di costrizione, proiettandole in una presunta “natura delle cose”.I nuovi idoli dell’Illuminismo
L’Illuminismo, pur mirando a smantellare i vecchi idoli, ha finito per sostituirli con nuove divinità ancora più potenti: Razionalità, Progresso, Scienza, Tecnica, Sviluppo e Crescita economica. Questi concetti sono diventati oggetto di culto e devozione, sostenuti da una profonda colonizzazione dell’immaginario da parte dell’economico e da una vera e propria teologia del Progresso.Il ruolo centrale dell’economia
L’economia ha assunto un ruolo centrale nella mentalità moderna, tanto da influenzare la percezione di ogni problema in termini economici. Questo dominio dell’immaginario è recente e occidentale, paragonabile all’influenza totalizzante che la religione esercitava nelle società antiche. Per i moderni credenti, economia, progresso e crescita sono realtà essenziali, positive e radicate nella natura stessa. Si crede che l’espansione economica sia un bene indiscutibile, portando con sé giustizia sociale e benessere universale.Il Progresso come strumento di legittimazione
Il Progresso si afferma come strumento di legittimazione e giustificazione delle sofferenze, prendendo il posto della religione tradizionale. Esso è strettamente legato a scienza, tecnica e sviluppo, diventando il nucleo centrale della religione dell’economia.La fede nel progresso e le sue conseguenze
La fede nel progresso è autorealizzante: la convinzione che progresso e crescita siano positivi spinge ad azioni che li promuovono. Il PIL pro capite diventa la misura del progresso e del benessere, confondendo benessere materiale e morale. La massimizzazione del PIL si trasforma in un obiettivo morale primario.La banalizzazione del male in nome del progresso
Questa sacralizzazione della crescita economica ha portato a una banalizzazione del male, dove azioni dannose per uomini e ambiente sono giustificate in nome del progresso economico. Nonostante le crescenti critiche e la perdita di fiducia nel progresso, si continua a perseguire questo modello, in mancanza di alternative.La decrescita come alternativa e la necessità di una dimensione spirituale
La decrescita emerge come possibile rottura radicale, ma si trova di fronte alla necessità di reintegrare una dimensione spirituale, contrapponendosi a una società che ha fatto della crescita economica la sua nuova religione laica, svuotando il mondo di altri valori.Se questa ‘fede economica’ è davvero così irrazionale e dannosa, come mai continua a dominare il pensiero e le azioni nella società contemporanea?
Il capitolo mette in luce i pericoli di una fede acritica nella crescita economica. Tuttavia, non indaga a fondo le ragioni per cui questa “fede” risulti così resiliente. Per comprendere questa persistenza, è fondamentale approfondire i meccanismi dell’ideologia e del potere. Esplorare le opere di autori come Marx, che ha analizzato il ruolo dell’ideologia nel mantenimento delle strutture sociali, o Foucault, che ha esaminato il rapporto tra potere e sapere, potrebbe fornire spunti preziosi. Inoltre, considerare autori che hanno studiato il consumismo e la formazione dei desideri sociali potrebbe illuminare le radici profonde di questa fede economica.3. La Svolta Papale: Economia ed Ecologia nel Discorso Vaticano
Nella politica occidentale globalizzata, usare l’ossimoro è una pratica comune. L’ossimoro è l’accostamento di parole che hanno un significato opposto. Anche la Chiesa Cattolica usa questa tecnica, nell’enciclicaL’Enciclica Caritas in veritate
Questa enciclica mostra come l’economia abbia influenzato il modo di pensare del Papa. L’economia viene presentata come qualcosa di cui non si può discutere e che può essere anche “buona”. Concetti come crescita e sviluppo diventano molto importanti. Lo “sviluppo umano” è considerato fondamentale, ma non c’è una critica forte al modello economico principale. La globalizzazione e il libero scambio sono visti in modo positivo, in accordo con le istituzioni economiche di tutto il mondo. La carità cristiana sembra avere un ruolo meno importante. Si pensa che l’economia abbia bisogno dell’etica solo per funzionare correttamente. Si parla di “responsabilità delle aziende” e si introduce l’idea di “economia della carità”. Si cerca di unire l’idea di gratuità e di dono con l’attività economica normale, provando a mettere insieme le logiche del mercato e i valori cristiani.L’Enciclica Laudato si’
Invece, l’enciclicaMa è davvero inevitabile che “sviluppo economico” e “tutela ambientale” siano in conflitto, o stiamo accettando una narrazione limitante?
Il capitolo presenta una tensione tra sviluppo economico e tutela ambientale quasi fosse una legge naturale. Ma questa contrapposizione potrebbe derivare da una visione specifica dello sviluppo, radicata in modelli economici superati. Per capire se esistono alternative, è utile studiare l’economia ecologica, approfondendo autori come Herman Daly e Giorgos Kallis, che mettono in discussione i presupposti della crescita economica infinita.6. La Fede nella Decrescita
La Decrescita come sistema di credenze
La decrescita viene analizzata come un sistema di credenze, andando oltre le questioni economiche e politiche. Si sostiene che la critica radicale al modello di sviluppo attuale e all’importanza data alla crescita economica diventa una vera e propria fede. Questo modo di vedere le cose mette in discussione i valori principali del consumismo e dell’accumulo, proponendo un sistema etico diverso.Principi e valori della Decrescita
La decrescita non è solo un insieme di proposte pratiche, ma diventa un modo di vivere che richiede un cambiamento profondo. È un rifiuto delle idee fisse della società industriale avanzata e un’adesione a principi fondamentali come la sobrietà, vivere con poco e la responsabilità verso l’ambiente. Questi principi non sono solo strumenti per usare meglio le risorse, ma diventano regole morali che guidano le azioni delle persone e della società.La Decrescita come risposta alla crisi di valori
La decrescita risponde a un bisogno di significato che si sente nelle società di oggi, offrendo una soluzione alla crisi dei valori e alla mancanza di direzione. Propone una storia diversa rispetto all’idea del progresso continuo e senza limiti, suggerendo un futuro di speranza basato su un diverso rapporto con la natura, con gli altri e con il tempo. La capacità della decrescita di spingere le persone ad agire, di ispirare un impegno personale importante e la sua dimensione ideale dimostrano che è più di una questione economica, avvicinandosi a una forma di fede laica.Ma definire la decrescita come “fede” non rischia di oscurare la necessità di analisi concrete e verificabili?
Il capitolo presenta la decrescita come una fede, enfatizzandone gli aspetti etici e valoriali. Tuttavia, questa impostazione potrebbe trascurare l’importanza di un’analisi rigorosa delle implicazioni pratiche e delle basi empiriche della decrescita. Per comprendere meglio se la decrescita sia una risposta efficace e realizzabile alle sfide attuali, sarebbe utile approfondire discipline come l’economia ecologica e la sociologia ambientale, studiando autori come Serge Latouche, un sostenitore della decrescita, ma anche economisti e sociologi che offrono prospettive critiche.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]