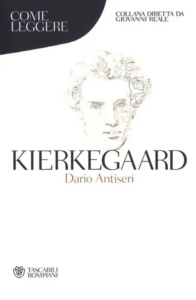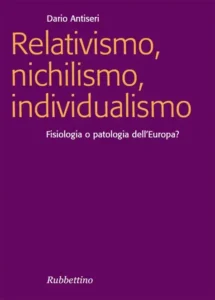1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Come leggere Pascal” di Dario Antiseri ti porta nel cuore del Seicento, un’epoca di svolta dove la rivoluzione scientifica, con figure come Galileo, scuoteva le fondamenta del sapere tradizionale e metteva in crisi la vecchia scolastica. In questo scenario intellettualmente effervescente, emerge la figura complessa di Pascal, non solo un genio della scienza e della matematica (pensiamo alla sua invenzione della calcolatrice o ai suoi studi sul vuoto), ma anche un pensatore profondamente tormentato dalle grandi domande sull’esistenza e sulla fede. Il libro esplora proprio questa tensione, analizzando il dibattito tra ragione e rivelazione, scienza e teologia, che caratterizza il pensiero di Pascal e il suo legame con movimenti come il giansenismo, centrato attorno al monastero di Port-Royal. Vedremo come Pascal si confronta con filosofi come Cartesio e Gassendi, analizza la paradossale condizione umana, fatta di miseria e grandezza, e propone la sua celebre scommessa di Pascal come un modo per affrontare l’ineludibile questione di Dio quando la ragione da sola non basta. È un viaggio affascinante nel pensiero di uno dei più grandi spiriti del suo tempo, che ancora oggi ci interroga.Riassunto Breve
Nel diciassettesimo secolo, la rivoluzione scientifica trasforma il sapere, mettendo in crisi la filosofia scolastica basata sull’autorità di Aristotele. Figure come Gassendi criticano questo sapere verboso e promuovono l’esperienza e l’osservazione, contestando anche il sistema deduttivo di Cartesio per la sua distanza dalla realtà empirica. In questo contesto, emerge la tensione tra ragione scientifica e fede religiosa. La scienza si fonda sull’esperienza e la ragione, progredisce nel tempo e rifiuta l’autorità, mentre la teologia si basa sull’autorità delle Scritture e della tradizione, con verità eterne che trascendono la ragione. La modernità scientifica riconosce che ogni epoca può superare la precedente nella conoscenza. Esistono due modi di pensare: lo spirito geometrico, basato su principi chiari ma distanti, e lo spirito di finezza, che coglie principi sottili e numerosi intuitivamente. L’essere umano si trova in una condizione paradossale di miseria, segnata da incertezza, inganni dei sensi e dell’immaginazione, egoismo e vanità. Questa miseria spinge l’uomo a cercare distrazioni per evitare di confrontarsi con la propria condizione e la paura della morte. La distrazione, o “divertissement”, è una fuga dalla riflessione interiore, che allontana l’individuo dalla consapevolezza di sé. Nonostante la miseria, l’uomo possiede grandezza nella sua capacità di pensare e nella coscienza della propria condizione, che lo eleva. La ragione umana, tuttavia, mostra i suoi limiti nel fondare principi morali universali; la giustizia e il bene variano con i luoghi e i tempi, dimostrando che consuetudine e forza spesso prevalgono sulla ragione. Le prove metafisiche dell’esistenza di Dio sono considerate inefficaci perché la ragione è fallibile e non può comprendere pienamente Dio. La fede non nasce da argomenti razionali, ma è un dono divino che si radica nel cuore. Il vero Dio non è il “Dio dei filosofi”, un’entità astratta, ma il “Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe”, un Dio personale che si rivela in Gesù Cristo. Dio si manifesta come un “Deus absconditus”, un Dio nascosto, la cui oscurità è funzionale alla condizione umana, permettendo di percepire sia la corruzione che la speranza di redenzione. Il cristianesimo riconosce sia la miseria che la grandezza dell’uomo, offrendo una via che equilibra timore e speranza, a differenza del deismo (orgoglio) o dell’ateismo (disperazione). Di fronte alla domanda sull’esistenza di Dio, la ragione è impotente e la scelta tra credere o non credere è inevitabile. Si presenta una scommessa: scommettendo sull’esistenza di Dio, si rischia il finito (la vita terrena) per guadagnare l’infinito (beatitudine eterna). Se si vince, si guadagna tutto; se si perde, la perdita è minima. Questa scommessa non è un mero calcolo, ma una risposta al bisogno di significato ultimo che filosofia e scienza non soddisfano. Riconoscere la propria miseria e contingenza apre alla fede come una scommessa sensata di fronte a una domanda ineludibile, un atto di ragione che offre la possibilità di un guadagno infinito.Riassunto Lungo
1. L’Alba della Ragione e la Crisi della Scolastica
L’epoca di Pascal è un periodo di grandi cambiamenti nel mondo del pensiero. La scienza sta vivendo una rivoluzione, e questo cambiamento scientifico porta con sé anche un cambiamento nel modo di filosofare. Scienziati come Keplero e Galileo aprono strade nuove nel sapere scientifico. Filosofi come Bacone e Hobbes si interrogano sulle conseguenze di queste novità. In questo contesto nasce anche il calcolo delle probabilità, una nuova disciplina scientifica a cui Pascal, insieme a Fermat, dà un contributo fondamentale. Questa disciplina nasce da problemi molto concreti, come quelli legati al gioco d’azzardo.La critica alla Scolastica di Gassendi
Gassendi critica in modo radicale il pensiero tradizionale di Aristotele e della Scolastica. Secondo Gassendi, questo modo di pensare è vecchio e pieno di parole inutili. Gassendi propone un sapere nuovo, basato sull’esperienza e sull’osservazione della natura. Si oppone all’idea che Aristotele abbia sempre ragione e critica le discussioni astratte e complesse della Scolastica. Questa critica si estende anche a Cartesio. Gassendi accusa Cartesio di aver creato un sistema filosofico basato su idee preconcette e deduzioni, lontano dalla realtà concreta dell’esperienza. In particolare, Gassendi non è d’accordo con la metafisica di Cartesio, soprattutto con la distinzione tra anima e corpo e con le prove dell’esistenza di Dio, che considera prive di fondamento empirico, cioè non basate sull’esperienza.Il ruolo di Mersenne nel dialogo tra scienza e fede
Mersenne è una figura importante perché mette in contatto tra loro gli studiosi di tutta Europa. Si impegna a far dialogare scienza e fede. Amico di Cartesio e traduttore di Galileo, Mersenne si rende conto che ci sono tensioni tra le nuove scoperte scientifiche e le dottrine tradizionali della Chiesa. Pur sostenendo che la scienza debba essere libera di indagare, Mersenne si preoccupa che alcuni mettano in dubbio l’esistenza di Dio o si allontanino dalla fede cristiana. Per questo, difende una fede basata sul buon senso e sulla volontà di credere.Pascal: scienza, fede e critica
Pascal dimostra fin da giovane un grande talento per la scienza, dando importanti contributi alla geometria e alla fisica. Inventa anche una macchina calcolatrice, dimostrando la sua capacità pratica. Ma la sua vita è segnata anche da una profonda ricerca spirituale. Vive due conversioni religiose che lo avvicinano al movimento del Port-Royal e al giansenismo, una corrente religiosa molto rigorosa. Con la sua opera “Le Provinciali”, Pascal critica duramente la morale dei Gesuiti, accusandoli di essere troppo permissivi e di adattare le regole morali a seconda delle circostanze. Pascal rappresenta quindi la difficoltà di conciliare ragione scientifica e fede religiosa, una difficoltà tipica di un’epoca in cui il vecchio sistema di pensiero scolastico entra in crisi di fronte alle nuove idee.Ma in che modo specifico il capitolo definisce la “crisi della Scolastica”?
Il capitolo introduce la “crisi della Scolastica” come un elemento centrale per comprendere il contesto intellettuale dell’epoca di Pascal, ma non approfondisce in modo sufficiente la natura specifica di questa crisi. Si accenna alla critica di Gassendi e alla nuova enfasi sull’esperienza, ma non si chiarisce se la crisi fosse primariamente metodologica, contenutistica, o legata a fattori sociali e istituzionali. Per comprendere appieno la portata di questa trasformazione, sarebbe utile esplorare più a fondo le caratteristiche del pensiero scolastico e le ragioni del suo declino, magari approfondendo autori come Aristotele e Tommaso d’Aquino, per poi confrontarli con le nuove proposte filosofiche e scientifiche del periodo.2. I Sentieri Divergenti di Ragione e Rivelazione
Nel Seicento, il contesto culturale è molto vivace. In questo periodo storico nascono nuove idee come il libertinismo e il giansenismo, che mostrano modi diversi di vedere la religione e la conoscenza. Il libertinismo è un movimento di persone colte che si ispirano al mondo antico e al Rinascimento. Questi libertini criticano le regole e la morale della Chiesa Cristiana. Spesso, invece di credere in un Dio personale, preferiscono pensare a un Essere supremo lontano dal mondo degli uomini. Allo stesso tempo, il giansenismo nasce da studi sulla teologia, con persone importanti come Giansenio e Saint-Cyran. I giansenisti vogliono tornare a una morale più severa, come insegnava Sant’Agostino. Si oppongono a un modo di fare meno rigido che vedono nei gesuiti e insistono sull’importanza della grazia divina, cioè dell’aiuto di Dio.Il monastero di Port-Royal diventa un punto di riferimento fondamentale per il giansenismo. Da qui, le idee gianseniste si diffondono anche nella filosofia, come si vede nel libro di logica scritto da Arnauld e Nicole. Questo libro sulla logica, che si ispira alle idee di Cartesio, non vuole essere solo un insieme di regole per ragionare in modo formale. Vuole piuttosto insegnare l’arte di pensare in modo corretto. Inoltre, si interroga sul rapporto tra pensiero e linguaggio, anticipando argomenti che saranno poi ripresi dagli studiosi del linguaggio moderno.In questo periodo, Pascal riflette sulla differenza tra scienza e teologia. Pascal spiega che nella scienza, che si basa sull’esperienza e sulla ragione, non bisogna accettare le cose solo perché le ha dette qualcuno di importante. Al contrario, bisogna indagare e cercare sempre nuove scoperte. Le verità scientifiche cambiano e si aggiungono nel tempo, costruendosi sulle scoperte fatte in precedenza. Invece, nella teologia, l’autorità delle Scritture e di quello che è stato detto in passato è fondamentale. Questo perché le verità della fede vanno oltre la ragione umana e sono eterne, cioè non cambiano mai. Perciò, Pascal critica chi usa l’autorità in modo sbagliato nella scienza o chi pensa di poter capire la teologia solo con la ragione. Pascal spera invece che si riconosca la differenza tra questi due modi di conoscere. Secondo Pascal, la scienza moderna si basa sull’idea che ogni epoca può conoscere più di quelle passate. Questo perché la verità scientifica nasce dal tempo e dall’esperienza di tutti gli uomini insieme.Ma è davvero così netta la distinzione tra ragione scientifica e fede teologica come la presenta il capitolo?
Il capitolo sembra delineare una divisione troppo rigida tra scienza e teologia, quasi fossero due mondi completamente separati. Tuttavia, la storia del pensiero ci mostra come il rapporto tra fede e ragione sia stato spesso molto più complesso e sfumato. Per comprendere meglio questa complessità, sarebbe utile approfondire la storia della filosofia medievale e moderna, studiando autori come Tommaso d’Aquino per il rapporto tra fede e ragione, e autori come Galileo Galilei e lo stesso Pascal nel loro contesto storico-scientifico, per capire le sfide e le interazioni tra scienza e fede nel Seicento.3. Tra Ragione Geometrica e Intuizione Umana: Misura e Dignità dell’Essere
Il Metodo Scientifico e i Limiti della Geometria
Il sapere scientifico avanza attraverso tentativi ed errori, a differenza della fede che è considerata immutabile. Per dare una struttura rigorosa alla scienza, si suggerisce di usare un metodo simile alla geometria. Questo metodo richiede definizioni precise e principi che siano evidenti a tutti. Tuttavia, un sistema perfetto che definisca e dimostri ogni cosa si dimostra impossibile da realizzare. La geometria, quindi, offre un approccio più pratico, basandosi su verità che appaiono chiare e immediate.L’Arte della Persuasione e le Regole Argomentative
Per persuadere in modo efficace, è necessario rivolgersi all’intelletto con argomentazioni logiche, e non solo alla volontà delle persone. L’arte della persuasione segue delle regole precise. Queste regole includono definire chiaramente i termini che si usano, proporre principi di base che siano evidenti e sostituire mentalmente le definizioni all’interno delle dimostrazioni. L’obiettivo di questo metodo è costruire ragionamenti solidi e impossibili da confutare.Due Modi di Pensare: Spirito Geometrico e Spirito di Finezza
Esistono due tipi di intelligenza: lo spirito geometrico e lo spirito di finezza. Lo spirito geometrico lavora con principi facili da toccare con mano, ma lontani dal modo di pensare comune. Lo spirito di finezza, invece, si muove attraverso principi più difficili da definire e molto numerosi, che si possono capire grazie all’intuizione.La Condizione Umana: Miseria e Grandezza
Se osserviamo la vita umana attraverso queste due forme di intelligenza, notiamo un paradosso. L’essere umano è segnato dalla miseria, una condizione profonda fatta di incertezza, di inganni dei sensi e dell’immaginazione, di egoismo e di vanità.La Dignità Umana: La Coscienza e il Pensiero
Nonostante questa miseria, nell’uomo si trova anche una grandezza. Questa grandezza nasce dalla consapevolezza della propria condizione e dalla capacità di pensare. La dignità dell’uomo sta proprio nel pensiero, che lo rende superiore all’universo materiale, anche se è fragile. Perciò, è essenziale riconoscere e accettare questa natura duplice dell’uomo, comprendendo che miseria e grandezza sono due aspetti che non possono essere separati nell’essere umano.È davvero razionale sostenere che la “debolezza” umana sia una condizione necessaria per apprezzare un presunto “Dio nascosto”, o si tratta piuttosto di una costruzione teologica per giustificare l’indimostrabilità della sua esistenza?
Il capitolo sembra presupporre che la difficoltà di comprendere Dio razionalmente sia una prova della sua esistenza e della necessità della fede. Tuttavia, questa argomentazione potrebbe essere ribaltata: l’assenza di prove razionali potrebbe semplicemente indicare l’assenza dell’oggetto di fede. Per approfondire questa critica, è utile esplorare il pensiero filosofico scettico e le opere di autori come David Hume, che hanno analizzato criticamente le basi razionali della fede religiosa. Inoltre, lo studio della filosofia della scienza può fornire strumenti utili per distinguere tra affermazioni verificabili e ipotesi non falsificabili.7. La Scommessa Inevitabile
L’esistenza di Dio: una scommessa inevitabile
Esiste un dubbio fondamentale per ogni persona: Dio esiste oppure non esiste. Di fronte a questa domanda cruciale, la ragione umana non riesce a trovare una risposta definitiva. Per questo motivo, ogni individuo si trova di fronte a una scelta inevitabile: credere o non credere. La ragione non offre una soluzione chiara e rimanere indecisi non è possibile. La vita stessa ci mette di fronte alla necessità di prendere una posizione.La posta in gioco: finito e infinito
Questa scelta si presenta come una scommessa. Quando si valutano le opzioni, si capisce che ciò che si rischia e ciò che si può guadagnare non sono la stessa cosa. Da una parte, se si sceglie di credere in Dio, si rischia qualcosa di finito, cioè la propria vita terrena. Dall’altra parte, però, si può guadagnare qualcosa di infinito, ovvero la felicità eterna. Se si scommette sull’esistenza di Dio e si indovina, si vince tutto. Se invece si perde, in realtà non si perde nulla di veramente importante, soprattutto se si è vissuta una vita retta e onesta.La fede come risposta al bisogno di significato
Questa idea non è solo un calcolo di convenienza, ma è soprattutto una risposta alla domanda più profonda sul senso della vita. La filosofia e la scienza, nonostante i loro sforzi, non sono riuscite a dare risposte complete al bisogno umano di trovare un significato ultimo all’esistenza. Di fronte a questa mancanza di risposte definitive, la fede si presenta come una possibilità concreta e ragionevole, una vera e propria scommessa sul futuro.Un invito a considerare la fede
La scommessa di Pascal non vuole obbligare nessuno a credere, ma vuole piuttosto invitare a riflettere seriamente sulla questione di Dio. Questa scommessa mette in discussione l’indifferenza e la superbia intellettuale, che spesso ci impediscono di affrontare le domande fondamentali sulla vita. Riconoscere i propri limiti e la fragilità della condizione umana apre uno spazio per la fede. La fede non è vista come una fuga irrazionale, ma come una risposta sensata a una domanda che non possiamo evitare. Scegliere di credere in Dio, quindi, diventa un atto di ragione, una scommessa che, anche se comporta un margine di incertezza, offre la possibilità di ottenere un guadagno infinito a fronte di un rischio molto piccolo.Ma è davvero possibile ridurre la fede a una mera scommessa razionale, svuotandola di ogni autenticità spirituale e morale?
Il capitolo presenta la fede come una ‘scommessa’, un calcolo di convenienza tra un rischio finito e un guadagno infinito. Tuttavia, questa visione potrebbe essere eccessivamente riduttiva. La fede, in molte tradizioni, è intesa come un impegno esistenziale profondo, una risposta a un richiamo interiore, e non semplicemente una strategia per massimizzare il proprio ‘guadagno’. Per comprendere meglio la complessità della fede e le critiche alla scommessa di Pascal, è utile approfondire la filosofia della religione e il pensiero di autori che hanno esplorato il tema della fede in modo più articolato.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]