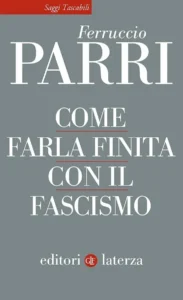1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Come farla finita con il fascismo” di Ferruccio Parri è un libro che ci porta indietro nel tempo, in un’Italia che ha dovuto scegliere tra la sottomissione e la lotta per la libertà. Attraverso le parole di Parri, un protagonista della Resistenza italiana, scopriamo la forza morale di una generazione che ha detto no al regime fascista, ispirandosi ai valori del Risorgimento. Il libro ci fa rivivere l’epopea della Resistenza partigiana, un movimento nato dal desiderio di riscattare l’Italia dalla vergogna della guerra e del fascismo, mostrando come le diverse anime politiche si siano unite, nonostante le difficoltà, contro il nazifascismo. Parri, con la sua coerenza e il suo senso di responsabilità, ci mostra come la Resistenza non sia stata solo una guerra di liberazione, ma un’opportunità per ricostruire l’Italia su basi democratiche, un impegno civico che ha visto protagonisti uomini e donne che hanno creduto in un futuro diverso. Il libro affronta anche le sfide della ricostruzione, le speranze post-belliche e le difficoltà nel tradurre gli ideali della Resistenza in azioni concrete, evidenziando come la memoria di quel periodo sia fondamentale per contrastare il neofascismo e per difendere i valori della democrazia. Le figure chiave che emergono da queste pagine, dai comandanti partigiani ai leader politici, ci aiutano a comprendere la complessità di un’epoca cruciale per la storia italiana.Riassunto Breve
La Resistenza italiana, vista attraverso le parole di Ferruccio Parri e altri documenti, emerge come un movimento fondato su un profondo senso morale e sulla volontà di ricostruire un’Italia libera e giusta. Fin da una lettera del 1927, Parri dichiara la sua opposizione al fascismo, non come un gesto personale, ma come la rivendicazione di una generazione fedele ai valori risorgimentali. Nel 1945, il suo discorso traccia un bilancio della lotta partigiana, descrivendola come un riscatto nazionale nato dal desiderio di liberare l’Italia da una “vergogna”. La Resistenza viene presentata come un movimento spontaneo, organizzato con difficoltà ma con determinazione, che ha visto crescere l’unità tra le diverse componenti politiche e ha collaborato con gli alleati, ottenendo risultati significativi nonostante le avversità. L’eredità della Resistenza non è solo la liberazione, ma anche l’opportunità di costruire un nuovo paese su basi democratiche, integrando chi aveva combattuto nelle nuove istituzioni.L’unità d’azione è stata fondamentale, come dimostra una lettera del 1944 che difende la struttura del CLNAI e le decisioni collegiali, pur riconoscendo le difficoltà operative e la scarsa collaborazione di alcuni partiti, in particolare il PCI. La caduta del governo Parri nel 1945, definito “governo della Resistenza”, segna un momento critico. Nato dalle speranze post-liberazione, il suo breve mandato è stato minato da dissidi interni, diffidenze e un contesto politico complesso. Parri stesso riflette sulla sua inesperienza politica e sulla difficoltà di trasformare gli ideali della Resistenza in azioni concrete, scontrandosi con la politica dei partiti tradizionali e un certo disinteresse generale. Le critiche al suo governo, incentrate sulla presunta violazione della “continuità dello Stato” da parte dei CLN, vengono interpretate come un attacco alla Resistenza stessa, preludendo alla crisi del Partito d’Azione e alla prevalenza degli interessi partitici sugli ideali unitari, con il rischio che l’Italia tornasse a un passato non democratico nonostante il contributo della Resistenza alla Costituzione.Le speranze della Resistenza si scontrano con le sfide della ricostruzione. Un discorso del 1945 evidenzia le difficoltà nel gestire un paese segnato dalla guerra e dalla frammentazione politica, con problemi economici come la carenza di beni primari e la disoccupazione. La mancanza di un’efficace “disinfestazione” dalla mentalità fascista e la debolezza delle coalizioni di governo sono ostacoli significativi. Trent’anni dopo, nel 1974, si riflette su come l’entusiasmo post-bellico si sia scontrato con una realtà ancora divisa e segnata da un’eredità totalitaria. La Resistenza, pur salvando l’onore nazionale, era un movimento minoritario la cui eredità è stata erosa da divisioni ideologiche e dalla gestione politica successiva. Le celebrazioni superficiali delle ricorrenze oscurano la comprensione profonda dei valori e delle lotte. La Costituzione, nata da quel contesto, rimane un baluardo di libertà, ma si sottolinea la necessità di non dimenticare i doveri civici. La difficoltà nel “trainare” il paese verso un futuro migliore emerge come tema ricorrente, ostacolato da divisioni interne e dalla persistenza di vecchie mentalità.La Resistenza è un fondamento morale e una lotta contro il neofascismo. È stata un atto politico e civile che ha definito il futuro del paese, una scelta di libertà da non dimenticare o alterare. L’energia morale sprigionata tra il 1943 e il 1945 è un patrimonio inestimabile. La sua storia, pur complessa, ha un significato fondativo indiscutibile, dalla crisi del fascismo fino alla lotta armata, contribuendo a forgiare l’identità democratica del paese. Gli scioperi del marzo 1943, ad esempio, dimostrano la forza delle classi lavoratrici. La Resistenza, nonostante le divisioni interne, ha rappresentato un’unità di intenti e valori, con diverse componenti politiche che hanno lavorato insieme per la liberazione. La minaccia del neofascismo negli anni ’70 ha reso urgente la difesa di questi valori, evidenziando la fragilità della democrazia e la necessità di un antifascismo concreto, che vada oltre la denuncia per smantellare le organizzazioni neofasciste e preservare la memoria storica. La Resistenza è un monito costante per il presente e il futuro, ispirando la lotta per la democrazia e la giustizia sociale, ricordando che la libertà va difesa con impegno.Il periodo della Resistenza e della ricostruzione post-bellica vede emergere figure chiave nella storia italiana, con ruoli militari, politici e intellettuali. Tra i militari si annoverano generali come Harold Alexander e Willis D. Crittenberger, Raffaele Cadorna alla guida del Corpo Volontari della Libertà, Jean-Marie De Lattre de Tassigny, e Rodolfo Graziani dal lato fascista. Sul fronte politico, Pietro Badoglio fu primo ministro, mentre Livio Bianco e Tancredi Galimberti furono fondatori del Partito d’Azione. Figure come Gino Birindelli e Giovanni De Lorenzo ebbero carriere militari e politiche, con quest’ultimo coinvolto in vicende legate ai servizi segreti. Giuseppe Dozza e Fausto Gullo furono fondatori del Partito Comunista d’Italia e sindaci o ministri. Enrico Dugoni rappresentò l’area socialista riformista. Allen Welsh Dulles fu direttore dell’OSS e della CIA. Amintore Fanfani e Arnaldo Forlani emersero nella Democrazia Cristiana. Franco Freda è indicato come politico legato al neofascismo. Antonio Gava fu dirigente democristiano. Agostino Gemelli, inizialmente socialista, divenne una figura religiosa influente. Jerzy Sas Kulczycki promosse gruppi partigiani. Ugo La Malfa fu fondatore del Partito d’Azione. Jean Lippmann organizzò collegamenti tra la Resistenza italiana e francese. Luigi Longo divenne segretario generale del PCI. Enrico Martini fu comandante partigiano. Frank Noel Mason-MacFarlane guidò la commissione di controllo alleata. Enrico Mattei trasformò l’AGIP in ENI. John McCaffery fu capo del SOE britannico. Rodolfo Morandi fu dirigente socialista e presidente del CLNAI. Vincenzo Moscatelli organizzò la Resistenza. Pietro Nenni fu leader socialista. Francesco Saverio Nitti fu presidente del Consiglio. Adolfo Omodeo fu storico e ministro. Giancarlo Pajetta fu dirigente comunista. Alfredo Rocco fu ideatore del “Codice Rocco”. Carlo Rosselli fu figura centrale dell’antifascismo. Bartolomeo Ruini fu ministro e presidente del Senato. Fernando Schiavetti fu direttore de “La Voce repubblicana”. Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, ebbe rapporti ambigui con il fascismo. Pietro Secchia fu dirigente comunista. Antonio Segni fu fondatore della DC. Carlo Sforza fu ministro degli Esteri. Mario Sossi fu un magistrato sequestrato dalle Brigate Rosse. Giuseppe Spataro fu dirigente della DC. Ellery Wheeler Stone fu capo della Commissione alleata di controllo. Paolo Emilio Taviani fu capo della Resistenza e ministro. Josip Broz Tito guidò la Resistenza jugoslava. Palmiro Togliatti fu segretario del PCI. Giovanni Ventura fu condannato per terrorismo. Adone Zoli fu presidente del Consiglio. Queste figure rappresentano un ampio spettro di ideologie e ruoli, evidenziando la complessità del panorama politico e sociale italiano durante un periodo di profonde trasformazioni.Riassunto Lungo
Capitolo 1: La scelta di resistere e il desiderio di ricostruire l’Italia
La lettera di Ferruccio Parri: un atto di opposizione morale
La lettera di Ferruccio Parri al giudice istruttore nel 1927 rappresenta una chiara dichiarazione di opposizione morale al fascismo. Non si tratta di una semplice ribellione personale, ma della rivendicazione di una generazione che, fedele ai valori del Risorgimento e alla lotta per la libertà e la giustizia, non si è piegata al regime. Parri sottolinea come il suo antifascismo sia radicato in un profondo senso morale e in un’adesione a ideali che il fascismo rinnega, mostrando una coerenza incrollabile con i propri principi.Il discorso del 1945: un bilancio della Resistenza partigiana
Il discorso di Parri nel 1945 offre un bilancio della Resistenza partigiana, descrivendola come un movimento spontaneo nato dal desiderio di riscattare l’Italia da una vergogna nazionale. Viene evidenziato il percorso di questa lotta, dalla sua nascita e organizzazione fino al suo svolgimento contro le forze nazifasciste. La narrazione mette in luce la difficoltà ma anche la determinazione delle bande partigiane, sottolineando la crescente unità tra le diverse componenti politiche che animavano il movimento.La lotta partigiana e il suo significato
La Resistenza partigiana è stata un cammino difficile ma fondamentale per la liberazione dell’Italia. La crescente unità tra le diverse componenti politiche ha rafforzato il movimento, permettendogli di affrontare con determinazione le forze nazifasciste. È stata sottolineata l’importanza della collaborazione con gli alleati, nonostante le difficoltà iniziali, e il valore intrinseco della resistenza italiana, che ha ottenuto risultati significativi anche in condizioni sfavorevoli.Parri: uomo coerente e fautore della ricostruzione democratica
In entrambi i testi, emerge la figura di Parri come uomo coerente con i propri ideali, mosso da un profondo senso di responsabilità e dalla ferma convinzione che fosse necessario combattere per un’Italia libera e giusta. La Resistenza viene presentata non solo come una guerra di liberazione, ma come un’opportunità irripetibile per ricostruire l’Italia su solide basi democratiche. Questo processo richiedeva un impegno civico condiviso e una valorizzazione concreta di coloro che avevano partecipato attivamente alla lotta, ponendo le basi per un futuro migliore. Si evidenzia, quindi, la necessità di dare un futuro ai partigiani, integrandoli nelle nuove istituzioni e riconoscendo pienamente il loro prezioso contributo alla rinascita del paese.Se la Resistenza partigiana è stata un movimento spontaneo nato dal desiderio di riscattare l’Italia, come si concilia questo con la crescente unità tra le diverse componenti politiche che, per definizione, implica un’organizzazione e una direzione preesistenti o comunque strutturate?
Il capitolo presenta la Resistenza partigiana come un movimento spontaneo, ma poi evidenzia la sua organizzazione e la crescente unità tra diverse componenti politiche. Questa apparente contraddizione necessita di un chiarimento sul rapporto tra spontaneità iniziale e successiva strutturazione. Per approfondire questo aspetto, sarebbe utile esplorare le dinamiche interne dei movimenti di resistenza, analizzando come la spontaneità iniziale possa evolvere in forme organizzate e quali siano le sfide nel mantenere l’unità tra diverse ideologie. Un autore da considerare per una prospettiva più ampia sulle rivoluzioni e i movimenti di massa è Hannah Arendt.Capitolo 2: Unità nella lotta e caduta di un ideale
L’importanza dell’unità d’azione nella Resistenza
Nel 1944, in un momento cruciale della Resistenza, una lettera evidenzia l’importanza di agire uniti contro il fascismo. Questa lettera risponde ad alcune critiche sul funzionamento del CLNAI, difendendo la necessità di un’organizzazione solida e di decisioni prese insieme. Nonostante ciò, la lettera riconosce le difficoltà pratiche e la scarsa collaborazione di alcuni partiti, in particolare il PCI. Le accuse di accentramento e di nascondere informazioni vengono respinte, sottolineando invece la complessità del lavoro svolto e il desiderio di mantenere un approccio comune.La caduta del governo Parri
Successivamente, si analizza la caduta del governo Parri nel 1945, noto come il “governo della Resistenza”. La sua nascita è stata alimentata dalle speranze del dopoguerra e dalle spinte provenienti dal “vento del Nord”. Tuttavia, la sua breve esistenza è stata segnata da disaccordi interni, sfiducia tra il Nord e il Sud del paese e un contesto politico molto complicato. Parri stesso ha riflettuto sulla sua poca esperienza in politica e sulle difficoltà nel trasformare gli ideali della Resistenza in azioni concrete. Si è scontrato con la politica dei partiti più tradizionali e con una generale mancanza di interesse per la lotta partigiana da parte di alcuni settori della società. Le critiche rivolte al suo governo, incentrate sulla presunta violazione della “continuità dello Stato” da parte dei CLN, sono state interpretate come un attacco alla Resistenza stessa. La fine del governo è vista come un segnale della crisi del Partito d’Azione, dimostrando come gli interessi dei singoli partiti abbiano avuto la meglio sugli ideali di unità.Le conseguenze sulla Resistenza e sull’Italia
L’Italia, pur avendo beneficiato della Resistenza per la creazione della Costituzione, ha rischiato di ritornare a un passato non democratico. La caduta del governo Parri ha segnato un momento delicato, dove le divisioni interne e le strategie politiche dei partiti hanno compromesso la piena realizzazione degli ideali nati dalla lotta di liberazione. Questo evento ha evidenziato le fragilità del sistema politico dell’epoca e le sfide nel costruire un futuro realmente nuovo e democratico.Se l’unità nella lotta era così cruciale per la Resistenza, come è possibile che la caduta del governo Parri, un governo nato da quell’ideale, sia stata interpretata come un attacco alla Resistenza stessa, piuttosto che come una dimostrazione della sua intrinseca fragilità o della prevalenza di interessi di partito?
Il capitolo presenta una narrazione che, pur evidenziando l’importanza dell’unità e le difficoltà incontrate, sembra oscillare tra la celebrazione degli ideali della Resistenza e la constatazione della loro sconfitta a favore degli interessi partitici. Questa dicotomia lascia aperta la questione se la caduta di Parri sia stata un tradimento degli ideali o una loro inevitabile evoluzione in un contesto politico complesso. Per comprendere appieno questa dinamica, sarebbe utile approfondire la teoria dei partiti e le dinamiche di potere nelle fasi di transizione democratica, magari consultando studi sulla storia politica italiana del dopoguerra e analizzando le opere di autori che hanno indagato il ruolo dei partiti nella formazione della Repubblica, come ad esempio studi sulla storia del Partito d’Azione e sulle sue relazioni con gli altri attori politici dell’epoca.Il contesto post-bellico e le sfide della ricostruzione
Il discorso inaugurale del 1945 mette in luce le difficoltà incontrate dal governo nel guidare un paese in fase di ricostruzione, un’Italia ancora segnata dalle conseguenze della guerra e divisa politicamente. Si evidenzia la necessità di azioni concrete per affrontare i problemi economici, come la scarsità di beni essenziali e la disoccupazione. Viene anche sottolineata la difficoltà nel trovare un modo efficace per comunicare con la nazione, un aspetto notato da Alvaro. La mancata “disinfestazione” dalla mentalità fascista e la debolezza intrinseca delle coalizioni di governo emergono come ostacoli significativi.La riflessione sulle speranze della Resistenza a trent’anni di distanza
Il testo del 1974 offre una riflessione sulle speranze della Resistenza, osservate a trent’anni di distanza. Questo confronto mette in risalto l’entusiasmo del periodo post-bellico rispetto alla realtà di un paese ancora diviso e influenzato da un’eredità totalitaria. Si sottolinea come la Resistenza, pur avendo salvato l’onore della nazione, fosse in realtà un movimento di minoranza. La sua eredità è stata poi indebolita da divisioni ideologiche e dalla gestione politica successiva. Viene criticata la tendenza a celebrare le ricorrenze in modo superficiale, trascurando la comprensione profonda dei valori e delle lotte di quel periodo. La Costituzione, nata da quel contesto, è vista come una difesa della libertà, ma si ribadisce l’importanza di non dimenticare i doveri civici.Le sfide nel costruire il futuro dell’Italia
Entrambi i testi evidenziano la complessità nel “progettare” un futuro per l’Italia. Le speranze iniziali si scontrano con le sfide concrete della ricostruzione, della coesione sociale e della memoria storica. La difficoltà nel “trainare” il paese verso un futuro migliore appare come un tema costante, ostacolato da divisioni interne e dalla persistenza di vecchie mentalità.Se la Resistenza è un fondamento morale indiscutibile, come si concilia questa visione con la complessità storica e le “ombre” citate, e in che modo la lotta contro il neofascismo si distingue dalla mera continuità di un’ideologia, piuttosto che da una sua evoluzione o reinterpretazione?
Il capitolo afferma con forza il significato fondativo e morale della Resistenza, definendola un “patrimonio inestimabile” e un “punto di riferimento che non può essere cancellato”. Tuttavia, ammette anche che la storia della Resistenza “non è priva di ombre”. Questa apparente contraddizione solleva interrogativi sulla coerenza dell’argomentazione: se esistono ombre, come possono essere conciliate con un fondamento morale indiscutibile? Inoltre, la transizione alla lotta contro il neofascismo, pur giustificata dalla minaccia, potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita che esplori le sfumature tra la mera riproposizione di vecchie ideologie e possibili evoluzioni o reinterpretazioni delle stesse. Per una comprensione più completa, sarebbe utile approfondire la storiografia della Resistenza, prestando attenzione alle diverse interpretazioni e ai dibattiti critici. Autori come Claudio Pavone e Paul Ginsborg hanno offerto prospettive fondamentali su questi temi. Inoltre, per analizzare la natura del neofascismo e le sue dinamiche, può essere utile consultare studi di scienze politiche e sociologia che indagano i movimenti estremisti e la loro evoluzione nel tempo.Figure Chiave della Storia Italiana del XX Secolo
Militari e Leader della Resistenza
Questo periodo storico ha visto l’azione di importanti figure militari e leader della Resistenza. Tra i militari, si ricordano generali come Harold Alexander, comandante delle forze alleate in Italia, e Willis D. Crittenberger, che ricevette la resa tedesca. Raffaele Cadorna guidò il Corpo Volontari della Libertà, mentre Jean-Marie De Lattre de Tassigny rappresentò la Francia nella resa tedesca. Dalla parte opposta, Rodolfo Graziani fu una figura chiave del fascismo e ministro della Difesa della RSI.Leader Politici e Fondatori di Partiti
Sul fronte politico, Pietro Badoglio fu primo ministro dopo il 25 luglio 1943. Livio Bianco e Tancredi Galimberti furono tra i fondatori del Partito d’Azione e attivi nella Resistenza. Gino Birindelli e Giovanni De Lorenzo ebbero carriere militari e politiche, con quest’ultimo coinvolto in vicende legate ai servizi segreti e a tentativi di colpo di stato. Giuseppe Dozza fu un fondatore del Partito Comunista d’Italia e sindaco di Bologna, mentre Enrico Dugoni rappresentò l’area riformista socialista. Amintore Fanfani e Arnaldo Forlani emersero come figure di spicco della Democrazia Cristiana, ricoprendo incarichi ministeriali e di presidenza del Consiglio. Ugo La Malfa fu tra i fondatori del Partito d’Azione e ministro. Luigi Longo divenne segretario generale del PCI. Pietro Nenni fu un leader socialista e membro del CLNAI. Francesco Saverio Nitti fu presidente del Consiglio e poi deportato dai tedeschi. Adolfo Omodeo fu uno storico e ministro. Giancarlo Pajetta fu un dirigente comunista attivo nella Resistenza. Carlo Rosselli fu una figura centrale dell’antifascismo, fondatore di GL e ucciso dai fascisti. Bartolomeo Ruini fu ministro e presidente del Senato. Fernando Schiavetti fu direttore de “La Voce repubblicana” e poi aderì al PSI. Antonio Segni fu tra i fondatori della DC e più volte ministro. Carlo Sforza fu ministro degli Esteri e poi rientrò in Italia dopo l’esilio. Giuseppe Spataro fu un dirigente della DC. Paolo Emilio Taviani fu un capo della Resistenza e più volte ministro. Palmiro Togliatti fu segretario del PCI e ministro della Giustizia. Adone Zoli fu membro del PPI e presidente del Consiglio.Figure Intellettuali, Religiose e Internazionali
Accanto ai leader politici e militari, altre personalità hanno segnato questo periodo. Allen Welsh Dulles fu direttore dell’OSS e poi della CIA. Franco Freda è indicato come politico e editore legato al neofascismo, riconosciuto colpevole per la strage di Piazza Fontana. Antonio Gava fu un dirigente democristiano con incarichi ministeriali. Agostino Gemelli, inizialmente socialista, divenne un importante religioso e fondatore dell’Università Cattolica, mantenendo una posizione defilata ma di consenso verso il fascismo. Fausto Gullo, fondatore del Partito Comunista d’Italia, fu più volte ministro. Jerzy Sas Kulczycki promosse gruppi partigiani in Veneto e fu decorato alla memoria. Jean Lippmann organizzò collegamenti tra la Resistenza italiana e francese. Enrico Martini fu un comandante partigiano. Frank Noel Mason-MacFarlane fu capo della commissione di controllo alleata. Enrico Mattei, partigiano e imprenditore, trasformò l’AGIP in ENI. John McCaffery fu capo del SOE britannico. Rodolfo Morandi fu un dirigente socialista e presidente del CLNAI. Vincenzo Moscatelli fu un organizzatore della Resistenza e politico. Alfredo Rocco fu un esponente nazionalista e fascista, ideatore del “Codice Rocco”. Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, ebbe rapporti ambigui con il fascismo. Mario Sossi fu un magistrato sequestrato dalle Brigate Rosse. Ellery Wheeler Stone fu capo della Commissione alleata di controllo. Josip Broz Tito fu il leader della Resistenza jugoslava. Giovanni Ventura fu condannato per terrorismo.Un Mosaico di Contributi
Queste figure rappresentano un ampio spettro di ideologie e ruoli, evidenziando la complessità del panorama politico e sociale italiano durante un periodo di profonde trasformazioni.Come si può conciliare la presenza di figure controverse, talvolta con legami ambigui con il fascismo o coinvolte in vicende oscure, all’interno di un capitolo dedicato alle “Figure Chiave della Storia Italiana del XX Secolo”, senza creare una narrazione storicamente distorta o giustificatoria?
Il capitolo presenta un elenco di personalità che hanno attraversato il XX secolo italiano, spaziando da leader politici e militari a intellettuali e figure internazionali, includendo anche personaggi la cui condotta o ideologia è oggetto di dibattito storico e morale. La giustapposizione di figure come Agostino Gemelli e Alfredo Rocco accanto a leader della Resistenza o fondatori di partiti democratici, senza un’adeguata contestualizzazione critica o un’analisi delle loro diverse implicazioni storiche, rischia di appiattire la complessità del periodo e di banalizzare il significato di “figura chiave”. Per affrontare questa lacuna, sarebbe utile approfondire la storiografia specifica su ciascun personaggio, distinguendo nettamente tra chi ha operato per la liberazione e la democrazia e chi ha sostenuto o beneficiato di regimi autoritari o antidemocratici. Si consiglia la lettura di opere che analizzino criticamente il ruolo di figure come Gemelli e Schuster nel contesto del fascismo, e che contestualizzino le azioni di personaggi come Graziani e Rocco all’interno della loro ideologia di appartenenza. Inoltre, un’analisi più approfondita delle fonti primarie e secondarie relative alle azioni e alle dichiarazioni di questi individui permetterebbe di fornire un quadro più completo e sfumato.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]