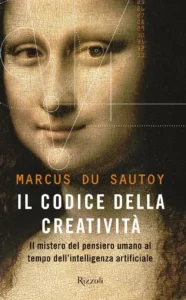1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Come contare fino a infinito” di Marcus Sautoy è un viaggio affascinante attraverso la storia e la natura dei numeri, partendo dalle prime necessità umane di contare, legate all’osservazione dei cicli lunari e alla gestione delle risorse, fino alle complesse teorie matematiche sull’infinito. Il libro ci porta indietro nel tempo, esplorando le ingegnose soluzioni sviluppate da antiche civiltà come Egizi, Maya e Babilonesi per gestire quantità sempre maggiori, introducendo concetti come i sistemi posizionali che ancora oggi influenzano la nostra vita, ad esempio nella misurazione del tempo. Ma il vero cuore del libro è l’esplorazione dell’infinito, un concetto che Sautoy rende sorprendentemente accessibile attraverso l’iconico “Albergo Infinito” di Hilbert. Attraverso questo espediente narrativo, scopriamo che esistono diversi “tipi” di infinito, un’idea rivoluzionaria che ha le sue radici nel lavoro del matematico Georg Cantor. Ci addentriamo nel mistero dei numeri irrazionali come pi greco, scoprendo come la loro natura “infinita e non periodica” abbia sfidato i matematici per secoli, dai pitagorici fino ai giorni nostri, e come questa comprensione sia fondamentale per la matematica moderna e gli algoritmi che usiamo ogni giorno. È una lettura che ti farà guardare ai numeri con occhi completamente diversi.Riassunto Breve
L’evoluzione del conteggio umano è strettamente legata alla necessità di misurare il tempo, con le prime tracce che risalgono al 35000 a.C. con ossa recanti tacche, probabilmente usate per registrare i cicli lunari. L’osso di Ishango, ad esempio, con i suoi raggruppamenti di tacche, suggerisce un interesse per i numeri primi. Le pitture rupestri di Lascaux presentano sequenze di punti che potrebbero indicare fasi lunari o stagioni di caccia. Tuttavia, la semplice registrazione di punti mostrava limiti con numeri elevati, spingendo allo sviluppo di sistemi più avanzati. Gli Egizi usarono simboli per le potenze di dieci, ma questo richiedeva la creazione continua di nuovi segni. Altre civiltà, come i Maya, svilupparono sistemi posizionali, utilizzando punti e linee e basandosi sul numero 20, con posizioni diverse per contare oltre il venti, simile al nostro sistema decimale. I Babilonesi, invece, contavano a gruppi di sessanta, sviluppando simboli fino a 59 e usando colonne per indicare ulteriori gruppi. La nostra preferenza per il sistema decimale deriva probabilmente dal conteggio sulle dita, mentre il sistema babilonese potrebbe essere legato alle proprietà matematiche del numero 60 o a un metodo di conteggio basato sulle ossa delle dita. Nonostante il nostro sistema decimale, l’influenza babilonese è ancora presente nella misurazione del tempo.Il confronto tra insiemi infiniti è reso possibile attraverso l’idea di corrispondenza biunivoca, estesa da George Cantor. Questo principio, paragonabile alle strategie di accoppiamento usate da alcune popolazioni indigene per confrontare quantità, si basa sull’associare un elemento di un insieme a uno di un altro. Se ogni elemento trova un corrispondente e viceversa, i due insiemi hanno la stessa cardinalità. Questo approccio permette di distinguere e confrontare diversi tipi di infinito. L’Albergo Infinito di Hilbert illustra come insiemi infiniti possano avere la stessa grandezza, anche se apparentemente diversi. Ad esempio, l’infinito dei numeri pari ha la stessa grandezza dell’infinito di tutti i numeri interi, poiché ogni numero pari può essere assegnato a una camera corrispondente alla sua metà. Allo stesso modo, anche l’insieme delle frazioni ha la stessa grandezza dell’insieme dei numeri interi, grazie a un metodo di ordinamento a zig-zag. Tuttavia, l’arrivo dei numeri irrazionali, come pi greco o la radice quadrata di 2, presenta una sfida, poiché non è possibile trovare un modo per sistemarli tutti, suggerendo l’esistenza di infiniti di dimensioni diverse.La necessità di misurare il mondo ha portato allo sviluppo della matematica, in particolare per calcolare aree di forme irregolari. Questo ha portato alla scoperta del pi greco ($\pi$), un numero irrazionale la cui stima è presente nel papiro di Rhind. Archimede utilizzò poligoni inscritti e circoscritti per approssimare $\pi$, ottenendo un intervallo ancora oggi utilizzato. La scoperta dei numeri irrazionali è attribuita ai pitagorici, che, studiando il teorema di Pitagora, scoprirono che la radice quadrata di 2 non poteva essere espressa come rapporto di due numeri interi. Questa scoperta minò la loro filosofia e portò alla reazione violenta della setta. Oggi si sa che numeri come $\pi$ e la radice quadrata di 2 sono decimali infiniti non periodici, la cui natura irrazionale impedisce la loro rappresentazione tramite frazione. La matematica moderna ha permesso di calcolare miliardi di cifre di questi numeri, ma la loro essenza rimane legata all’infinito.L’idea che esistano diversi tipi di infinito, alcuni più grandi di altri, è ulteriormente illustrata dall’impossibilità di assegnare una camera a tutti gli ospiti con numeri irrazionali nell’Albergo Infinito. La costruzione di un nuovo numero irrazionale, che differisce da ogni numero presente nella fila, dimostra che l’insieme dei numeri irrazionali è più grande dell’insieme dei numeri interi. I numeri interi rappresentano un infinito “numerabile”, mentre i numeri irrazionali un infinito “non numerabile”, più vasto. Questa scoperta di Cantor rivoluziona la comprensione dell’infinito, dimostrando che non è un concetto monolitico, ma una gerarchia di grandezze. La capacità di manipolare e confrontare questi infiniti ha applicazioni pratiche negli algoritmi moderni.Riassunto Lungo
L’evoluzione del conteggio umano
Le prime tracce del conteggio
L’esigenza di contare è nata migliaia di anni fa, legata alla necessità di misurare il tempo. Le prime testimonianze di questa attività risalgono al 35000 a.C., con ossa recanti tacche, come l’osso di Border Cave, probabilmente utilizzate per registrare i cicli lunari. Un esempio più complesso è l’osso di Ishango (20000 a.C.), con raggruppamenti di tacche che suggeriscono un interesse per i numeri primi. Anche le pitture rupestri di Lascaux (15000 a.C.) presentano sequenze di punti, forse legate alle fasi lunari o alle stagioni di caccia.I limiti dei sistemi semplici e la nascita di nuove idee
Tuttavia, la semplice registrazione di punti o tacche mostrava limiti, specialmente con numeri superiori a cinque, difficili da quantificare a vista. Questo ha spinto diverse culture a sviluppare sistemi di conteggio più avanzati. Gli antichi Egizi utilizzarono simboli specifici per potenze di dieci, ma questo metodo richiedeva l’invenzione continua di nuovi segni per rappresentare quantità sempre maggiori.I sistemi posizionali: Maya e Babilonesi
Altre civiltà, invece, hanno adottato sistemi posizionali, permettendo di contare all’infinito con un numero limitato di simboli. I Maya, circa 2000 anni fa, combinavano punti e linee, utilizzando un sistema basato sul numero 20. Dopo quattro punti, introducevano una linea per rappresentare il cinque, e per contare oltre il venti, utilizzavano posizioni diverse, simili al nostro sistema decimale. Questo sistema posizionale era molto sofisticato e utile per calcoli astronomici. I Babilonesi, invece, contavano a gruppi di sessanta, sviluppando simboli per i numeri fino a 59 e utilizzando nuove colonne per indicare ulteriori gruppi di sessanta.Le ragioni del sistema decimale e l’eredità babilonese
La nostra preferenza per il sistema decimale deriva probabilmente dall’abitudine di contare sulle dita delle mani. Il sistema babilonese, invece, potrebbe essere legato alle proprietà matematiche del numero 60, che possiede molti divisori, o a un metodo di conteggio basato sulle ossa delle dita, utilizzando il pollice per contare le 12 ossa delle altre quattro dita, e le dita dell’altra mano per tenere traccia dei gruppi da 12, raggiungendo così il 60. Nonostante il nostro sistema decimale, l’influenza babilonese è ancora presente nella misurazione del tempo, con 60 secondi in un minuto e 60 minuti in un’ora.È davvero l’abitudine di contare sulle dita la ragione primaria della nostra adozione del sistema decimale, o questa è una semplificazione che ignora le complesse interazioni tra necessità pratiche, sviluppi cognitivi e influenze culturali che hanno plasmato i sistemi di conteggio nel corso dei millenni?
Il capitolo presenta l’origine del sistema decimale come una conseguenza quasi automatica del contare sulle dita, senza esplorare a fondo le ragioni per cui altri sistemi, come quello babilonese, pur avendo vantaggi matematici, non si siano imposti su scala globale. Manca un’analisi più approfondita delle dinamiche di adozione e diffusione dei sistemi di conteggio, e di come fattori sociali, economici e persino religiosi abbiano potuto influenzare la prevalenza di un sistema rispetto a un altro. Per comprendere appieno questo aspetto, potrebbe essere utile approfondire studi sull’antropologia della matematica e sulla storia delle idee, consultando autori come Marcel Mauss per le sue ricerche sull’antropologia del dono e della reciprocità, che potrebbero offrire spunti su come le pratiche sociali influenzino la strutturazione del pensiero e dei sistemi di misurazione. Inoltre, uno studio comparativo dei sistemi di conteggio di diverse culture, come quelli presentati da Georges Ifrah nel suo “Storia universale dei numeri”, potrebbe fornire un contesto più ampio per valutare le ragioni della predominanza del sistema decimale.Capitolo 1: L’Infinito e il Confronto dei Numeri
Un Approccio Matematico all’Infinito
Per comprendere il concetto di infinito e come misurarlo, si parte da un esercizio matematico. Immaginiamo di contare numeri, dimezzando progressivamente il tempo impiegato per ogni intervallo successivo. La somma di questi tempi, che forma una serie geometrica, tende a un valore finito di 16 secondi, anche se questo presuppone una velocità di conteggio che va oltre la realtà.Confrontare Grandezze Infinite con l’Analogia
Per confrontare insiemi infiniti, possiamo ispirarci alle strategie di alcune popolazioni indigene, come gli Angkamuthi australiani. Essi utilizzano un metodo di accoppiamento per stabilire quale gruppo sia più numeroso. Questo consiste nell’associare un elemento di un insieme a uno di un altro, fino a quando uno dei due insiemi non si esaurisce. In questo modo, si può determinare quale insieme contiene più elementi.La Natura e il Confronto di Grandezze
Questa logica di confronto è presente anche nel mondo animale, dove la capacità di valutare gruppi, come branchi di scimmie, è essenziale per la sopravvivenza. Il matematico George Cantor ha applicato questo principio all’infinito, dimostrando che è possibile confrontare diverse grandezze infinite. Il suo metodo si basa sull’idea di stabilire una corrispondenza uno a uno tra gli elementi di due insiemi infiniti. Se ogni elemento di un insieme trova un suo corrispondente nell’altro, e viceversa, allora i due insiemi hanno la stessa cardinalità, cioè la stessa grandezza. Se invece alcuni elementi di un insieme non trovano corrispondenza nell’altro, significa che quell’insieme è più numeroso. Questo approccio ci permette di distinguere e confrontare diversi tipi di infinito.È davvero matematicamente dimostrabile che l’infinito numerico sia “misurabile” attraverso un’analogia con metodi di conteggio primitivi, o si tratta di un’estensione metaforica che rischia di banalizzare la complessità dell’infinito stesso?
Il capitolo presenta un accostamento tra un esercizio matematico che ipotizza una velocità di conteggio irrealistica per dimostrare la convergenza di una serie geometrica, e l’analogia con metodi di confronto di grandezze utilizzati da popolazioni indigene e nel mondo animale. Sebbene l’intento sia quello di rendere comprensibile il concetto di infinito e la sua cardinalità attraverso la corrispondenza uno a uno, manca un’esplicitazione chiara del passaggio logico che giustifichi l’applicabilità diretta di questi metodi intuitivi a concetti matematici astratti come l’infinito potenziale e attuale. Per approfondire la natura rigorosa del confronto tra insiemi infiniti e le potenziali criticità nell’uso di analogie, sarebbe utile consultare le opere di matematici come Georg Cantor stesso, approfondendo il concetto di funzione biunivoca e le sue implicazioni nella teoria degli insiemi. Inoltre, un’analisi delle diverse “dimensioni” dell’infinito, come quelle esplorate da Cantor, potrebbe fornire il contesto mancante per comprendere appieno la portata e i limiti di tali confronti.L’Albergo Infinito: Un Paradosso Matematico
L’Infinito delle Camere
L’idea di un albergo con un numero infinito di camere, pensata da David Hilbert, serve a spiegare il lavoro di Georg Cantor. Questa immagine mostra come insiemi infiniti, anche se sembrano diversi, possano in realtà avere la stessa grandezza.L’Arrivo degli Ospiti Numerati
Quando arrivano ospiti che hanno solo numeri interi positivi (come 1, 2, 3 e così via), il problema è semplice: ogni ospite occupa la camera che porta il suo stesso numero.Gli Ospiti con Numeri Pari
La situazione si fa più interessante quando arrivano ospiti che hanno solo numeri pari (2, 4, 6, ecc.). Anche se sembrerebbe che occupino solo la metà delle camere, il portiere Cantor ha una soluzione. A ogni ospite con un numero pari viene assegnata la camera il cui numero è esattamente la metà del numero sul suo cartellino. Così, l’ospite con il numero 2 va nella camera 1, quello con il 4 nella camera 2, e così via. In questo modo, tutte le camere vengono occupate, dimostrando che l’insieme dei numeri pari ha la stessa grandezza dell’insieme di tutti i numeri interi.La Sfida delle Frazioni
Successivamente, si presenta una folla ancora più numerosa: ospiti con numeri che sono frazioni. Sembra impossibile trovare posto per tutti, dato che ci sono infinite frazioni tra ogni coppia di numeri interi. Tuttavia, Cantor ha trovato un metodo per organizzarli. Immagina di creare file infinite, una per ogni possibile denominatore (come 1/1, 2/1, 3/1 e poi 1/2, 2/2, 3/2, e così via). Per assegnare le camere, Cantor non percorre una singola fila, ma si muove a zig-zag attraverso questa griglia infinita di frazioni. Assegna una camera a ciascuna seguendo un ordine preciso, come ad esempio dare la camera 1 a 1/1, la camera 2 a 2/1, e poi tornare indietro per dare la camera 3 a 1/2. Questo schema diagonale garantisce che ogni singola frazione trovi posto, confermando che anche l’insieme delle frazioni ha la stessa grandezza dell’insieme dei numeri interi.I Numeri Irrazionali: Un Limite all’Infinito
L’arrivo dei numeri irrazionali, come pi greco o la radice quadrata di 2, rappresenta una sfida che non si può superare. Anche se l’albergo ha un numero infinito di camere, non esiste un modo per sistemare tutti gli ospiti con numeri irrazionali. Questo suggerisce che esistono diversi tipi di infinito, alcuni più “grandi” di altri.Ma se l’infinito è intrinseco alla natura dei numeri irrazionali, come può il capitolo affermare che la matematica moderna ha permesso di “calcolare miliardi di cifre” di tali numeri, suggerendo una sorta di “controllo” su un concetto intrinsecamente incontrollabile?
Il capitolo presenta una narrazione che, pur affascinante, potrebbe generare un fraintendimento sulla natura dell’infinito e sulla capacità umana di “misurarlo” o “calcolarlo”. L’affermazione che miliardi di cifre di numeri come $\pi$ siano state calcolate potrebbe far pensare a una sorta di completamento o comprensione totale, quando in realtà si tratta di approssimazioni sempre più precise di un processo infinito. Per affrontare questa apparente contraddizione, sarebbe utile approfondire la filosofia della matematica, in particolare le correnti che si occupano della natura dei numeri e dell’infinito, come il costruttivismo o l’intuizionismo. Autori come Imre Lakatos, con la sua opera “Dimostrazioni e confutazioni”, potrebbero offrire prospettive illuminanti sulla natura delle definizioni matematiche e sui limiti della dimostrazione. Inoltre, una maggiore contestualizzazione storica sul significato del termine “calcolo” in epoche diverse potrebbe chiarire come la nostra comprensione di questo processo si sia evoluta, specialmente in relazione ai numeri irrazionali.Capitolo 3: L’Infinito Numerabile e l’Infinito Non Numerabile
L’Albergo Infinito e l’Arrivo degli Irrazionali
L’idea che esistano diversi tipi di infinito, alcuni più grandi di altri, viene illustrata attraverso un esperimento mentale che coinvolge l’Albergo Infinito. Questo albergo, con un numero infinito di camere, si trova ad affrontare l’arrivo di una comitiva di numeri irrazionali, caratterizzati da espansioni decimali infinite. Nonostante l’operatore turistico sia convinto che l’albergo possa ospitare tutti, il portiere, utilizzando una strategia basata sulla costruzione di un nuovo numero irrazionale, dimostra che è impossibile assegnare una camera a ciascun ospite.La Strategia del Portiere per Dimostrare la Differenza
La strategia del portiere consiste nell’associare a ogni ospite della fila un numero irrazionale e, per ciascun numero, modificare la cifra decimale in una posizione specifica. Ad esempio, se il primo ospite ha come prima cifra decimale 1, il portiere crea un numero il cui primo decimale è 2. Se il secondo ospite ha come seconda cifra decimale 1, il portiere crea un numero il cui secondo decimale è 2. Questo processo genera un numero irrazionale che, per costruzione, differisce da ogni numero presente nella fila. Anche se si tenta di inserire questo nuovo numero nella fila, il portiere può sempre crearne un altro che manca.La Gerarchia degli Infiniti: Numerabile vs. Non Numerabile
Questa dimostrazione evidenzia che l’insieme dei numeri irrazionali è più grande dell’insieme dei numeri interi, anche se entrambi sono infiniti. I numeri interi sono un infinito “numerabile”, nel senso che possono essere messi in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali (1, 2, 3…). I numeri irrazionali, invece, rappresentano un infinito “non numerabile”, più vasto, poiché non è possibile creare una corrispondenza che li includa tutti. Questa scoperta di Cantor rivoluziona la comprensione dell’infinito, dimostrando che non è un concetto monolitico, ma una gerarchia di grandezze.Implicazioni e Applicazioni degli Infiniti
La capacità di manipolare e confrontare questi infiniti ha applicazioni pratiche negli algoritmi moderni, che gestiscono grandi quantità di dati e aiutano a prendere decisioni in vari ambiti della vita quotidiana.Se l’Albergo Infinito può sempre creare un nuovo numero irrazionale per ogni ospite che arriva, non è forse un’argomentazione circolare affermare che l’infinito degli irrazionali sia “più grande” di quello degli interi, quando il metodo stesso di dimostrazione sembra implicare una capacità illimitata di generare nuovi elementi, rendendo ogni confronto di “grandezza” potenzialmente arbitrario?
Il capitolo presenta la dimostrazione di Cantor come un fatto compiuto, senza però contestualizzare a sufficienza il dibattito storico e filosofico che ha circondato queste idee, né le critiche che sono state mosse all’epoca e che ancora oggi animano discussioni sulla natura dell’infinito e sulla validità di tali dimostrazioni. Per comprendere appieno la portata e le eventuali criticità di questa argomentazione, sarebbe utile approfondire gli scritti di Georg Cantor stesso, ma anche le posizioni di matematici e filosofi che hanno messo in discussione il suo lavoro, come ad esempio Leopold Kronecker. Un’ulteriore esplorazione della teoria degli insiemi e delle diverse concezioni dell’infinito, magari attraverso testi di storia della matematica o di filosofia della matematica, potrebbe fornire il contesto necessario per valutare la solidità e le implicazioni di questa distinzione tra infiniti.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]