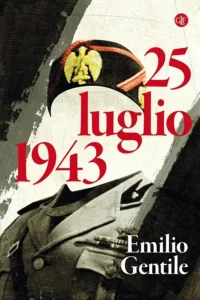Contenuti del libro
Informazioni
“Chi è fascista” di Emilio Gentile è un libro che scava a fondo nella storia per capire davvero cosa significa questa parola, che oggi usiamo un po’ per tutto. L’autore parte dalla tendenza a sminuire il fascismo storico, quella che chiama “defascistizzazione”, negando che fosse un vero regime totalitario fascista con una sua ideologia e un partito milizia forte, riducendolo magari solo a Mussolini e al ventennio fascista come una farsa. Invece, Gentile ci mostra come il fascismo sia stato un fenomeno complesso, nato dallo squadrismo e culminato nel Partito Nazionale Fascista dopo la Marcia su Roma, un regime che voleva creare un uomo nuovo fascista e dominare ogni aspetto della vita. Il libro esplora anche come il termine “fascista” sia diventato una “parola elastica”, usata per insultare chiunque, dai liberali ai socialisti, e come l’antifascismo stesso abbia avuto le sue lotte interne su chi fosse il vero nemico. Arrivando ai giorni nostri, Gentile analizza l’allarme sul ritorno del fascismo, spiegando che i veri pericoli per la democrazia non sono i nostalgici del fascismo storico, ormai tramontato, ma piuttosto chi, pur rispettando le regole elettorali, abbandona gli ideali di libertà e uguaglianza. È un viaggio nella storia italiana e non solo, per capire chi è stato fascista, chi viene chiamato così oggi, e perché l’analisi storica è l’unico modo per non perdersi in definizioni superficiali.Riassunto Breve
Il fascismo storico viene spesso svuotato del suo vero significato, negando che avesse una vera ideologia, uno Stato o una classe dirigente distinti, riducendolo a un fenomeno legato solo a Mussolini o a una farsa. Questa visione ignora la complessità del fascismo come movimento, partito e regime con caratteristiche proprie, non riconducibili solo al Duce o a presunti dissidenti interni. Negare questi aspetti storici rende il termine “fascismo” generico e ne banalizza la comprensione. La parola “fascista” è diventata molto elastica, usata spesso come insulto generico per indicare autoritarismo, nazionalismo o violenza politica, applicata a fenomeni molto diversi tra loro, perdendo il legame con la sua origine storica. Il termine nasce da “fascio” e solo dopo il 1919 Mussolini lo usa per il suo movimento, diffondendosi globalmente dopo la Marcia su Roma e grazie anche all’uso che ne fanno i comunisti per definire le forze reazionarie. Anche dopo il 1945, l’uso si allarga a figure politiche diverse, portando al concetto accademico di “fascismo generico”, che però rischia analogie superficiali. Per capire chi è fascista, serve l’analisi storica. Negli anni del regime, i comunisti definiscono “semifascisti” o “oggettivamente fascisti” altri gruppi antifascisti che non mirano a distruggere il capitalismo, considerato la base del fascismo, arrivando alla teoria del “socialfascismo”. Questa linea dura cambia solo nel 1935 con la direttiva di Stalin per l’unità antifascista, portando alla collaborazione nella Resistenza. La pretesa di definire “fascista” chi non segue Mussolini persiste. La nascita del fascismo storico non è nel 1919 con i Fasci di combattimento, che erano un piccolo gruppo con idee diverse (riforme democratiche, antipartito), ma intorno al 1921-1922, con lo sviluppo dello squadrismo di massa e la trasformazione in Partito Nazionale Fascista, che conquista il potere e instaura la dittatura. Questo fascismo storico è un fenomeno nuovo del Novecento, un partito milizia che distrugge la democrazia per creare uno Stato totalitario e un “uomo nuovo” dedito alla nazione e al duce, con un’ideologia mitica e una spinta imperialista. Il totalitarismo fascista mira al monopolio del potere e a plasmare la società, creando un cittadino collettivo che annulla l’individualità. L’allarme ricorrente su un ritorno del fascismo oggi spesso applica l’etichetta a movimenti e governi che non richiamano il fascismo storico, staccando il fenomeno dalla sua storia specifica. Chi è fascista oggi si definisce erede del fascismo storico, ne segue idee e metodi, o milita in organizzazioni che vi si richiamano, come definito dalla legge italiana. Partiti che in passato esaltavano il fascismo si sono trasformati e integrati nel sistema democratico. I pericoli attuali per la democrazia non vengono da un ritorno del fascismo storico, che è tramontato, ma dalla scissione tra il metodo democratico (elezioni) e l’ideale democratico (uguaglianza e libertà), quando movimenti eletti democraticamente non perseguono questi ideali. L’ideale democratico sancito dalla Costituzione resta un impegno attuale. Il fascismo si definisce attraverso la sua storia, rappresentata da una mappa che include l’organizzazione (movimento di massa, partito milizia, monopolio del potere), la cultura (pensiero mitico, militarizzazione, religione politica, totalitarismo, uomo nuovo, razzismo) e le istituzioni (polizia politica, partito unico, simbiosi regime-Stato, economia corporativa, imperialismo).Riassunto Lungo
1. Il Fascismo Svuotato
Esiste una tendenza a negare le caratteristiche storiche fondamentali del fascismo, un fenomeno che potremmo definire “defascistizzazione del fascismo”. Chi sposa questa visione sostiene che il fascismo non avesse una vera ideologia, né uno Stato fascista autentico, né una classe dirigente realmente fascista, e nemmeno un regime totalitario effettivo. Secondo questa prospettiva, gran parte delle persone coinvolte, dai militanti alle masse e persino ai leader, non sarebbero state sinceramente fasciste, ma solo simulatori o partecipanti passivi. Questa idea riduce l’esperienza del ventennio a una vicenda quasi grottesca o a qualcosa legato solo alla figura di Mussolini. Personaggi importanti come Federzoni, Bottai, Grandi o Balbo vengono visti come oppositori interni, nonostante abbiano avuto ruoli attivi e mostrato fedeltà al regime.La realtà storica del fascismo
Contrariamente a questa visione riduttiva, il fascismo si presenta storicamente come un movimento, un partito e un regime complesso. Possedeva caratteristiche ben precise che lo rendevano un fenomeno politico nuovo e distinto. Anche se Mussolini era una figura centrale e dominante, il fascismo era il risultato di molteplici elementi organizzativi, culturali e istituzionali che andavano oltre la sua persona. La grande quantità di documenti storici disponibili non conferma l’idea che i principali esponenti del regime fossero simulatori o dissidenti nascosti.Le conseguenze di negare la storia
Negare questi elementi storici essenziali finisce per banalizzare il fascismo e svuotarlo del suo vero significato. Questo processo trasforma il termine “fascismo” in un semplice vocabolo generico, perdendo la sua specificità storica. Questa tendenza, iniziata dopo la caduta del regime, continua ancora oggi a influenzare la comprensione storica, favorendo interpretazioni superficiali invece di promuovere un’analisi seria e approfondita della sua vera natura.Ma ridurre ogni dibattito sulla reale portata dell’ideologia e dell’adesione al fascismo a una mera “defascistizzazione” non rischia forse di ignorare la complessità storica e le diverse sfumature dell’esperienza del ventennio?
Il capitolo, nel criticare la visione che sminuisce la natura del fascismo, sembra a sua volta semplificare eccessivamente il dibattito storiografico, presentando l’alternativa come un blocco monolitico di negazione. La realtà storica è spesso più sfaccettata, con gradi diversi di convinzione, opportunismo e coercizione che coesistevano. Per comprendere meglio questa complessità, sarebbe utile approfondire la storia sociale del fascismo e le diverse interpretazioni storiografiche sul consenso e il dissenso. Autori come Renzo De Felice, pur controverso, o Emilio Gentile offrono prospettive fondamentali, ma è cruciale confrontarle con studi che analizzano la vita quotidiana e le dinamiche sociali sotto il regime.2. La Parola Elastica: Chi è Fascista?
La parola “fascista” si sente spesso nelle discussioni di oggi, come se il fenomeno fosse sempre presente. In realtà, l’uso di questo termine è diventato molto flessibile nel tempo. Già nel 1944, un pensatore come Benedetto Croce notava che “fascista” veniva usato come un semplice insulto politico, rivolto a partiti diversi tra loro, come liberali, cattolici e socialisti rivoluzionari. Questa tendenza a usare la parola in modo ampio è continuata e si è rafforzata negli anni.L’uso ampio e spesso negativo del termine
Oggi, il termine “fascismo” si è allargato nel linguaggio politico e accademico per includere persone, movimenti e governi che spesso sono molto differenti l’uno dall’altro. Viene usato in modo dispregiativo come sinonimo di destra, autoritarismo, nazionalismo o razzismo. La parola “fascista” descrive chiunque usi la violenza contro i propri oppositori politici, trattandoli come nemici da eliminare. Questa definizione così vasta porta a considerare “fascisti” anche gruppi terroristici, regimi autoritari di stampo islamico (coniando la categoria di “islamofascismo”), e persino i leader di regimi comunisti come quelli che si trovano in Corea del Nord o in Cina.Le vere origini storiche del termine
Per capire veramente chi si può definire “fascista”, bisogna tornare alle radici storiche della parola. È interessante notare che la parola “fascista” non nasce dal termine “fascismo”, ma deriva dalla parola “fascio”. Nell’Ottocento, “fascio” era usato per indicare associazioni o gruppi, anche di orientamento politico di sinistra. L’aggettivo “fascista” appare per la prima volta nel 1893 e poi di nuovo nel 1915, quando Benito Mussolini lo usò per descrivere i Fasci di azione rivoluzionaria che aveva fondato. Solo nel 1919, Mussolini iniziò a usare il sostantivo “fascismo” per riferirsi specificamente al movimento dei Fasci italiani di combattimento, dando così un nome al suo movimento politico.La diffusione globale del concetto
Il termine “fascismo” si diffuse in tutto il mondo dopo che Mussolini prese il potere in Italia. Eventi come la “marcia su Roma” e la figura stessa del Duce contribuirono enormemente a questa diffusione internazionale. Un ruolo importante lo ebbe anche la leggenda, che Mussolini stesso smentì in seguito, di aver salvato l’Italia dal rischio di una rivoluzione comunista. Anche l’Internazionale comunista contribuì a rendere il termine noto a livello globale, usandolo per definire tutte le forze politiche considerate reazionarie. La Seconda guerra mondiale consolidò ulteriormente l’uso del termine a livello mondiale, legandolo indissolubilmente ai regimi totalitari dell’epoca.“Fascismo generico” e le difficoltà di definizione oggi
Anche dopo il 1945, nonostante la sconfitta militare del fascismo storico, l’uso del termine non diminuì, anzi si estese ulteriormente. Venne applicato a regimi e figure politiche molto diverse in varie parti del mondo, da Perón in Argentina a De Gaulle in Francia, da Nixon negli Stati Uniti a leader contemporanei come Trump o Bolsonaro. Questa enorme estensione del significato ha portato gli studiosi a creare la categoria accademica di “fascismo generico”. Questo concetto teorico serve a catalogare fenomeni politici diversi che presentano alcune caratteristiche comuni, distinguendolo però dal Fascismo storico italiano. L’estrema genericità del termine “fascismo generico” permette di applicarlo a realtà molto differenti tra loro, rendendo estremamente difficile e complessa l’indagine su chi possa essere definito “fascista” nel mondo di oggi. Usare paragoni superficiali, come definire De Gaulle “fascista” nonostante rispettasse i principi fondamentali della democrazia, porta inevitabilmente fuori strada e non aiuta a capire. Per rispondere in modo serio alla domanda “chi è fascista?” è indispensabile un’analisi rigorosa basata sulla storia del fenomeno.Se il capitolo critica l’uso “superficiale” del termine “fascista” per figure contemporanee, quali criteri concreti derivati dalla “analisi rigorosa basata sulla storia” dovrebbero essere applicati per giudicarle?
Il capitolo evidenzia correttamente come il termine “fascista” sia diventato una “parola elastica”, usata spesso in modo generico e dispregiativo, e sottolinea l’importanza di un’analisi storica rigorosa per comprenderne il vero significato. Tuttavia, dopo aver criticato l’applicazione del termine a figure politiche contemporanee come Perón, De Gaulle, Nixon, Trump o Bolsonaro, il capitolo non fornisce gli strumenti analitici specifici – derivati proprio da quella storia – che permettano di distinguere un uso corretto da uno scorretto nel contesto attuale. Per affrontare seriamente la questione di chi possa essere definito “fascista” oggi, è indispensabile non fermarsi alla sola origine storica, ma approfondire la comparazione tra il Fascismo storico e altri regimi autoritari o movimenti politici, studiando le diverse teorie sul “fascismo generico” e i metodi per identificare caratteristiche comuni (ideologia, struttura del partito, rapporto con lo stato, uso della violenza, culto del capo, ecc.) che possano, o meno, giustificare l’uso del termine in contesti diversi. Approfondire autori che si sono dedicati alla storia del fascismo e alla sua comparazione, come Emilio Gentile, Robert Paxton, Roger Griffin, Stanley Payne, o Zeev Sternhell, può fornire le chiavi di lettura necessarie.3. Definizioni in lotta: chi è fascista?
Negli anni del regime fascista, il termine “fascista” veniva spesso usato in modo molto ampio, specialmente dai comunisti, per descrivere anche altri gruppi che si opponevano al regime. Questo modo di usare la parola portò a considerare l’esistenza di un “fascista camuffato” o addirittura “oggettivo”, indicando persone o gruppi che, pur non seguendo Mussolini apertamente, venivano visti come funzionali al mantenimento del sistema fascista.L’accusa di “socialfascismo”
Dopo la crisi politica del 1924, seguita all’omicidio Matteotti, i comunisti iniziarono a definire “semifascisti” i partiti di opposizione che avevano partecipato alla protesta parlamentare dell’Aventino. Questa etichetta fu data a figure come il liberale Amendola, il popolare Sturzo e il socialista Turati. La critica principale verso questi gruppi era la convinzione che non volessero davvero eliminare il capitalismo, che i comunisti consideravano la vera base su cui si fondava il fascismo. Questa idea si rafforzò e divenne la teoria del “socialfascismo”, adottata dall’organizzazione comunista internazionale nel 1929, che arrivò a considerare i partiti socialisti e socialdemocratici come una parte del fascismo stesso.I comunisti e l’antifascismo “oggettivo”
I comunisti credevano di essere gli unici veri antifascisti perché, analizzando la società dal punto di vista delle classi sociali, vedevano la borghesia e il capitalismo come l’essenza stessa del fascismo. Per questo motivo, chiunque si opponesse al fascismo ma non lottasse per distruggere il capitalismo e la borghesia veniva considerato, in modo “oggettivo”, un complice del regime. Anche figure importanti come Carlo Rosselli e il movimento Giustizia e Libertà furono attaccate e definite “oggettivamente” vicine al fascismo. Questo accadeva a causa di alcune loro idee, come il richiamo ai valori del Risorgimento italiano o la critica alle teorie di Marx. Nonostante alcuni all’interno del Partito Comunista, come Tasca e Terracini, non fossero d’accordo, questa linea molto rigida prevalse fino al 1934.Il cambio di strategia e l’unità
A partire dal 1935, una nuova indicazione arrivata da Stalin impose un cambiamento radicale nella strategia comunista: bisognava cercare l’unità d’azione con tutti i gruppi antifascisti. Il Partito Comunista Italiano adottò quindi un nuovo approccio, proponendo di collaborare e persino di agire all’interno delle grandi organizzazioni di massa create dal fascismo. Fu lanciato un famoso “appello ai fratelli in camicia nera” e il partito iniziò a richiamarsi al programma del fascismo del 1919 e alla tradizione del Risorgimento. Questa svolta inattesa causò critiche e dubbi negli altri antifascisti, come Nenni e Rosselli, che la videro come una strategia confusa o un tentativo destinato a fallire di cambiare il fascismo dall’interno.L’unità nella Resistenza e oltre
Nonostante le forti divisioni e le polemiche del passato, l’unità tra i diversi gruppi antifascisti che si formò a partire dal 1935 divenne il fondamento per la Resistenza, il movimento di lotta armata contro il nazifascismo iniziato dopo il 1943. Durante la guerra civile che ne seguì, l’espressione “antifascisti fascisti” non fu più usata. Tuttavia, la tendenza a voler stabilire chi fosse veramente “fascista” al di là dei seguaci dichiarati di Mussolini continuò a esistere anche dopo la fine del regime.Se il fascismo storico “non tornerà”, come possiamo essere certi che le sue derive autoritarie e illiberali non si manifestino in forme nuove, magari proprio all’interno di quei “democratici” che rinunciano all’ideale di libertà e uguaglianza?
Il capitolo traccia una distinzione netta tra il fascismo storico, considerato un fenomeno del passato, e i pericoli attuali per la democrazia, individuati nell’abbandono dell’ideale democratico da parte di forze politiche elette. Questa distinzione, sebbene utile per evitare allarmi ingiustificati, rischia di sottovalutare la possibilità che elementi, metodi o linguaggi propri del fascismo storico possano riemergere in contesti politici contemporanei che non si definiscono esplicitamente fascisti, ma che mostrano tendenze illiberali o autoritarie. Per approfondire questa complessa interazione tra passato e presente, e per capire se e come certe caratteristiche del fascismo possano persistere o trasformarsi, è utile esplorare gli studi sulla natura del fascismo e sulle sue manifestazioni contemporanee. Discipline come la scienza politica comparata e la storia delle ideologie possono offrire strumenti critici. Tra gli autori da considerare per una riflessione su queste tematiche si possono citare Umberto Eco, per la sua analisi delle caratteristiche persistenti del “fascismo eterno”, e Jason Stanley, che indaga le tattiche del fascismo nella politica contemporanea.7. La Mappa del Fenomeno Fascista
Il fascismo è un fenomeno che si comprende guardando alla sua storia. Questa storia rivela aspetti unici per il ventesimo secolo. Per capirlo meglio, possiamo usare una mappa che mostra i suoi aspetti principali, divisi in tre aree fondamentali: l’organizzazione, la cultura e le istituzioni.Come era organizzato il movimento
Sul piano organizzativo, il fascismo si presenta come un vasto movimento che coinvolge persone di tutte le classi sociali ed era guidato in particolare dai giovani della classe media. Era organizzato come un ‘partito milizia’, unito da un forte senso di cameratismo e dalla convinzione di dover rinnovare la nazione. Questo movimento si sentiva in costante lotta contro i suoi oppositori. Per ottenere il controllo totale, usava metodi violenti come il terrore, ma anche strategie politiche e accordi. L’obiettivo finale era distruggere il sistema democratico esistente e costruire un nuovo tipo di regime.
La cultura fascista
La cultura fascista si basava su idee forti e spesso non razionali, come il ‘pensiero mitico’. Promuoveva una visione della vita molto attiva e dinamica e metteva al centro il mito della giovinezza. La politica stessa era vista come una lotta, quasi militare. La sua ideologia era flessibile e si opponeva a molte correnti di pensiero dell’epoca:
- Materialismo
- Individualismo
- Liberalismo
- Democrazia
- Marxismo
- Populismo
- Anticapitalismo (con tendenze)
Il fascismo creò un nuovo stile politico, usando miti, riti e simboli che ricordavano una religione, per coinvolgere le masse e formare un ‘uomo nuovo’. Aveva una visione totale della politica, che voleva unire l’individuo e la massa in un’unica nazione. Questa nazione era vista come una comunità basata sull’etnia e su valori morali condivisi. Chi era considerato un nemico o inferiore veniva perseguitato. Secondo l’etica fascista, il cittadino doveva essere completamente sottomesso allo Stato. Si esaltavano la disciplina, la forza (virilità) e lo spirito combattivo.
Le istituzioni del regime
A livello istituzionale, il regime si basava su un forte apparato di polizia. Questo apparato controllava e reprimeva ogni forma di dissenso usando il terrore. C’era un unico partito politico, dotato di una sua milizia, che aveva il compito di difendere il regime. Questo partito selezionava i futuri capi e organizzava la popolazione in una costante mobilitazione. Il partito si impegnava a portare avanti una sorta di ‘rivoluzione continua’. Il sistema politico funzionava grazie a una stretta unione tra il regime e lo Stato esistente. Al vertice di questa struttura c’era un ‘capo’ carismatico che guidava tutto. L’economia era organizzata in modo ‘corporativo’, eliminando la libertà dei sindacati. Lo Stato aumentava il suo controllo sui settori produttivi. Questo controllo serviva a indirizzare l’economia verso gli obiettivi di potenza del regime. Tuttavia, la proprietà privata e le classi sociali venivano mantenute. La politica estera mirava a ottenere maggiore potenza e grandezza per la nazione, con chiare ambizioni imperialiste.
Se il capitolo descrive un fascismo ideologicamente ‘flessibile’ e capace di opporsi a una lista così eterogenea di correnti, come si spiega la sua presunta coerenza interna e la capacità di costruire un ‘uomo nuovo’ e un regime ‘totale’?
Il capitolo, nel descrivere la cultura fascista, evidenzia una presunta ‘flessibilità’ ideologica e una vasta gamma di opposizioni a correnti di pensiero diversissime. Questo solleva un interrogativo fondamentale sulla reale coerenza interna del fascismo e sulla sua capacità di proporsi come un sistema ‘totale’ in grado di plasmare un ‘uomo nuovo’. Se l’ideologia era così adattabile e reattiva, su quali basi solide poggiava la sua pretesa di unificazione e controllo totale della società? Per approfondire questa apparente contraddizione tra flessibilità ideologica e pretesa di totalità, sarebbe utile esplorare le diverse interpretazioni storiografiche sul fascismo. Approfondire gli studi di autori come Emilio Gentile, che ha analizzato la dimensione culturale e sacrale del regime, o Renzo De Felice, con le sue complesse e dibattute tesi, può aiutare a comprendere meglio la natura del pensiero fascista e il suo rapporto con la pratica politica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]